Orgoglio, resistenza, sovversione
Per una critica dell'eterosessualità
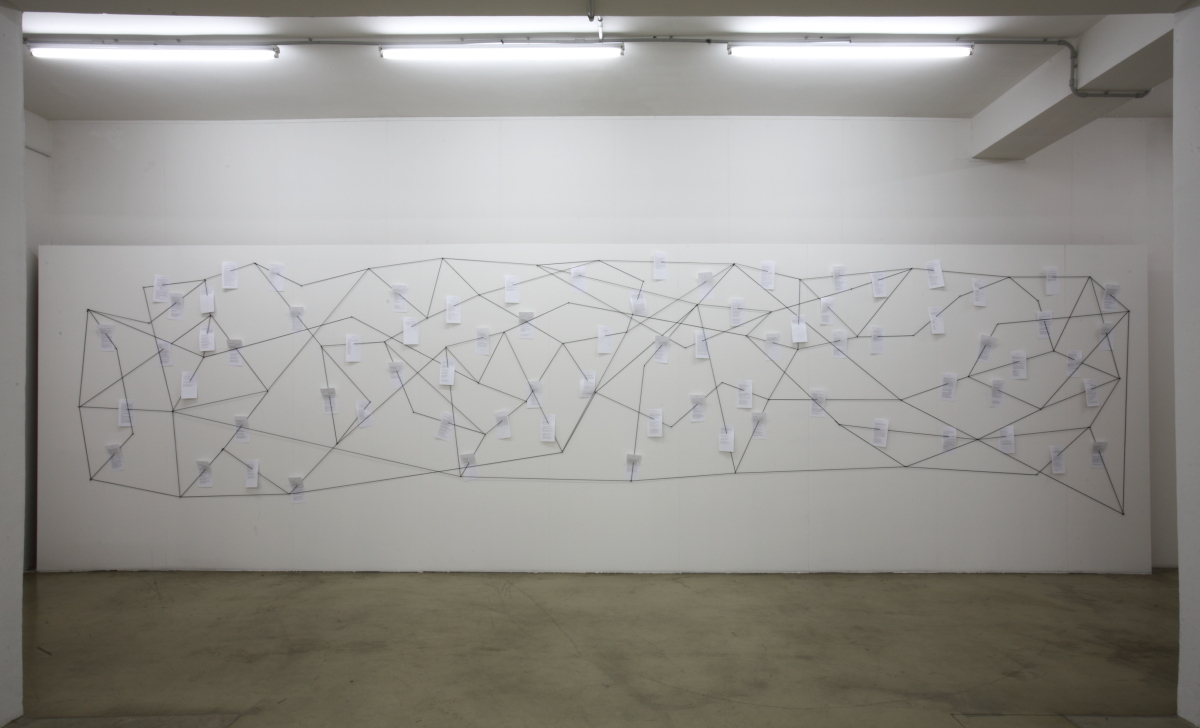
Questo testo è stato letto in occasione del Palermo Pride 2017 al Teatro Montevergini – Palermo, 30 giugno 2017.
Man mano che diventano più popolari, istituzionalizzati e partecipati, i Pride divengono anche sempre più contestati dalle minoranze più critiche e politicizzate del movimento. E ciò accade per molte ottime ragioni, che tengo particolarmente a esplicitare, trovandomi io stesso a far parte di quelle minoranze, o almeno spero di essere da loro riconosciuto come tale. I motivi della contestazione, mi sembra, attengono a tre ordini di motivi. Il primo è che i Pride sembrano ormai troppo normali, troppo pacificati, troppo ripuliti, troppo maschili, troppo bianchi, troppo cisgender, troppo abili, troppo impegnati a garantirsi il consenso degli eterosessuali, e dunque, di conseguenza, troppo impegnati ad anteporre questa garanzia di consenso alla memoria e al progetto sovversivo dei corpi trans, non bianchi e poveri di Sylvia Rivera, di Marsha P. Johnson, di Miss Major e delle altre donne trans, drag, froce passive e checche impresentabili che a Stonewall lanciarono scarpe col tacco e bottiglie di birra contro la polizia, nonché contro la violenza e la diseguaglianza ratificata o istituita dallo stato, nella notte del 28 giugno del 1969. Il secondo motivo è che i Pride si trovano a essere oggettivamente vampirizzati da parte degli stati (ivi incluse le istituzioni dello stato, come la polizia) che spesso si servono strumentalmente delle minoranze di genere e sessuali come masse di manovra per il consenso, nonché da parte del capitalismo, che nelle minoranze di genere e sessuali vede potenziali acquirenti o risorse da sfruttare. Ed è forse probabile che questa apparente cecità di fronte alla vampirizzazione capitalista dei Pride, che spesso viene anzi salutata con entusiasmo ogni qual volta una multinazionale dell’acqua o dell’abbigliamento sportivo immetta nel mercato un prodotto rainbow creato ad hoc, abbia contribuito a quella che viene percepita – e questo è il terzo motivo della contestazione – come l’idea di un definitivo accantonamento, da parte delle ali maggioritarie del movimento, ossia di quelle che detengono risorse relativamente maggiori, di ogni interesse, e forse anche di ogni coscienza politica, per le condizioni “materiali” di vita delle minoranze di genere e sessuali, ossia del nesso che sussiste tra l’abiezione “culturale” e le sue consistenti premesse, e conseguenze, “materiali”.
In altre parole – questa è la conclusione che traggo –, sembra che il discredito che permea i Pride, proveniente dagli strati minoritari del movimento, riguardi il fatto di essere troppo sintonici a ciò che la società eterosessuale, gli stati e il capitalismo desiderino che i Pride siano, e che, di conseguenza, ogni rivendicazione di orgoglio che i Pride pongono in essere si trovi a essere 1) compatibile con il capitalismo, 2) in linea con i programmi di governo, 3) particolarmente attenta, infine, a non intaccare il privilegio eterosessuale, e in particolare quello maschile, nonché a sovvertire l’eterosessualità come matrice culturale di produzione delle soggettività, maggioritarie e minoritarie, in modi che sono invariabilmente indistinguibili dalle diseguaglianze, culturali e materiali. Ciò che i Pride sembrano orientati a guadagnarsi è dunque il riconoscimento da parte di chi detiene l’autorità formale, o, per meglio dire, da parte di chi esercita il potere di stabilire chi e cosa può ambire alla riconoscibilità – come fanno anche coloro che salutano con slancio e gioia il riconoscimento da parte dello stato delle unioni civili senza curarsi del fatto che questo riconoscimento, lungi dall’istituire l’eguaglianza, istituisca ulteriori gerarchie, ampliando dunque la regione dell’inciviltà, dell’indecoroso, e dell’irriconoscibile. Tali posizioni, che definiamo omonormative e omonazionaliste, giurano eterna fedeltà ed eterno amore alla società, alla nazione e al capitalismo eterosessuali, in cambio di una piccola società gay, di una nazione che si tinge occasionalmente rainbow e di un po’ di pinkwashing da parte del capitale. Ma tutto ciò non ha nulla a che fare con l’eguaglianza: l’eguaglianza, infatti, si consegue mediante la sovversione di ciò che, nel caso delle minoranze di genere e sessuali, le produce come diseguali.
Le critiche che provengono dagli strati minoritari del “movimento” sono irrinunciabili, ed è molto importante che possano trovare spazio nell’ambito di un Pride come quello di Palermo – che si caratterizza, mi sembra, per una certa pluralità organizzativa –, così come è importante ricordare che a Bologna parteciperanno alla parata alcune minoranze dissidenti che non hanno preso parte all’organizzazione dell’evento, come il Laboratorio Smaschieramenti, la Consultoria Transfemminista Queer, Atlantide e il Movimento Identità Trans (MIT). Ciò che penso, infatti, è che ci sono molte persone che prendono parte ai Pride pur condividendo precisamente questi contenuti critici, e che costituiscono dunque una minoranza sottorappresentata da chi, all’interno del “movimento”, è impegnato a far passare la lotta per il riconoscimento del matrimonio egualitario o del diritto ad avere un figlio attraverso la gestazione per altri come fossero le uniche ragioni di vita dell’intero movimento, e dunque anche della nostra vita.
A scanso di equivoci: è molto importante contrastare, per ragioni indipendenti, le argomentazioni omofobiche, non solo clericali, fasciste o razziste, contro il matrimonio egualitario, o contro la gestazione per altri. Ciò che intendo anche dire, tuttavia, è che intercettare le minoranze interne al movimento Lgbt mainstream, ma non adeguatamente rappresentate1 dal movimento Lgbt mainstream potrebbe essere importante non solo perché magari queste minoranze hanno timore di manifestare apertamente le proprie preoccupazioni, o non si sentono sufficientemente legittimate a farlo, ma anche e soprattutto per ampliare il bacino delle posizioni controegemoniche finalizzate al contrasto del lavoro di egemonia operato dagli strati maggioritari del movimento, che ovviamente tende a selezionare con cura quali argomenti e quali rivendicazioni debbano riguardarci, o quali debbano essere le modalità della lotta. “Perché”, si sono chieste ad esempio Alessia Acquistapace, Elisa A.G. Arfini, Barbara de Vivo, Antonia Anna Ferrante e Goffredo Polizzi, “perché non risolvere il problema della discriminazione delle coppie dello stesso sesso abolendo il matrimonio eterosessuale, anziché legittimando quello omosessuale?”2. La selezione di argomenti e priorità operata dalle ali maggioritarie del “movimento” si fonda non solo sulla marginalizzazione, e spesso la denigrazione, delle posizioni più queer relativamente a questioni quali l’organizzazione sociale della sessualità, della solidarietà e della parentela; essa si fonda anche sull’invisibilizzazione delle questioni connesse alla sopravvivenza materiale di chi, trovandosi per un motivo o per l’altro a disattendere l’imperativo di inseguire disperatamente una normalità di seconda mano come premio di consolazione per le identità abiette, versa in una condizione di invivibilità.
Al contempo, la mia idea è che non sia più nemmeno sufficiente appellarsi al queer, come se tale parola avesse delle proprietà taumaturgiche, o immediatamente controegemoniche, per il semplice fatto di porsi come genericamente “anti-identitario”, o contro una generica “normalità”. Nel momento in cui il queer si istituzionalizza, l’anti-identitarismo diventa semplicemente un modo per non mettere in discussione le gerarchie che sussistono tra le identità privilegiate e abiette, ma anzi quasi per occultarle attivamente dietro al fatto che se non si sente, individualmente, di occupare una posizione di privilegio, o se non si vuole riconoscere di occupare una posizione di privilegio, allora si detiene il potere assoluto e dispotico di stabilire da sé se si sia o meno dei privilegiati. Tale posizione – tra le innumerevoli altre sciagure che reca con sé – finisce paradossalmente per far rientrare l’identitarismo dalla finestra, in quanto aggira e squalifica proprio uno degli assunti teorici del queer, di recente ribadito da Judith Butler in questi termini:
in quanto corpo, io non sono soltanto per me stessa, e nemmeno principalmente per me stessa; io piuttosto, trovo me stessa, se mai dovessi riuscirci, in quanto costituita e spossessata dalla prospettiva di altri. Al fine dell’azione politica, pertanto, io appaio agli altri in modi che non posso conoscere, e il mio corpo viene esso stesso istituito da prospettive che non posso abitare ma che senz’altro, mi abitano. Questo è un punto importante, perché non è solo il mio corpo a stabilire quale sia la mia prospettiva3.
Quando il queer diventa sinonimo di whatever, “la qualunque”, quando il queer diventa una variante minoritaria dell’individualismo sovrano e proprietario, in quei casi esso occulta il fatto che nessuna soggettività, nessuna pluralità imprevedibile, mutevole e infinita, nessun whatever è egualmente e materialmente possibile, e vivibile. Non, almeno, in assenza della sovversione della matrice eterosessuale di produzione delle differenze di genere e sessuali in modi che sono indisgiungibili dalle diseguaglianze di genere e sessuali; tutte cose che, però, il queer istituzionalizzato si guarda bene dal dire. D’altronde, tali diseguaglianze diventano intelligibili e operative anche e attraverso le modalità operative delle istituzioni, e dunque anche attraverso le modalità operative dell’università. E dunque c’è da chiedersi cosa resti di un pensiero sovversivo nel momento in cui l’unica forma sociale che assume è l’accomodamento nelle logiche escludenti dell’istituzionalizzazione accademica. Il nulla, forse – o, se preferite, whatever.
A fronte, dunque, della convergenza tra movimenti Lgbt mainstream e forme istituzionalizzate del queer accademico nella connivenza con le matrici di produzione delle diseguaglianze di genere e sessuali, e dunque, in senso più ampio, con le gerarchie sociali, stabilire un’alleanza tra le minoranze del movimento mainstream sottorappresentate e le minoranze queer anti-identitarie extra-istituzionali ed extra-accademiche diventa cruciale. La mia idea, infatti, è che non si tratti più solo di criticare, contestare, e rifiutare il riconoscimento concesso dall’autorità – tratti, questi, che hanno storicamente contrapposto la critica e l’attivismo queer alla politica Lgbt identitaria. Ciò che si tratta di pensare, ora, è la sovversione del nesso ricattatorio e violento che sussiste tra il riconoscimento condizionalmente concesso, o negato, dall’autorità e l’obbligo di conformarsi ai criteri che presiedono a questa riconoscibilità per ambire a vivere una vita che conta. È questo, per come lo intendo, il passo successivo alla critica, alla contestazione, e al rifiuto delle norme che presiedono al riconoscimento. Ciò che occorre rifiutare, in altre parole, non è, o non è più, il riconoscimento in sé, bensì che l’alternativa al rifiuto del riconoscimento sia l’indigenza, la morte sociale, o la morte effettiva. E c’è una differenza tra queste due cose.
Questa differenza consiste nel fatto che noi dobbiamo poter vivere, dobbiamo poter vivere bene, dobbiamo vivere una vita che conta, al di là e a prescindere dal fatto che ci adeguiamo, o meno, ai criteri che dovrebbero misurare il grado della nostra riconoscibilità – al di là del fatto che siamo ritenute “degne”, o meno, di benedizione. Lo svilimento della benedizione da parte dell’autorità, infatti, non si compie attraverso il mero rifiuto, bensì attraverso una lotta finalizzata a deprivarla del suo potere di stabilire chi può vivere, e vivere bene. Il ricatto, ovviamente, consiste nel fatto che la dignità di buona vita dipende strettamente dalla benedizione da parte dell’autorità, dal momento che è l’autorità a detenere il monopolio delle risorse, degli spazi, delle forme di supporto, delle risorse finanziarie, nonché a stabilire “chi” e “come” possa fruirne. La soluzione, tuttavia, non consiste nell’accettazione di questo ricatto, quasi fosse naturale o necessario vivere sotto ricatto, bensì nella sovversione del nesso che sussiste tra il riconoscimento simbolico e il supporto materiale: in assenza di questo sforzo, infatti, rischiamo di essere noi per prime a normalizzare il fatto che essere “riconoscibili” costituisca il ragionevole, e responsabile, prezzo da pagare non solo per un’inclusione condizionale, e dunque aleatoria, ricattatoria e sempre suscettibile di revoca, ma proprio per la possibilità di sopravvivere, e prosperare – come tutt’oggi, invariabilmente, accade. Questa sovversione impone dunque di radicalizzare, e di ampliare, il conflitto con chi detiene l’autorità formale, o con chi ad essa si conforma. E i motivi per cui ciò deve essere fatto, dalla mia prospettiva, sono due. Il primo è perché il privilegio dipende sempre dall’abiezione di qualcun altro – la relazione tra il privilegio e l’abiezione è una relazione di tipo sacrificale: la mia sicurezza dipende dalla tua vulnerabilità, il mio privilegio dipende dalla tua abiezione. Il secondo è perché se noi dismettiamo il conflitto corriamo il rischio di far credere che siamo tutto sommato contente di essere sfruttate, di essere indigenti, o di morire.
L’idea che vorrei condividere con voi è che così come sussiste un nesso tra l’essere soggetti riconosciuti, o riconoscibili, sul piano culturale e l’essere soggetti degni di supporto materiale, allo stesso modo sussiste anche un nesso tra l’assenza di riconoscimento, o il riconoscimento condizionale, delle minoranze di genere e sessuali, e la loro situazione economica e materiale. Idea, questa, che richiede tuttavia alcune precisazioni. Ad esempio, non sto dicendo che tutte le persone sussumibili sotto la definizione “minoranze di genere e sessuali” versano in situazioni di svantaggio materiale ed economico: sappiamo perfettamente che non è così. Allo stesso tempo, non sto nemmeno dicendo che chiunque versi in condizioni di svantaggio materiale ed economico sia per motivi riconducibili alla sua subalternità di genere o sessuale, ma magari a un’altra, o a un intreccio di altre – la razza, l’abilità o “conformità” psicofisica, per citarne alcune. Ciò che sto dicendo, piuttosto, è che la subalternità economica e materiale – la povertà, la precarietà, l’impossibilità di scegliere tra alternative egualmente percorribili e vivibili, e dunque l’assenza di potere nel determinare, per quanto possibile, le condizioni della propria esistenza –, la subalternità, dicevo, non è mai un fenomeno “naturale” né tantomeno da ricondurre alla sfortuna o al caso, ai meriti o ai demeriti individuali, benché esattamente attorno alla sfortuna o al caso, ai meriti e ai demeriti individuali facciano leva gli ordini discorsivi finalizzati a giustificarla e normalizzarla. Vorrei qui far notare che è proprio attorno a tali ordini discorsivi che convergono sia i sostenitori del neoliberismo (tra cui tutti i governi delle democrazie liberali contemporanee), sia la Chiesa cattolica, che sulla naturalità o fatalità della subalternità economica e materiale ha costruito la sua storica egemonia, di cui le minoranze di genere e sessuali, guarda caso, sono state e sono tuttora tra le principali vittime – e con questo intendo suggerire un modo nuovo, per noi, di contestare la concezione clericale della “naturalità”.
Se, dunque, la subalternità economica non è un fenomeno naturale, esattamente come quella che in quanto minoranze di genere e sessuali già esperiamo coscientemente sul piano del misconoscimento simbolico e culturale, essa è il prodotto di una specifica organizzazione sociale delle modalità di soggettivazione secondo linee di privilegio, di abiezione o di sacrificabilità, nonché, ovviamente, il prodotto delle relazioni sociali e dei rapporti di forza che li innervano. La mia idea, di conseguenza, è che ciò che in quanto minoranze di genere e sessuali dovremmo includere nelle nostre rivendicazioni, è che esattamente come la subalternità razziale, di classe o determinata dall’abilità psicofisica, anche quella di genere e sessuale dovrebbe confluire nella de-naturalizzazione della povertà e della subalternità economica e materiale.
Chiaramente, ammesso che si sia disposti a ritenere valida questa suggestione, si potrebbe facilmente obiettare: che differenza c’è se la subalternità economica è dettata dalla razza, dall’abilità psicofisica, dal genere o dalla sessualità? La povertà è sempre povertà: quali che possano essere le sue cause, i suoi effetti sono sempre gli stessi – e ciò potrebbe essere vero. Ciò che questa obiezione sottovaluta, tuttavia, è che dal momento che la povertà e la subalternità economica e materiale non sono fenomeni naturali, come ho detto, bensì il frutto del modo in cui sono organizzate le relazioni sociali, e dei modi in cui, all’interno di tali relazioni, si perviene a occupare una posizione di privilegio o di abiezione, allora diventa cruciale de-naturalizzare non solo le matrici culturali che governano queste relazioni sociali, ma anche i “fenomeni sociali che esprimono la nostra oppressione”, perché è proprio la naturalizzazione a rendere “impossibile qualunque forma di cambiamento”, per dirla con le parole di Monique Wittig4. In altre parole: se, a differenza di ciò che sostengono i neoliberisti e la Chiesa cattolica, concordiamo attorno al fatto che la subalternità materiale, proprio perché non è un fenomeno naturale, è “sovvertibile”, è molto importante avere ben chiari quali sono sia i fattori culturali che la determinano, sia le forme sociali attraverso le quali diventa intelligibile, proprio per sovvertirla. Questi fattori, infatti, costituiscono il fenomeno stesso, sono pezzi di funzionamento del fenomeno, e dunque concorrono non solo a una sua critica più avveduta, ma costituiscono anche, precisamente, ciò che deve essere sovvertito affinché una sovversione del fenomeno “generico” della subalternità materiale possa essere non solo più mirata, ma innanzitutto desiderabile. Ciò che intendo dire, in altre parole, è che la sovversione delle matrici culturali che confluiscono nella determinazione della subalternità materiale è il prerequisito per la sua sovversione, e per l’instaurazione di un ordine fondato sull’eguaglianza sostanziale e sulla giustizia.
Dai teorici del “comune”, ai marxisti, ai post-operaisti, ai sostenitori del reddito incondizionato, alle tante soggettività che, come in questo teatro, e in molte altre esperienze, sperimentano il “comune” – chiunque, a sinistra, si spenda teoricamente e praticamente per un’aspirazione di eguaglianza sostanziale e di giustizia deve essere messo di fronte a questa domanda: che tipo di promessa di eguaglianza o di giustizia può costituire, agli occhi delle minoranze di genere e sessuali, l’ipotesi di rovesciamento dell’attuale ordine sociale ed economico, con tutte le sue inaccettabili e naturalizzate diseguaglianze e ingiustizie, in assenza di una sovversione esplicita delle modalità di produzione, riproduzione e organizzazione sociale delle relazioni che producono le differenze di genere e sessuali in modi che sono indistinguibili dalle diseguaglianze? Che tipo di eguaglianza sostanziale e di giustizia dovremmo immaginare se le loro basi culturali sono le differenze di genere e sessuali che puntualmente si trasformano nelle forme sociali dell’abiezione e della diseguaglianza materiale? Indirettamente, questa domanda diventa un modo per rispondere a quanti, ancora oggi, ci fanno lezioni a proposito del fatto che la lotta contro le oppressioni di genere e sessuali sarebbe perseguibile solo nell’alveo della lotta anticapitalista, o comunista, intesa come sfondo necessario di ogni lotta politica, e dunque anche della nostra lotta politica. Proporrei qui di ricordarci, invece, che l’economia etero-patriarcale precede il capitalismo, e ad esso offre le necessarie risorse culturali e materiali per affermarsi e riprodursi: si leggano le analisi femministe materialiste di Christine Delphy5, per fare un nome. Ma si leggano anche le analisi gay materialiste di Mario Mieli, per farne un altro, il quale, negli Elementi di critica omosessuale, scriveva proprio che il maschilismo è il più grave impedimento alla realizzazione della rivoluzione comunista: esso divide il proletariato e fa dei proletari eterosessuali i principali tutori della Norma sessuale di cui il capitale necessita per perpetuare il proprio dominio6.
Dunque, per Mieli era un fatto che fosse il capitalismo a “necessitare” di quella che lui definiva “Norma sessuale”, tutelata innanzitutto dal maschilismo dei “compagni”, ai fini della perpetuazione del proprio dominio; non il contrario. Credo che debbano essere imputati proprio alla costante obliterazione di questo “fatto” sia la scarsa attenzione, o la scarsa fiducia, da parte delle stesse minoranze di genere e sessuali, per un’analisi critica della loro subalternità materiale come dipendente da quella culturale, sia l’assoggettamento di chi, pur essendo parte di tali minoranze, le tratta come due cose ben distinte, essendo appunto la subalternità culturale e la subalternità materiale comunemente intese come due cose ben distinte.
D’altronde, è solo se siamo disposti a formulare un linguaggio, o una cornice interpretativa, che consenta di rendere intelligibile questo assoggettamento, ossia il nesso che sussiste tra il misconoscimento culturale, o il riconoscimento condizionale, e la subalternità materiale delle minoranze di genere e sessuali, che possiamo contrastare, e sovvertire, la distinzione tra il “culturale” e il “materiale”. Questa distinzione, infatti, è la base ideologica del dominio eterosessuale e maschile. Mettere in luce l’interdipendenza tra queste due dimensioni si rivela dunque necessario ai fini dell’ipotesi per cui la sovversione delle matrici culturali di oppressione sia un prerequisito necessario alla sovversione delle diseguaglianze materiali, poiché le prime costituiscono il prerequisito delle seconde. E formulare questa ipotesi, dalla prospettiva delle minoranze di genere e sessuali, assume un valore specifico: nessuno, o quasi, si sognerebbe infatti di dire che per il fatto che gli Stati Uniti hanno avuto un presidente nero allora le matrici culturali della razza non sono più implicate nella determinazione della subalternità materiale delle persone nere statunitensi – resa intelligibile, solo per fare due esempi, dal numero di omicidi di uomini di colore per mano della polizia, cresciuto esponenzialmente proprio durante i due mandati di Obama, o dal fatto che la popolazione detenuta nelle istituzioni penali degli Stati Uniti sia costituita per la maggior parte di persone nere, come Angela Davis ha chiaramente dimostrato7. Se un presidente nero è in grado di adombrare le masse di persone nere che versano in condizioni di subalternità, di inedia, di abiezione, significa solo una cosa: non significa che “il capitalismo” ha perseguito tutti i suoi obiettivi, bensì significa che “il dominio bianco”, inteso come sistema economico-politico e sociale, ha perseguito tutti i suoi obiettivi.
Dunque, come mai non appena il discorso si sposta dalla razza al genere o alla sessualità, il fatto che esistano – solo per fare un esempio – degli stilisti gay molto ricchi, e forse indubbiamente potenti in termini economici, dovrebbe sancire la definitiva impossibilità di intendere la subalternità culturale di genere e sessuale come premessa, e come conseguenza, di quella materiale delle persone gay, solo per fare un esempio? Il fatto che esistano alcuni stilisti gay molto ricchi e dalle posizioni politiche indubbiamente riprovevoli, in altre parole, è forse sufficiente ad adombrare che gli elevati tassi – con punte del 100% – di commessi gay che incontriamo nei negozi di alcune multinazionali dell’abbigliamento non coincida affatto con il tasso di ricercatori e professori gay che possiamo incontrare nei dipartimenti delle università, o in altri luoghi maggiormente qualificati socialmente? Pongo questa domanda pur sapendo, molto bene, che l’università sia oggi tenuta in piedi dal lavoro sommerso dei ricercatori precari; ma la mia domanda non cambia. I ricercatori accademici, ancorché precarizzati, sono nella stragrande maggioranza dei casi eterosessuali, e nella quasi totalità dei casi, sono pronto a scommetterci, cisgender – le punte del 100% di commessi gay trovano, indubbiamente, un corrispettivo nelle punte del 100% di professori e ricercatori cisgender. Dunque significa che l’università è e resta uno dei luoghi dell’attuazione e dell’istituzionalizzazione della stabilità dei generi eteronormativi. Qualcuno dirà che il tasso di commessi gay nel settore dell’abbigliamento riferisca della persistenza di uno “stereotipo” – il prezzo che i gay devono pagare per avere buon gusto. Ai fini del reperimento di un linguaggio più adatto alla messa in evidenza del nesso tra la dimensione culturale e quella materiale, sono invece più interessato a intendere questo fatto nei termini di segregazione occupazionale, e vorrei particolarmente insistere sulla dimensione coatta, non scelta, e imposta, di ogni segregazione.
Si legga, in proposito, l’articolo di Deborah Ardilli, Call Gender, che prende le mosse proprio da una delle tante forme di segregazione occupazionale che si dipana lungo le linee del genere, esemplificata dal lavoro “detestabile, mortificante, socialmente squalificante”, oltre che poco redditizio, nei call center – si parla di una media del 74%, e talvolta di punte del 100%, di operatrici donne, etero o lesbiche, quali che siano i loro titoli di studio8. Ed è molto importante insistere su questo punto, perché la segregazione occupazionale aggira tranquillamente quella norma sociale secondo cui a determinato titolo di studio corrisponde determinata posizione lavorativa, o reddituale, e, dunque, sociale – norma che, nel caso delle minoranze di genere e sessuali, non è mai stata valida, o sicuramente mai troppo valida: quante donne in possesso di laurea o dottorato hanno a un certo punto “scelto” di dedicarsi alla cura di prole e mariti? Al punto che a costituire uno “scandalo sociale”, agli occhi di un’opinione pubblica poco incline a prendere sul serio le conseguenze materiali del marchio del genere, è esclusivamente il fatto che donne laureate o con titoli di studio superiori siano confinate nei call center, non il fatto che lo siano, nella stragrande maggioranza, le donne tout court: al contrario, “il genere racchiuso nello ‘sgabuzzino delle telefoniste’ – Ardilli fa qui il verso di una poesia di Montale – può addirittura proporsi come poesia, riconfermandosi a un livello più alto come ineluttabile naturalezza”9. È proprio di fronte alla minaccia costante di questa “ineluttabile naturalezza” che occorre far confluire nella de-naturalizzazione della subalternità economica e materiale la subalternità di genere e sessuale – nella quale includo, da una prospettiva transfemminista queer, quella di donne, queers, gay, lesbiche, trans*, gender nonconforming, intersex, nonché quella di tutte le altre forme di posizionamento di genere e sessuale che rifuggono ogni distinzione categoriale.
Per tornare alla mia domanda, il fatto che esistano degli stilisti gay molto ricchi è dunque sufficiente ad adombrare la segregazione occupazionale dei ragazzi gay in regime di super-sfruttamento, precarietà e a condizioni reddituali molto, molto al di sotto della soglia di povertà? Mi riferisco, chiaramente, ai ragazzi gay cisgender, bianchi, abili ed esteticamente conformi, perché per quelli non bianchi, o disabili, o dai corpi meno conformi, o trans, le cose potrebbero essere molto peggiori, anche in questi luoghi di segregazione occupazionale – o in altri luoghi di segregazione, come quelli di segregazione relazionale e sessuale, esemplificati dalle chat. E, per fare un’altra domanda, il fatto che esistano alcune, poche, persone trans molto famose, e forse molto ricche, è forse sufficiente ad adombrare l’estrema subalternità materiale in cui versa la più ampia popolazione trans?
Al netto di alcuni limiti che rilevo nella ricerca, relativamente recente, finanziata dall’Ufficio Nazionale delle Antidiscriminazioni Razziali (Unar) nel 201110, un elemento che mi ha colpito positivamente è il rifiuto della “media” come valore di misurazione della situazione economica di un campione della popolazione, suppongo egualmente rappresentativo di persone eterosessuali e cisgenere e di persone non eterosessuali e non cisgenere – fermo restando che l’eguale rappresentatività statistica sia minata, solo per fare un esempio, dalla diseguale esposizione dei gruppi in questione alla necessità di valutare il rischio o l’opportunità di fare coming out. “In media”, in ogni caso, sembrerebbero non esservi significative distinzioni – il reddito medio è di 15mila euro annui. Ciò che la media non consente di indagare, tuttavia, è proprio il grado di diseguaglianza materiale tra i gruppi sociali, proprio perché li considera tra loro culturalmente simmetrici: per motivare il rifiuto della media, non a caso, gli autori dell’indagine rievocano, significativamente, quella poesia di Trilussa nella quale il poeta scrive che “se tu mangi un pollo intero e io non ne mangio, in media avremo mangiato comunque mezzo pollo a testa” (restituisco il senso della poesia dal titolo Statistica, non la lettera). Infatti, se dalla media spostiamo l’attenzione ad altri valori, come quello della deviazione standard – il quale consente di misurare, statisticamente, la diseguaglianza –, nel caso delle persone non eterosessuali, là dove c’è reddito, raramente si tratta di un reddito più alto della media, mentre, nel caso delle persone trans o non cisgenere, ciò che si rileva è innanzitutto l’alto tasso di assenza di reddito, dovuto al bassissimo livello di occupazione (e, come saprete, il lavoro è l’unico mezzo per avere un reddito). Anche in regime di diversity management, dunque, o di segregazione occupazionale, le persone trans fanno più fatica a trovare un lavoro grazie al quale sopravvivere, ancorché precariamente, o poveramente. Inoltre, tra i molti altri elementi che, nella ricerca dell’Unar, concorrono nella definizione del quadro della subalternità materiale delle minoranze di genere e sessuale, colpisce il diseguale accesso alla casa: assai di meno sono i proprietari di casa tra le persone non eterosessuali, e drasticamente di meno tra le persone trans. Ma il motivo principale per cui questo indicatore dell’accesso alla casa mi ha colpito, in realtà, è un altro: pur mettendo doverosamente in guardia dai rischi oggettivi insiti nell’accostamento alla prostituzione, la ricerca ha il merito di non confondere l’urgenza di contrastare la discriminazione – dal momento che non solo le persone trans si prostituiscono, come sappiamo – con le necessarie osservazioni sociologiche che ci consentono di leggerla, invece, come uno degli indicatori della diseguaglianza materiale rispetto ai gruppi sociali maggioritari. In primo luogo, lo fa rilevando gli effetti materiali della discriminazione, consistenti nel fatto che “i padroni di casa non affittano volentieri alle persone trans per via del timore della reazione dei vicini che assimilano la transessualità alla prostituzione” – reazione alla quale raramente vanno incontro le persone eterosessuali e cisgender, anche nei casi in cui si prostituiscano. In secondo luogo, però, lo fa non contribuendo ad occultare la vulnerabilità e ricattabilità di quelle persone trans che effettivamente si prostituiscono, per le quali la prostituzione costituisce l’unica fonte di reddito, e che lavorano a casa: e dalle interviste delle persone trans che lo hanno dichiarato, emerge che un certo numero di loro si trova di fatto a cedere una percentuale considerevole del proprio reddito al locatore, in aggiunta ai soldi dell’affitto. In questo, come in molte altre forme di accesso a beni e servizi fondamentali – quale è l’accesso a una casa, o a un ospedale –, le persone trans pagano innanzitutto il prezzo della non conformità alle modalità egemoniche di apparizione, le quali sono chiaramente modalità egemoniche che stabiliscono come deve apparire il genere per essere degno di riparo, assistenza, credibilità, supporto, reddito.
Chiaramente, innumerevoli sono i rischi sottesi a ricerche e statistiche di questo tipo. Uno di questi consiste nel veicolare l’idea per cui la subalternità culturale delle minoranze di genere e sessuali divenga più inaccettabile solo se siamo in grado di dimostrare efficacemente quali sono le sue implicazioni materiali, oltre che morali – si tratta dunque del rischio di riprodurre la dicotomia tra il culturale e il materiale, anziché sovvertirla. L’altro rischio è che mentre ci offrono un linguaggio che ci consente di analizzare e descrivere, e nominare, la materialità della diseguaglianza, al contempo rischiano di deprivarci della possibilità di cogliere le forme di agency, di resistenza e di supporto reciproco poste in essere dalle minoranze di genere e sessuali – da noi minoranze di genere e sessuali. E tali forme di agency, di resistenza e di supporto reciproco devono invece essere tenute debitamente in considerazione perché a essere sempre in agguato è un altro rischio: il rischio, cioè, di consegnarci all’autorità paternalistica, statale o capitalistica, che ci conduca, nei suoi modi e con i suoi termini eteronormativi e maschili, al di fuori della subalternità. Ma ciò su cui voglio insistere, però, è la necessità di una lotta e di un’alleanza politica più specificamente orientata alla sovversione di ciò che ci espone a questo doppio vincolo. Questa sovversione, per come la intendo, è sovversione delle differenze di genere e sessuali in modi che sono indiscernibili dalle diseguaglianze di genere e sessuali. Come l’ho definita altrove, questa sovversione è sovversione dell’eterosessualità11.
La sovversione dell’eterosessualità, a differenza di come molti hanno voluto intenderla, non è una lotta identitaria: tutt’al contrario, è una lotta anti-identitaria, ed è senz’altro un’alleanza potenziale, finalizzata alla sovversione della matrice di produzione di tutte le forme di genere e sessuali esistenti, dato che queste forme non si muovono affatto su un piano di eguaglianza, ma anzi vanno differenzialmente incontro a forme varie di abiezione e di subalternità. La sovversione dell’eterosessualità, inoltre, non pretende di elevare la matrice eterosessuale a un maggior grado di importanza rispetto ad altre matrici culturali di produzione di diseguaglianze materiali, come ad esempio la razza, l’abilismo, la classe, o anche la specie: ciò che intende fare, semmai, è non relegarla a una posizione di minore importanza. La tanto celebrata intersezionalità delle lotte, d’altra parte, ha senso solo 1) se esistono lotte specifiche contro specifiche matrici di oppressione e 2) se si ritiene che tutte le matrici di oppressione contro cui si lotta, intersezionalmente, abbiano eguale valore e necessitino di essere tutte egualmente sovvertite; per farlo, occorre però che siano innanzitutto riconosciute egualmente come tali, ossia come matrici di oppressione – cosa nel caso dell’eterosessualità non è mai troppo chiaro. L’eterosessualità non è “un orientamento sessuale” (sic), bensì, per riprendere le parole di Wittig, “un sistema sociale che produce la dottrina della differenza tra i sessi per giustificare la sua oppressione”12. A differenza di quanto scrive Wittig, questo sistema sociale non si limita, dalla mia prospettiva, alla giustificazione dell’oppressione, o dello sfruttamento, degli uomini sulle donne (benché lo faccia in modo determinante), bensì informa innanzitutto i parametri di intelligibilità di ogni forma di soggettivazione, psichica e corporea, e di relazione, procedendo poi alla loro distribuzione differenziale lungo linee di privilegio o abiezione: si pensi ai protocolli eteronormativi che consentono di diagnosticare e “correggere” l’intersessualità, o a quelli che consentono di transitare da un genere all’altro (“da un genere all’altro”, appunto). L’eterosessualità, in altre parole, è la matrice di ciò che chiamiamo genere, di tutti i generi; solo secondariamente, dunque, è un orientamento sessuale, senz’altro il più conforme, nella maggior parte dei casi, al sistema sociale che lo produce in quanto maggioritario e privilegiato. Al netto di questa scarsa chiarezza, la sovversione dell’eterosessualità non è una lotta preclusa alle persone eterosessuali: qualunque persona eterosessuale che intenda sovvertire se stessa, può senz’altro prendere parte a questa lotta, e a questa alleanza. D’altronde, da tale autosovversione non dovrebbero essere immuni nemmeno le stesse minoranze di genere e sessuali (pur con tutte le dovute distinzioni), dal momento che anche il privilegio cisgender, ad esempio, è un privilegio che dipende dalla conformità, finalizzata alla riconoscibilità, ai due generi eteronormativi, e dunque dalla conformità all’eterosessualità, anche in assenza di pratica eterosessuale.
Il Pride di Palermo onora quest’anno una pensatrice e una attivista alla quale in tant* sentiamo di dovere molto – le riconosciamo un’autorevolezza che è senz’altro sganciata dalla sua autorità, benché non dovrebbe essere dimenticato che tale autorità abbia senza dubbio contribuito alla sua autorevolezza. Il nome del Pride è L’alleanza dei corpi, preso in prestito dall’ultimo libro di Judith Butler. E come ricordava proprio Butler in un articolo di vent’anni fa, dal titolo e dal contenuto incredibilmente polemico, Merely cultural13, la produzione etero-patriarcale delle posizioni di subalternità di genere e sessuali non è mai stata, e non è tuttora, “meramente culturale”: se tali subalternità, innanzitutto, sono essenziali al mantenimento del privilegio eterosessuale e cisgenere, tale mantenimento consiste sempre, inaggirabilmente, in una forma di riproduzione materiale, e forse anche proprio economica. Non si tratta solo del fatto che le minoranze di genere e sessuali vengono genericamente marginalizzate, misconosciute, o segregate: sono la marginalizzazione, il misconoscimento e la segregazione stesse a garantire il mantenimento e la riproduzione materiale del privilegio. Non si tratta solo del fatto che alcune persone sono vittime dell’omofobia, della transfobia, o della misoginia, da parte di certe altre: sono l’omofobia, la transfobia, la misoginia, a costituire esse stesse specifici modi di produzione di genere e sessuale che operano per mantenere la stabilità del genere, l’eterosessualità del desiderio, nonché la naturalità della famiglia e della parentela, come luoghi deputati alla riproduzione della stabilità del genere e dell’eterosessualità. Nella misura in cui la stabilità del genere e l’eterosessualità funzionano in modo da assicurare che i due generi eteronormativi continuino a costituire la sacra e necessaria struttura del mondo, essi operano precisamente attraverso tutte le pratiche sociali che delimitano chi può ambire alla riconoscibilità, in questo mondo. Insistere sulla sovversione dell’eterosessualità, e dunque sulla sovversione della sua ri-produzione materiale, significa insistere sulla sovversione di ciò che è, e di ciò che può, un corpo – suggestione, questa che derivo dall’attivismo intersex, oltre che da quello trans*, e non è una suggestione meramente culturale, ma è piuttosto una suggestione che insiste sul ruolo che la regolamentazione eterosessuale esercita nella produzione e riproduzione dei corpi stessi, e nella loro esposizione differenziale al sostegno, o come più spesso accade, alla mancanza di sostegno. Per operare questa sovversione, che è una sovversione culturale di ciò che determina l’esposizione materiale dei corpi al privilegio e all’abiezione, abbiamo bisogno di sostegno – e abbiamo bisogno di reddito, innanzitutto, abbiamo bisogno di fare spazio, anche nei Pride, alla rivendicazione di reddito come specifica forma di restituzione del valore che ci viene estorto, e come forma di riconoscimento per il fatto di costituire la visibile e celebrata assenza che rende possibile l’invisibile, normalizzata, riproduzione della vita eterosessuale.
Note
| ↩1 | Ad esempio, quelle che si chiedono se il matrimonio non sia in qualche modo problematico rispetto a un progetto di trasformazione radicale dei modi in cui il genere, la sessualità e le relazioni sono organizzate socialmente ed economicamente; o, per fare un altro esempio, quelle che in cuor loro pensano che anche ammesso che tutti ambissimo alla genitorialità a mezzo surrogazione, al momento dobbiamo fare i salti mortali per pagare l’affitto, dunque figuriamoci se abbiamo i soldi per andare in California, o per pagare la gestante per il suo lavoro. |
|---|---|
| ↩2 | Alessia Acquistapace, Elisa A.G. Arfini, Barbara de Vivo, Antonia Anna Ferrante e Goffredo Polizzi, Tempo di essere incivili. Una riflessione terrona sull’omonazionalismo in Italia ai tempi dell’austerity, in Federico Zappino, a cura di, Il genere tra neoliberismo e neofondamentalismo, ombre corte, 2016, p. 66. |
| ↩3 | Judith Butler, L’alleanza dei corpi. Note per una teoria performativa dell’azione collettiva, trad. it. di Federico Zappino, Nottetempo, 2017, p. 125. |
| ↩4 | Monique Wittig, One is not born a woman (1981); trad. it. di Sara Garbagnoli, Non si nasce donna, in Sara Garbagnoli, Vincenza Perilli, Non si nasce donna. Percorsi, testi e contesti del femminismo materialista in Francia, Alegre, 2013. |
| ↩5 | Christine Delphy, L’ennemi principal 1. Économie politique du patriarcat, Syllepse, 1997; Ead., L’ennemi principal 2. Penser le genre, Syllepse, 2001. |
| ↩6 | Mario Mieli, Elementi di critica omosessuale, Einaudi, Torino 1977. |
| ↩7 | Angela Davis, Aboliamo le prigioni? Contro il carcere, la discriminazione, la violenza del capitale, trad. it. di Giuliana Lupi, minimum fax, 2009. Cfr. inoltre Miguel Mellino, Pelle nera, potere bianco. Dallas, Baton Rouge e le ceneri del mito post-razziale, in “Commonware”, 30 luglio 2016. |
| ↩8 | Deborah Ardilli, Call Gender, in “Effimera”, 20 giugno 2017. |
| ↩9 | Ibid. |
| ↩10 | Ricerca condotta da Carlo d’Ippoliti e Alexander Schuster, Disorientamenti. Discriminazione ed esclusione sociale delle persone Lgbt in Italia, Armando, 2011. |
| ↩11 | Rimando al mio Sovversione dell’eterosessualità, in Il genere tra neoliberismo e neofondamentalismo, cit. |
| ↩12 | Monique Wittig, Non si nasce donna, cit. |
| ↩13 | Judith Butler, Merely Cultural, in “Social Text”, n. 52-53, Autumn-Winter 1997, pp. 265-277; trad. it. di Cristian Lo Iacono in Nancy Fraser, Il danno e la beffa. Un dibattito su riconoscimento, redistribuzione e partecipazione, a cura di Cristian Lo Iacono, Pensa Multimedia, 2012. |





condividi