Ideologia e spirito di scissione in Gramsci
Dalla prospettiva del separatismo Queer
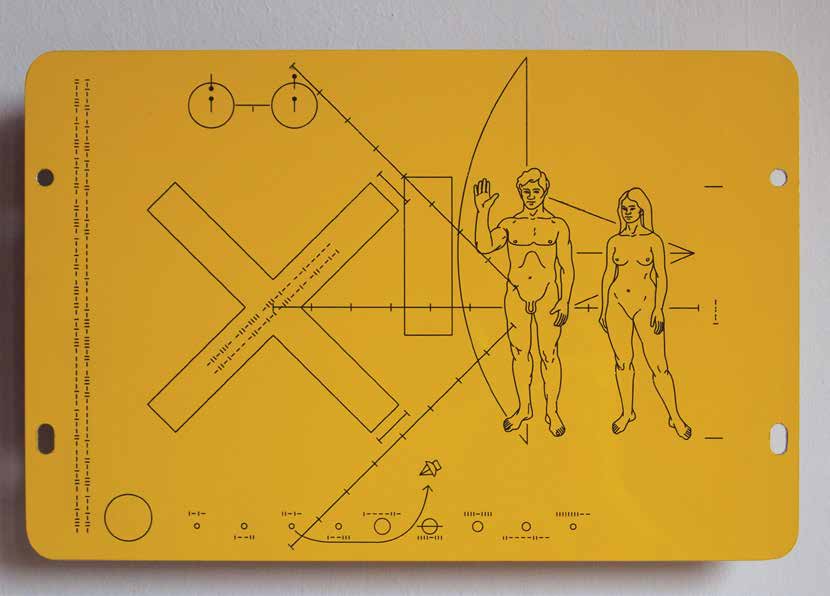
Il testo è stato scritto in occasione della partecipazione a CampoSud – A Visionary Camp. Gramsci Project (7 settembre – 1 ottobre, Cagliari). CampoSud è un’isola di azione e di pensiero, temporanea e autonoma, dove artisti, curatori, filosofi e pensatori sono invitati a indagare la tensione tra dimensione estetica e praxis e a riflettere sulla relazione tra pratiche artistiche, curatoriali e politiche nell’arte contemporanea.
Può sembrare singolare chiamare in causa un pensatore come Antonio Gramsci nell’ambito di un intervento che ha la parola «queer» nel titolo. Per quanto le riflessioni di Gramsci sulla subalternità, ad esempio, siano state molto produttive in campi di sapere ai quali egli direttamente non avrebbe pensato – penso innanzitutto agli studi postcoloniali, e all’impiego delle categorie gramsciane operato da Gayatri Chakravorty Spivak –, è anche vero che l’accostamento tra Gramsci e il queer richiede alcune precisazioni. Precisazioni che, dalla mia prospettiva, non sono solo di natura teorica, ma pratica: Gramsci mi è stato prezioso per l’articolazione di una posizione politica1 nel momento in cui la crociata neofondamentalista contro la «teoria gender» e contro l’«ideologia gender» produsse effetti incalcolati proprio attorno allo statuto «ideologico» delle riflessioni «teoriche» sul genere, facendo emergere divergenze importanti, in seno alle stesse minoranze destinatarie dell’attacco, tra una maggioranza relativa composta da quante rigettavano come infamante l’accusa di ideologia, e una minoranza assoluta composta da quante, invece, la rivendicavano apertamente, ravvisando nel conflitto in corso l’opportunità di una variazione trasformativa. Quasi un’epifania, nel bel mezzo di questi apparentemente infiniti mattini grigi della tolleranza2.
Come ha sintetizzato perfettamente Simona de Simoni, d’altronde, il neofondamentalismo non esprime semplicemente «una mentalità retrograda e regressiva». Il neofondamentalismo, piuttosto, «costituisce un regime discorsivo complementare a quello neoliberale»:
mentre la logica del neoliberalismo prevede/concede – almeno ad alcune coordinate geografico-politiche – la moltiplicazione delle espressioni individualizzate del sé a patto che tutte le pratiche soggettive siano socialmente normalizzate ed economicamente produttive (tanto in termini di sfruttamento, quanto di consumo), il neofondamentalismo prescrive la riproduzione dell’ordine sociale e simbolico all’interno del quale si iscrivono le stesse istanze normative3.
Il neofondamentalismo, in altri termini, disvela senza mistificazioni il posto del genere all’interno della riproduzione dell’ordine sociale e simbolico eteronormativo, tanto nelle sue forme gerarchizzanti ed escludenti, quanto in quelle «socialmente normalizzate ed economicamente produttive», agevolate dal neoliberalismo. Per tornare alla crociata contro l’«ideologia gender», la posta in gioco dell’accusa è proprio la salvaguardia della naturalizzata riproduzione dell’ordine simbolico e sociale eteronormativo, intesa come condizione di possibilità del neoliberalismo: di conseguenza, lo è anche la criminalizzazione di coloro che invece ritengono che sia sovvertibile. Criminalizzazione, è bene sottolineare, agevolata proprio dal fatto che per l’ordine discorsivo neoliberale, che si autodefinisce «post-ideologico» al fine di occultare la propria stessa natura ideologica, ogni (altra) ideologia non è che il frutto di un errore cognitivo o, nei casi peggiori, espressione di una falsa coscienza, un tentativo di manipolazione, una minaccia totalitaria. Che intelligenze politiche sopravvivano nel bel mezzo dell’allineamento pressoché totale all’ordine discorsivo neoliberale è chiaramente difficile da credersi, dal momento che la razionalità neoliberista ha contribuito a neutralizzare quasi ogni istanza conflittuale e sovversiva, producendo un discorso sul genere tra i più zuccherosi, finalizzato non alla sovversione bensì al rafforzamento degli assetti riproduttivi simbolici e sociali eteronormativi4. L’accusa di ideologia, tuttavia, non dovrebbe forse indicare un’eccedenza non ancora allineata, non ancora sussunta, e forse non allineabile, non sussumibile?
Con la parola «queer» vorrei riferirmi, performativamente, a questa eccedenza. So molto bene, infatti, che il suo significato o i suoi usi non siano univoci, né necessariamente forieri di qualcosa di concretamente promettente, o sovversivo5. Ma «queer», d’altronde, è una genealogia, non una proprietà intrinseca. E vorrei difendere l’idea che la sua genealogia ci parli di un’alleanza, non di un’identità, come ha ricordato recentemente Judith Butler, richiamandosi non a caso a Eve Kosofsky Sedgwick6. Un’alleanza tra le teorie e i movimenti femministi e le teorie e i movimenti gay, lesbici e trans*, finalizzata proprio alla sovversione di ciò che ne produce la comune oppressione: l’eterosessualità come matrice di produzione del binarismo di genere e come ordine simbolico e sociale che naturalizza questa stessa produzione, trasfigurandola in un’«identità» o in una serie di «differenze», per legittimare la propria oppressione. E nel dire che la matrice dell’oppressione è «comune» non intendo affatto eludere la pluralità delle sue forme sociali, né l’elevata conflittualità tra queste stesse forme sociali. Il paradosso di questa comune oppressione, infatti, consiste nel suo divenire intelligibile solo attraverso forme sociali tra loro distinte, e spesso non sovrapponibili.
Se «queer» sottende un’alleanza di questo tipo, a cosa si deve, dunque, l’accostamento a Gramsci? Sarebbe certo importante, per ragioni indipendenti, espropriare esplicitamente Gramsci alle forze politiche e intellettuali sintomaticamente impegnate in prima linea proprio sul fronte della criminalizzazione dell’ideologia gender… Ciò che intendo dire, in ogni caso, è che non erano certo il genere, né la sessualità, a costituire il fulcro delle riflessioni di Gramsci. Non c’è chiaramente da sorprendersi, ma è bene ricordare che del tutto assenti sono nei Quaderni del carcere, o in altri scritti, le considerazioni sui primi movimenti omosessuali tedeschi, ad esempio. E se pure nei Quaderni è possibile rinvenire un’attenzione nei riguardi dell’azione politica delle donne, ciò avviene sempre nel quadro di una implicita, ovvia, cornice maschile ed eteronormativa, indifferente alla critica femminista socialista, ad esempio7. Penso innanzitutto alla critica della famiglia come modo di produzione, alla critica delle forme di soggettivazione maschili e femminili che la famiglia istituisce e riproduce (in quanto necessarie alla riproduzione della famiglia stessa, tra le altre cose), nonché del surplus di lavoro domestico femminile gratuito, i cui principali fruitori erano gli uomini – uso l’imperfetto, ma solo per ragioni di restituzione storica e teorica, dal momento che il dato dello sfruttamento del lavoro di cura delle donne, a livello familiare e sociale, è mutato in misura minore alle aspettative. D’altronde, sembrerebbe che l’attenzione riservata da Gramsci nei riguardi dell’azione politica delle donne avesse la funzione di farle convergere a mo’ di massa di manovra verso una realizzazione del socialismo che, della critica femminista, preservava poco o nulla.
Come ebbe a notare Morena Pagliai, fin dal 1919, fin dai tempi di Torino, il pensatore sardo si spese attivamente per persuadere le donne socialiste torinesi alla consapevolezza della necessità di un’azione di massa, organizzandole dentro il partito o nell’associazionismo, in quanto sperava che partecipassero alle lotte dei lavoratori, e le supportassero8. A differenza di quanto aveva fatto il Partito socialista, prima, o il Partito comunista appena sorto e diretto da Bordiga, Gramsci – nelle parole di Camilla Ravera – richiamava costantemente le donne «al concetto leninista di partecipazione diretta, creativa, consapevole delle masse popolari» e indicava come modi e obiettivi del lavoro delle donne «la necessità di uno sviluppo autenticamente democratico del movimento femminile, ma nella prospettiva del socialismo». Lo stesso pensiero lo ritroveremo d’altronde nel Secondo sesso di Simone de Beauvoir, del 19499. Tuttavia, per quanto strumentale e subordinata alla priorità del socialismo, l’attenzione di Gramsci nei riguardi dell’organizzazione delle donne era piuttosto concreta: «L’ordine nuovo», la rivista di cui era caporedattore, istituì una tribuna dedicata ai temi dell’emancipazione femminile, assegnando l’incarico proprio a Camilla Ravera; sotto la sua direzione, il Partito comunista organizzò, fra le sezioni di lavoro, anche la Commissione nazionale per il lavoro delle donne, diretta da Ruggero Grieco; e determinante sarà il ruolo di Gramsci nella pubblicazione della rivista quindicinale «Compagna», che verrà poi abolita dalle leggi eccezionali del fascismo.
Tuttavia, è solo spostando l’attenzione dall’azione politica al pensiero che la anima che è possibile rendersi conto non solo della «quasi totale assenza di riferimenti, di precisazioni, di prese di posizione chiare»10, sempre per dirla con le parole di Pagliai, ma proprio della salda cornice maschile ed eteronormativa delle sue convinzioni circa il rapporto sociale di genere. Ad esempio, in una recensione alla rappresentazione al Teatro Carignano di Torino di Casa di bambola di Henrik Ibsen, apparsa sull’«Avanti!» nel marzo del 1917, Gramsci si chiede perché il pubblico sia rimasto indifferente di fronte al dramma «profondamente umano» di Nora Elmer «che abbandona la casa, il marito, i figli, per cercare se stessa»11. E a tale domanda si risponde accusando il pubblico italiano di essere succube della «morale tradizionale della borghesia», e di essere incapace di accettare «una morale e un costume meno animaleschi», un costume «per il quale la famiglia non è più un istituto economico, ma è specialmente un mondo morale in atto, che si completa per l’intima fusione di due anime che trovano l’una nell’altra ciò che manca a ciascuna individualmente».
In altre parole, ciò che la critica trans-femminista queer odierna definirebbe, sintomaticamente, «sciopero» di Nora Elmer dal genere e dai doveri riproduttivi imposti dall’eteronormatività, viene letto da Gramsci principalmente nei termini di dramma «profondamente umano», meramente esistenziale, sganciato dall’asimmetria delle relazioni coniugali e familiari, e dalla materialità della subalternità di genere, che viene pertanto naturalizzata. Naturalizzata al punto che se c’è un differenziale di potere che balza agli occhi di Gramsci nella lettura della storia di Nora Elmer è solo quello della classe, non del genere. «Il dramma di Nora Elmer», scrive, «lo possono comprendere, perché lo vivono quotidianamente, le donne del proletariato, le donne che lavorano». Gramsci, in altre parole, ravvisa un’ingiustizia nel carico di lavoro domestico non retribuito che grava sulle spalle delle donne che lavorano anche fuori casa, ma non perviene pienamente alla comprensione del principio binario che anima, tra le altre cose, la partizione sessuale del lavoro in generale, e dal quale dipende l’istituzione dei generi. Paradossalmente, infatti, assistiamo a un tentativo di elevare una versione «intima», quasi «privatizzata» dell’eteronormatività («l’intima fusione di due anime che trovano l’una nell’altra ciò che manca a ciascuna individualmente») a presupposto per una concezione «meno animalesca» del costume, tale per cui la famiglia non è solo un «istituto economico», bensì un «mondo morale in atto». È interessante il paragone specista, ma è ovviamente problematico – anche solo se letto in relazione allo stesso materialismo –, che Gramsci ripartisca l’animalità e l’umanità rispettivamente ai rapporti economici e a quelli morali: è solo se leggiamo la relazione eterosessuale in termini morali anziché economici, secondo Gramsci, che possiamo aprirci alla comprensione del fatto che essa costituisca un «mondo in atto», e non qualcosa di meramente «animalesco». In modo significativo, è proprio questa incapacità di leggere la materialità dell’eterosessualità – dei rapporti sociali che istituisce e da cui è riprodotta – a costituire la cifra delle riflessioni gramsciane sulla famiglia e sul rapporto sociale di genere. Di più: la sua esplicita concezione della famiglia dipende proprio da questa sua incapacità di decodificazione che egli però non considera come parte della sua stessa posizione di genere. D’altronde, è possibile che l’indifferenza di Gramsci per la critica femminista socialista affondasse le radici nell’oscuro presagio di ciò che avrebbe significato per l’organizzazione unitaria del partito, e per il modo in cui avrebbe messo in crisi la sua rigida concezione della «classe», in quanto la critica economica della famiglia, dell’eterosessualità e dello sfruttamento del lavoro di cura delle donne, proprio in quanto aspetti di un’unica egemonia, riguardava trasversalmente tutte le classi.
È importante tenere ferma, senza sconti, questa attenzione selettiva da parte di Gramsci nei riguardi dell’egemonia. E tuttavia, mi domando, è possibile rinvenire ugualmente dai suoi testi e dalle sue riflessioni alcuni spunti per il lavoro teorico e politico controegemonico delle minoranze di genere e sessuali? In altre parole, è possibile leggerlo contro se stesso, anche solo per andare contro egli stesso, e tuttavia facendo salve le possibilità politiche che le sue categorie sono in grado di aprire, anche al di là delle sue stesse intenzioni? Come apprendo dall’eccellente analisi di Gianfranco Rebucini12, ad esempio, un’interpretazione di tipo gramsciano dell’eteronormatività (l’ideologia eterosessuale) potrebbe mostrarci come l’eterosessualità a fondamento delle società capitaliste (acquisizione che ci proviene dal femminismo socialista) sia uno degli elementi del vasto «blocco ideologico» dell’egemonia di tali società. Proprio per questo, l’eterosessualità è anche organica a quelli che Gramsci chiama «apparati egemonici», ossia la struttura materiale del blocco ideologico.
Gramsci era ben cosciente del fatto che la parola «ideologia» rinviasse a una lunga lista di significati peggiorativi. Gli stessi Engels e Marx, che chiaramente influenzarono le idee di Gramsci, impostarono il problema in questi termini, salvo poche eccezioni. In modo detrattivo, entrambi impiegavano infatti il concetto di «ideologia» per definire gli schemi di intelligibilità, di possibilità e di realtà informati dalla classe dominante, in modi che occultassero la loro stessa natura ideologica, al fine di soggiogare le classi subalterne. Si tratta di una definizione di «ideologia» accreditata, e non ho alcuna intenzione di metterla in discussione: proprio questa definizione marxiana, peraltro, ci consente di definire anche l’eterosessualità nei termini di una ideologia. Un’ideologia che informa alcune tappe fondamentali della vita di ciascuno di noi, in questo mondo così com’è: l’assegnazione del genere, l’attribuzione di un nome, l’intelligibilità del corpo, l’educazione, la socializzazione primaria e secondaria, solo per dirne alcune. Questa ideologia informa dunque i processi di costituzione della soggettività. Il punto, tuttavia, è che a differenza di quanto pensavano Engels e Marx io vorrei oppormi all’idea per cui la lotta contro l’ideologia dominante possa essere «non ideologica», o che conduca a uno stato di cose scevro da ideologie. E questa è un’acquisizione che mi deriva proprio dalla lettura di Gramsci. Gramsci, ad esempio, pensava che «le ideologie sono tutt’altro che illusioni e apparenza; sono una realtà oggettiva ed operante». In altre parole, Gramsci rileva il carattere performativo delle ideologie: la produzione di effetti materiali, come anche ri-organizzativi, del discorso. Dal momento che la materialità e la realtà non hanno voce propria, esse parlano attraverso la voce dell’ideologia. Senza questa mediazione, tuttavia, non solo non potremmo leggerle, ma non potremmo nemmeno contestarle, sovvertirle e ri-organizzare altrimenti i termini della leggibilità stessa. E tutto ciò è già parte del lavoro ideologico: un lavoro ideologico minoritario, o controegemonico. «Le forze materiali», scrive Gramsci nei Quaderni, «non sarebbero concepibili storicamente senza forma (le ideologie) e le ideologie sarebbero ghiribizzi individuali senza le forze materiali»13. Le ideologie sono dunque gli schemi di intelligibilità culturale della materialità. Per Gramsci, anche il marxismo è chiaramente un’ideologia, ma un’ideologia controegemonica: le ideologie, infatti, costituiscono sempre il terreno comune e necessario della coscienza e della cultura, e le uniche differenze tra loro sono di grado.
D’altronde, come ha sintetizzato efficacemente Guido Liguori14, da un’analisi complessiva dei Quaderni è possibile evincere che 1) per Gramsci, l’ideologia è connessa alla religione popolare, al folclore e al senso comune; 2) che Gramsci auspica una «coscienza collettiva» che superi e sostituisca l’ideologia dominante, supportata da un’azione organizzata che sappia dialetticamente misurarsi con il «senso comune», al fine però di superarlo; 3) che ogni gruppo sociale, infine, ha la sua coscienza e la sua cultura, cioè la sua ideologia. E Gramsci accomuna il marxismo alle altre ideologie proprio per il fatto di rivestire una determinata utilità per un gruppo sociale; a differenza delle altre, tuttavia, esso non si spaccia per qualcosa al di sopra o al di là della storia. Nulla, infatti, esiste per Gramsci al di sopra o al di là dei rapporti di forza della storia. In essi tutto si gioca, ideologicamente: questa è la condizione di possibilità della stessa lotta ideologica per l’egemonia.
Esistono, come sappiamo, innumerevoli ragioni per essere sospettose nei riguardi di ogni facile equiparazione tra il marxismo e il queer. Ne esistono altrettante, tuttavia, per stare in guardia da ogni analisi fin da principio preclusa a ogni equiparazione di questo tipo. Se la lotta delle minoranze di genere e sessuali rifuggisse interamente un proposito ideologico, sarebbe fisiologicamente condannata alla sussunzione integrale da parte dell’ideologia dominante, o schiacciata su forme aleatorie di resistenza, spesso solo ed esclusivamente individuali – tu ti autodetermini così, io mi muovo strategicamente cosà, lei soccombe, un’altra ancora non sa come pagare l’affitto ecc. E dalla mia prospettiva, è proprio la risignificazione queer dell’idea gramsciana di «ideologia» a consentirci di stabilire una differenza rilevante con il marxismo: non esiste realtà o materialità autentica, non performativa, non ideologica. Questo dovrebbe essere sufficiente a fugare molti dubbi. D’altronde, questo è parte di ciò che si evince dalla teoria della performatività del genere di Butler, non a caso annoverata tra le principali ideologhe del gender: non esiste realtà che non sia performata; non esiste materialità che non sia mediata culturalmente. A fare la differenza è l’ideologia che permea quella performatività e quella mediazione. Si legga, ad esempio, il modo in cui Butler legge la materialità del corpo:
il sesso è reso comprensibile dai segni che indicano come dovrebbe essere letto o interpretato. Tali indicatori rappresentano i mezzi culturali con i quali viene letto il corpo sessuato. Anch’essi possiedono una natura corporea e, tuttavia, agiscono in quanto segni, perciò non è facile distinguere tra ciò che è «materialmente» vero e ciò che è «culturalmente» vero riguardo il corpo sessuato. Non intendo affatto approdare alla conclusione che segni meramente culturali producano la materialità del corpo: intendo dire però che il corpo non può diventare sessualmente leggibile senza quei segni, i quali sono allo stesso tempo irriducibilmente materiali, e culturali15.
Alla luce di quanto detto fin qui, tre sono le cose che mi preme sottolineare. Il concetto di ideologia in Gramsci ci consente 1) di collegare l’eterosessualità a una religione popolare, al folclore e al senso comune; 2) ci consente di auspicare una coscienza collettiva, chiaramente minoritaria, che superi e sostituisca l’ideologia dominante: per porre in essere tale superamento è necessaria un’azione organizzata che sappia leggere dialetticamente, negli stessi termini, il senso comune eterosessuale, al fine di sovvertirlo; 3) ci consente di comprendere, infine, che dal momento che un’ideologia definisce la coscienza e la cultura di ogni gruppo sociale, può ben essere che anche le minoranze di genere e sessuali abbiano una coscienza e una cultura, che alcuni, detrattivamente, definiscono «ideologia gender»: la sovversione dell’ideologia eteronormativa, ossia degli schemi di intelligibilità, di possibilità e di realtà da cui dipende la materialità del genere, tanto nelle sue forme privilegiate quanto in quelle abiette.
Gramsci riteneva che i gruppi subalterni dovessero lottare incessantemente per essere in grado di imporre una propria egemonia, e che la loro lotta fosse resa complicata dal fatto di essere oggettivamente immersi nell’ideologia dominante. Le loro rivendicazioni e le loro richieste politiche «possono essere solo frammentarie, non strutturate e talvolta anche contraddittorie perché giocano la loro lotta sempre all’interno della egemonia opposta»16. «La storia dei gruppi subalterni», scriveva, «è necessariamente disgregata ed episodica. […]. I gruppi subalterni subiscono sempre l’iniziativa dei gruppi dominanti, anche quando si ribellano e insorgono: solo la vittoria «permanente» spezza, e non immediatamente, la subordinazione».
La «vittoria permanente», ossia la costruzione di un’egemonia alternativa, prevede una fase di transizione autonoma che Gramsci definisce «spirito di scissione»:
Cosa si può contrapporre, da parte di una classe innovatrice al complesso formidabile di trincee e fortificazioni della classe dominante? Lo spirito di scissione, cioè il progressivo acquisto della coscienza della propria personalità storica, spirito di scissione che deve tendere ad allargarsi dalla classe protagonista alle classi alleate potenziali: tutto ciò domanda un complesso lavoro ideologico.
Gianfranco Rebucini ha ragione, a mio avviso, quando stabilisce una relazione tra lo «spirito di scissione» gramsciano e ciò che il movimento femminista ha storicamente riconosciuto come «separatismo»17, ossia come momento strategico «non misto» volto a produrre «un complesso lavoro ideologico, la prima condizione del quale è l’esatta conoscenza del campo egemonico» in cui si svolge la lotta. Secondo Rebucini, questa rilettura dello spirito di scissione gramsciano potrebbe gettare le basi per la costruzione di una politica strategica a partire dai bisogni e i desideri di coloro che, performativamente, lo praticano. Non si tratta di uno spazio di mera difesa, o resistenza; Rebucini lo legge piuttosto come un lavoro di teoria e di prassi volto a spezzare «l’unità basata sull’ideologia tradizionale». Lo spirito di scissione, scrive, coincide con un momento necessario dello sviluppo di una «coscienza di classe», e di una «catarsi».
Può sembrare inaspettato che ad avanzare una risignificazione del separatismo sia un maschio cisgender, ancorché non eterosessuale – una soggettività che, per il mondo così com’è, viene quasi regolarmente ascritta al gruppo sociale degli «uomini». È anche possibile, però, che questo paradosso sia parte della stessa risignificazione che propongo. È pur vero, d’altronde, che nessun* di noi, nel momento in cui è costretto a fare la propria apparizione in questo mondo, può sapere in anticipo quali ideologie renderanno intelligibile la propria materialità corporea; tutto ciò che possiamo fare è misurarci con esse, e tentare di contrapporne delle altre. Per le femministe degli anni Settanta e Ottanta, la pratica separatista, pur con tutte le sue importanti varianti, consisteva nella cesura relazionale dagli uomini, affinché i tratti di una comune oppressione simbolica e materiale, sessuale e sociale potessero emergere nella relazione esclusiva tra donne, ossia tra soggetti in posizione strutturalmente simile in termini di genere. Dobbiamo molto a questa pratica; dalla mia più modesta prospettiva, tuttavia, lo spirito che può guidarne oggi il ripensamento non verte attorno al sesso o al genere di «chi» si separa da «chi», bensì alla lotta e all’obiettivo politico da perseguire. Credo infatti che la preservazione del principio del separatismo classico, nell’idea che propongo, si tradurrebbe non solo in un’impossibilità di pensare la risignificazione stessa, ma, cosa assai più importante, ostacolerebbe la sovversione stessa di quel sistema sociale in cui è proprio la naturalizzazione del binarismo – o la produzione della differenza sessuale, per dirla in altri termini – a giustificare le gerarchie e le oppressioni di genere e sessuali.
Nessuno dovrebbe negare che la forma sociale dell’oppressione esperita da una donna cisgender è diversa da quella esperita da una donna trans. E nessuno dovrebbe negare che queste forme sono tuttavia diverse da quella esperita da un uomo gay, da una lesbica, da un uomo trans o da una persona intersex, specialmente quando tutte queste oppressioni si intersecano tra loro in modi complessi, e a loro volta con le questioni del colore della pelle, dell’età, del posto in cui vivi, dei soldi che hai in tasca e dell’abilità psicofisica. Eppure esistono, come sappiamo, discorsi gay violentemente misogini e antifemministi, posizioni femministe violentemente omo-transfobiche ed eterosessiste, ed esiste anche la minimizzazione, da entrambe le parti, delle altre, tantissime, forme di subalternità di genere, forse statisticamente meno ricorrenti, eppure determinanti nell’indicare la complessità della subalternità stessa, e dunque la necessità di un lavoro teorico e politico strategicamente più complesso contro ciò che la produce. Ma ho tuttavia in mente alcuni importanti esempi di alleanze tra donne, cis e trans, persone trans*, queer, gay/lesbiche, gender nonconforming, bisessuali, intersessuali, asessuali in cui la diversità delle forme culturali e materiali delle rispettive oppressioni non viene né minimizzata né usata per stabilire gerarchicamente quali di queste forme sia più ricorrente e oppressiva delle altre, bensì è precisamente ciò che indica la forma che deve assumere una visione sovversiva comune, della comune matrice di oppressione. Il separatismo potrebbe essere una pratica laboratoriale di supporto al «lavoro ideologico» di cui parla Gramsci, funzionale al coinvolgimento delle «classi alleate potenziali»: uno strumento di organizzazione di una classe che ambisce evidentemente alla realizzazione di un’altra idea di realtà, diversa da quella della classe dominante.
Questo separatismo è queer perché la «classe» non è tenuta insieme dall’identità, né storica né biologica, bensì dall’alleanza tra soggettività diverse, le cui oppressioni sono tuttavia egualmente riconducibili a un’ideologia che tali soggettività, nella pratica, non intendono affatto riprodurre. In questo senso, concordo dunque con la genealogia del queer proposta da Butler, nonché con il «proposito normativo» di questa alleanza. Un proposito normativo, ci spiega Butler, rappresenta una «concezione del mondo come dovrebbe essere»; in fondo, questa rappresentazione immaginativa non è che uno dei significati proprio della parola «ideologia», secondo Gramsci. «Il mondo come dovrebbe essere», scrive Butler, «tutelerebbe la possibilità di sovvertire la norma, e offrirebbe supporto e conferma a quanti si trovassero a realizzare tali sovversioni»18.
Ma divergo anche da Butler. Secondo lei, infatti, che la genealogia «queer» designi questo tipo di alleanza, dovrebbe esortare le soggettività che vi convergono a stabilire alleanze anche con altri gruppi sociali, finalizzate al raggiungimento di obiettivi più ampi, specialmente sul fronte dell’abbattimento della precarietà e della povertà socialmente indotte dall’istituzionalizzazione di logiche neoliberali. Questo ragionamento, tuttavia, manca di problematizzare adeguatamente che l’abiezione delle minoranze di genere e sessuali, che sia o meno percepita come frutto di un’oppressione comune, sia in ogni caso la condizione di possibilità del privilegio relativo degli altri gruppi sociali. Curiosamente, infatti, le minoranze di genere e sessuali dovrebbero allearsi con altri gruppi per il raggiungimento di ogni obiettivo possibile, fuorché per la sovversione della propria oppressione! E questo è un ragionamento che, inaspettatamente, riproduce la dicotomia tra il culturale e il materiale, mancando di vedere l’organicità del legame che salda tra loro la struttura e la sovrastruttura. Questo lo comprese Gramsci, inaspettatamente, forse anche a partire dalla propria esperienza di disabilità motoria – come mi ha fatto opportunamente osservare Peter Mayo. È nella sostanza di quel legame che si cela l’ideologia dominante, ed è dalla sostanza di quel legame che traluce la possibilità della sua sovversione. La precarietà di una persona queer, o trans*, o di una persona ascritta al gruppo sociale delle «donne», è indotta innanzitutto dal mero fatto di quella ascrizione: ciò determina la sua vulnerabilità, la sua esposizione alla violenza, di strada o domestica, allo stupro, all’indigenza economica, alla possibilità di morire precocemente, come a quella di essere inclusa condizionalmente. Ciò significa che ancora non sappiamo distinguere dove finisca l’abiezione culturale e dove inizino gli effetti materiali ed economici di questa abiezione. Ma non è compito nostro distinguerlo, al momento, dal momento che su di noi grava l’onere di esperirlo. Ed è certo che se vogliamo parlare di ricomposizione, occorre prima sovvertire tutti i differenziali di potere che stabiliscono una gerarchia tra assi di oppressione, minando così le basi per la ricomposizione stessa. «Queer» è forse il nome che possiamo attribuire a una scissione necessaria a sovvertire questa gerarchia, che ancora ci impedisce di chiamare «queer» una desiderabile, e trasformativa, ricomposizione.
Note
| ↩1 | Mi riferisco esplicitamente a Gramsci in Sovversione dell’eterosessualità, in «Effimera», 31 marzo 2016. Cfr., inoltre, Deborah Ardilli, Federico Zappino, La volontà di negare. La teoria del gender e il panico eterosessuale, in «il lavoro culturale», 14 luglio 2015. |
|---|---|
| ↩2 | Sto chiaramente citando il Foucault recensore di Pasolini: Les matins grises de la tolérance, recensione a Comizi d’amore di Pierpaolo Pasolini, originariamente pubblicato su «Le Monde», 23 marzo 1977, trad. it. in «aut aut», 345, gennaio-marzo 2010. «Credo che ciò che attraversi il film», scriveva Foucault, «non è l’ossessione per il sesso, ma una specie di timore storico, un’esitazione premonitrice e confusa di fronte a un regime che allora stava nascendo in Italia: quello della tolleranza. È qui che si evidenziano le scissioni, in quella folla che tuttavia si trova d’accordo a parlare del diritto, quando viene interrogata sull’amore. […] Con rassegnazione o furore, i vecchi si preoccupano: che fine farà il diritto? E i giovani, con ostinazione, rispondono: che fine faranno i diritti, i nostri diritti?». |
| ↩3 | Simona de Simoni, Per un’epistemologia queer del vivente. Il fondamentalismo sessuato del neoliberismo, in «OperaViva Magazine», 24 ottobre 2016. |
| ↩4 | Educazione alle differenze, rispetto delle differenze, valorizzazione delle differenze, valore della/delle diversità, diversity management, empowerment, «inclusione», «eguaglianza», «riconoscimento», «pari opportunità», «parità», «autodeterminazione», «consenso», «violenza», contrasto alla «violenza», «violenza di genere», femminicidio, mascolinità tossica, bullismo omofobico, cyberbullismo omotransfobico, ma anche sessismo, misoginia, omofobia, transfobia, omo-lesbo-transfobia: tutte parole che descrivono la scotomizzazione, l’aggiramento volontario o la naturalizzazione dei grossi problemi, dei danni e degli ingenti costi individuali e sociali dell’ordine eterosessuale. |
| ↩5 | Ho già affrontato la questione in Orgoglio, resistenza, sovversione. Conferenza per il Palermo Pride 2017, ora in «OperaViva Magazine», 4 luglio 2017. |
| ↩6 | Judith Butler, L’alleanza dei corpi, Nottetempo 2017, p. 115. |
| ↩7 | Cfr. Judith Butler, Merely Cultural, in «Social Text», n. 52-53, Autumn-Winter 1997, pp. 265-277; trad. it. di Cristian Lo Iacono, Meramente culturali, in Nancy Fraser, Il danno e la beffa, a cura di Cristian Lo Iacono, Pensa Multimedia, 2012. |
| ↩8 | Morena Pagliai, Donna, in Carla Ricchini, Eugenio Manca e Luisa Melagrani (a cura di), Gramsci: le sue idee nel nostro tempo, Edizioni de L’Unità, Roma 1987. |
| ↩9 | In un’intervista dell’ottobre del 1974, de Beauvoir dichiarerà che il socialismo non può bastare, e che il femminismo deve costituire una lotta autonoma. Esattamente come Gramsci, tuttavia, anche de Beauvoir non si smarca dal quadro di una esplicita elevazione dell’eterosessualità a metro di misura finanche della possibilità di alleanza tra femministe e omosessuali maschi: «Io credo», dirà, «che non vi possa essere lotta comune tra il femminismo e l’omosessualità maschile. L’omosessuale maschio in genere odia le donne, le emargina assai più coerentemente dell’uomo etero, rifiutandole anche a letto. Perciò i tentativi che si sono fatti in Francia di unificare i movimenti omosessuali maschili e femminili sono falliti» (corsivo mio). Si sarebbe tentati di commentare che Simone de Beauvoir è «omofoba», legittimamente infastiditi, e di voltare pagina. Forse, però, l’epiteto individualizzante ci impedirebbe di sottolineare che l’assoggettamento delle donne – incluso quello della stessa de Beauvoir – non resta al di fuori della camera da letto. E questo potrebbe essere più interessante, politicamente. De Beauvoir manca di vederlo al punto che è la sudditanza all’atto sovrano di «accettazione» o «rifiuto» delle donne da parte degli uomini, «a letto», a stabilire la possibilità e il grado di una «lotta comune» – quella tra donne e omosessuali maschi. Ed è questa stessa sudditanza a costituire il prerequisito di una lotta definita «autonoma», quella femminista, che tuttavia, nelle parole di de Beauvoir, manca puntualmente di precisare il suo obiettivo. Stando al suo ragionamento, infatti, un’alleanza tra femministe e omosessuali maschi non è impossibile, ma è soprattutto inutile: se il femminismo non è lotta contro l’eterosessualità come condizione di possibilità del patriarcato, come matrice di produzione del maschile e del femminile, e come sistema sociale che occulta questa produzione per naturalizzarne gli effetti politici, sociali ed economici, perché gli omosessuali maschi dovrebbero lottare insieme alle femministe, dalla prospettiva di de Beauvoir? Solo per solidarietà? Tutto ciò può essere di grande rilievo per il ripensamento più generale delle alleanze, e del separatismo. |
| ↩10 | Pagliai, Donna, cit. |
| ↩11 | Tutte le citazioni che seguono sono tratte da Antonio Gramsci, La morale e il costume (Casa di bambola di Ibsen al Carignano), in «Avanti!», 22 marzo 1917. |
| ↩12 | Gianfranco Rebucini, Cannibalismo queer. Gramsci e le strategie di trasformazione molecolare, in Federico Zappino (a cura di), Il genere tra neoliberismo e neofondamentalismo, ombre corte 2016, p. 51 ss. |
| ↩13 | Tutte le citazioni dai Quaderni del carcere derivano dall’Edizione critica dell’Istituto Gramsci, a cura di Valentino Gerratana, Einaudi 1975. |
| ↩14 | Guido Liguori, Ideologia, in «Gramscitalia» |
| ↩15 | Judith Butler, Fare e disfare il genere (2004), Mimesis 2014, p. 147. |
| ↩16 | Rebucini, Cannibalismo queer, cit., p. 54. |
| ↩17 | Ibid. |
| ↩18 | Butler, L’alleanza dei corpi, cit., p. 56. |





condividi