Che mondo è mai questo?
Una fenomenologia pandemica

Pubblichiamo in anteprima un estratto dal nuovo libro di Judith Butler, Che mondo è mai questo?, tradotto da Federico Zappino, e appena pubblicato per Laterza. Ringraziamo l’autrice, il traduttore e l’editore per la disponibilità.
***
Anche senza addentrarci nella questione se la pandemia costituisca un effetto diretto o indiretto del cambiamento climatico, appare in ogni caso dirimente calare la condizione pandemica nel contesto del cambiamento climatico, poiché entrambi rendono l’interdipendenza globale una questione di vita o di morte. Quale che sia il senso del mondo che intendiamo privilegiare, nell’ambito di una simile discussione, esso sarà in ogni caso influenzato dalla questione dell’attuale distruzione ambientale. E ciò significa che la pandemia accade in seno a una forma di «razzismo ambientale», esemplificato dal fatto che nelle zone del mondo più povere l’acqua non sia potabile, o dal numero crescente di sfratti nei riguardi di coloro che non hanno la certezza di un reddito. Il rapporto differenziale che le diverse popolazioni intrattengono con aria, acqua, riparo e cibo – già compromesso dal cambiamento climatico e, ancora prima, da forme sregolate di capitalismo – si registra ancora più acutamente nelle condizioni di una pandemia. Pertanto, per quanto il razzismo ambientale e la pandemia costituiscano situazioni distinte, esse al contempo si connettono e, soprattutto, si intensificano a vicenda. Da un lato, la sospensione dei viaggi e la battuta d’arresto di determinate attività produttive ha consentito al mare e all’aria di rigenerarsi da forme decennali di contaminazione tossica. Dall’altro lato, abbiamo solo intravisto in cosa potrebbe consistere una simile rigenerazione, prima che la produzione riprendesse la sua normale attività; eppure, la pandemia ha mostrato che la rigenerazione e la riparazione ambientale sarebbero possibili, qualora si riducessero gli spostamenti aerei e si abbassassero, o azzerassero, i livelli delle emissioni di CO2.
Il mio proposito è di collegare idealmente il carattere interconnesso delle nostre vite all’obbligo di organizzare il mondo – a partire dall’assistenza sanitaria – in ossequio a un principio di eguaglianza radicale. D’altronde, l’idea di «riaprire» e «far ripartire l’economia» in zone del mondo in cui per più di un anno si è vissuto in condizioni di lockdown, sembra ignorare che ciò, per molte persone, potrebbe comportare malattia e morte. Nella primavera del 2022, alcuni governi hanno dichiarato la «fine della pandemia» – come quello inglese, presieduto da Boris Johnson –, annullando la validità di ogni restrizione adottata fino a quel momento. Decisioni come questa servono a istituire porzioni di popolazione come dispensabili, addossando alle singole persone la responsabilità di mettersi in lockdown o di rischiare la vita. A pagare il prezzo più alto di simili decisioni sono coloro che soffrono di malattie autoimmuni, diabete, malattie respiratorie, nonché coloro che, a causa dell’età o dell’impossibilità di vaccinarsi per ragioni mediche, non hanno anticorpi a sufficienza.
Alla base dell’eliminazione delle misure restrittive e dell’obbligo dei dispositivi di protezione vi è certo l’idea che alcune persone si ammaleranno e moriranno, e anche che tutto ciò sia meno importante rispetto alla riapertura e al rilancio dell’economia. Ma il punto è che il rilancio dell’economia è realmente importante, specie per le classi più povere o per quelle che, se non lavorassero, sprofonderebbero nella povertà e nell’indebitamento. Ma a quale prezzo? Chi vive solo ed esclusivamente del proprio lavoro si pone questo interrogativo: perché devo lavorare per «guadagnarmi da vivere» se «guadagnarmi da vivere» mi fa morire? Non si tratta più solo dell’alternativa «o lavoro o morte», bensì del fatto che si muore di lavoro, come conseguenza del lavoro, anche se il lavoro è ciò di cui si ha più bisogno per vivere. È questa la «contraddizione» che Marx ha illustrato tanto tempo fa, sebbene, nella sua analisi, una simile contraddizione fosse innescata dal modo di produzione capitalistico, non da una pandemia (ma d’altronde, al tempo in cui scriveva Marx c’era proprio una pandemia).
Nel sistema capitalistico, secondo Marx, chi lavora lo fa per assicurarsi un salario che consenta a sé e alla propria famiglia di sopravvivere. Eppure, se si lavora in condizioni che non tutelano la propria salute, si rischia la vita. Inoltre, tempi di lavoro che finiscono per essere logoranti per il corpo diventano causa di infortuni e malattie. Nel capitalismo, in altre parole, è il lavoro stesso a non consentire a chi lavora di riprodurre la propria vita, dei propri familiari o delle persone che ha a carico. E ciò significa che quel lavoro che dovrebbe garantire una vita vivibile, in realtà procura malattie o morte. Nell’analisi di Marx, una simile contraddizione poteva essere risolta solo dal superamento del capitalismo; oggigiorno, la stessa contraddizione può risolversi solo attraverso l’istituzione di un reddito minimo garantito. Se il reddito fosse garantito, infatti, nessuno, per vivere, dovrebbe svolgere un lavoro nocivo per la propria salute. La vita vissuta con l’ansia costante per un lavoro mortificante non è una vita vivibile. L’attuale organizzazione economica non è improntata all’eguaglianza e non serve a sostenere la continuità delle vite e della vita comune.
Dunque, la pandemia si svolge sia nel contesto del cambiamento climatico e della distruzione ambientale sia nel contesto di un’economia capitalistica che continua a considerare dispensabile la vita di chi lavora, o almeno è così nella maggior parte dei casi. Le cose, infatti, sono parzialmente cambiate rispetto a quando Marx descrisse il lavoro nei termini di una lotta fra la vita e la morte: in alcuni casi, il lavoro si svolge oggi in condizioni di sicurezza e nella garanzia di diritti come l’assicurazione sanitaria o il welfare. Tuttavia, per la stragrande maggioranza delle persone al mondo il lavoro continua a svolgersi nella precarietà e nell’assenza di assicurazione sanitaria, e le lotte volte al riconoscimento di un simile diritto si rivelano troppo spesso fallimentari. Quando ci chiediamo per chi, negli Stati Uniti, la pandemia è sproporzionatamente più rischiosa, scopriamo che lo è per le classi più povere, per le comunità afroamericane, per le popolazioni migranti e carcerarie e per le persone anziane. Nella riapertura delle fabbriche, nel rilancio dell’economia, o nelle rapide alternanze di apertura e chiusura, la tutela della salute di chi lavora è a dir poco secondaria. E per coloro che non hanno accesso all’assistenza sanitaria, o che subiscono di più gli effetti del razzismo, malattie croniche che prima della pandemia sarebbero state del tutto curabili diventano «patologie pregresse», delineando un quadro di «comorbidità» che rende quelle persone più vulnerabili alla malattia e alla morte. Almeno fino all’estate del 2021, diversi paesi al mondo – la maggior parte dei quali in Africa – non avevano ricevuto alcuna dose di vaccino. Simili diseguaglianze globali si riflettono nei tassi di vaccinazione tuttora drammaticamente bassi in paesi quali Burundi, Tanzania, Repubblica Democratica del Congo e Haiti.
Coloro che reputano la «salute dell’economia» più importante della «salute della popolazione» aderiscono alla convinzione che il profitto e la ricchezza siano molto più importanti delle vite umane. Coloro che calcolano i rischi, includendo in tali calcoli «tot» decessi, concludono implicitamente o esplicitamente che in nome dell’economia si sacrificheranno vite umane. Durante le varie ondate pandemiche, alcune persone hanno sostenuto che le fabbriche e i luoghi di lavoro sarebbero dovuti rimanere aperti per il «bene» delle classi più povere. Ma se sono proprio queste a sacrificare la propria vita sul posto di lavoro, dove i tassi di infezione sono più alti, ritorniamo alla contraddizione fondamentale illustrata da Marx quasi duecento anni fa. Si dice di voler far ripartire la produttività – o di non arrestarla del tutto – per il sostentamento di persone che è proprio il rilancio dell’economia, però, a produrre come dispensabili, come mera forza-lavoro sostituibile, come vite che non contano come tali – ossia, come vite uniche, dal valore inestimabile. Nelle condizioni della pandemia, in altre parole, il lavoro che dovrebbe dar da vivere accelera in realtà la morte. Chi lavora scopre dunque in senso letterale di essere dispensabile e perfettamente sostituibile, dal momento che, stando a questa logica, la salute dell’economia è decisamente più importante della sua. Ecco come si trasforma, nel sistema pandemico, la vecchia contraddizione insita nel sistema capitalistico.
Nel 2021, quando i decisori politici hanno calcolato costi e benefici del «ritorno alla normalità», sapevano perfettamente che molte persone sarebbero morte, ma sapevano anche che a rischiare di più sarebbero state le persone prive di un’adeguata copertura sanitaria e quelle che non hanno altra scelta se non lavorare «in presenza». Ma anche le persone in carcere o detenute alle frontiere degli Stati, che non possono muoversi, né tantomeno praticare il «distanziamento sociale». Il distanziamento sociale, ossia la possibilità di stabilire determinate condizioni spaziali di sicurezza, è infatti un privilegio. Nei rifugi per senzatetto, dove molte persone vivono in condizioni di prossimità, questo privilegio non esiste. Il carattere strutturale del razzismo diventa via via più esplicito ogni qual volta una persona non bianca, negli Stati Uniti, o una persona povera, ovunque nel mondo, sia la prima a soccombere. Ogni volta che questo accade, è all’opera un calcolo: quante vite vale la pena perdere? E ancora prima: quali vite non sono mai state considerate degne di salvaguardia?
Domande come queste sono state proprio al cuore del Movement for Black Lives durante la pandemia, dal momento che molte comunità non bianche negli Stati Uniti hanno subito la decimazione di forme dignitose di assistenza sanitaria, ammesso che l’abbiano mai avuta. Inoltre, l’omicidio di George Floyd nel maggio del 2020 – e di un lungo e sempre crescente numero di persone nere uccise dalla polizia – ha dislocato, intensificandolo, un senso di pericolo già sufficientemente pervasivo; e non solo perché si trattava dell’ennesima vita nera annientata dalla brutalità della polizia, ma anche perché lo spettacolo della sua uccisione costituiva una spudorata pubblicità al suprematismo bianco, una forma rinnovata di linciaggio realizzata ad arte per la diffusione tramite smartphone. Anche in quel caso, sintomaticamente, a essere oggetto della presa da parte del poliziotto era il collo, e George Floyd soffocava, non riusciva più a respirare. Ma il trauma collettivo vissuto in relazione alla comunità nera non può essere sottovalutato nella sua forma intergenerazionale e attuale, specialmente nel momento in cui così tante vite nere sono interessate dalla pandemia, a causa di forme di assistenza sanitaria inadeguate, inaccessibili o insostenibili. Il numero sproporzionato di morti fra le persone nere ci parla di un razzismo sistemico più generale, nel quadro di un sistema sanitario mal funzionante e brutale. E come se non bastasse, quella stessa comunità che piange la perdita di vite che si sarebbe potuto e dovuto curare e salvare, deve subire anche la violenza della polizia per le strade. Se Foucault sosteneva che vi fosse una differenza fra «uccidere» e «lasciar morire», oggi possiamo osservare come la violenza della polizia, che uccide, vada di pari passo con il modo di funzionamento del sistema sanitario, che lascia morire. E a unificare queste due modalità operative del potere è proprio il razzismo sistemico.
Infatti, non si tratta di episodi in conflitto fra loro, né tantomeno di disgrazie casualmente simultanee. Si tratta di fenomeni correlati. Il razzismo sistemico esemplificato dall’insufficienza di cure mediche nei riguardi delle comunità non bianche deriva dalla mancata istituzione di un sistema sanitario universale che consideri la cura un bene comune fondamentale, su cui chiunque dovrebbe poter contare. E la pretesa che le persone nere lavorino al servizio di un sistema sociale che consente a chi ha soldi di starsene a casa, ben distante da negozi e fabbriche, deriva a sua volta da un sistema economico che induce le persone a lavorare anche nei casi in cui le condizioni di lavoro siano nocive per la salute, anziché garantire un reddito universale che metta chiunque nella condizione di sottrarsi alla «scelta» fra morire di povertà o morire di malattia.
Abbiamo preso forse un grande abbaglio quando abbiamo pensato che la pandemia avrebbe potuto riequilibrare le asimmetrie sociali e che avrebbe costituito l’occasione per immaginare forme radicali di eguaglianza sostanziale e giustizia sociale. Non dico che fossimo totalmente fuori strada, ma sicuramente non avevamo pensieri all’altezza del mondo che pure immaginavamo. Uno dei problemi sottesi all’idea di poter rifare il mondo è che questa presumeva che il mondo fosse diventato una tabula rasa e che la pandemia costituisse un nuovo inizio, senza tenere in considerazione che il «nuovo» ha sempre alle spalle una storia pesante, e dando per scontato che i nuovi inizi costituiscono sempre drastiche rotture con il passato. L’altro problema, molto più drammatico, è che la preoccupazione per il mondo, nel discorso pubblico dominante, è stata ben presto sostituita dalla preoccupazione per l’economia. La «salute dell’economia» diventava molto più preziosa e degna di attenzione rispetto alla «salute delle persone»; un simile discorso rappresentava il sistema economico quasi come un corpo, come un organismo, la cui vita e prosperità dovevano essere tutelate a ogni costo – anche a costo, cioè, di perdere vite umane. Tuttavia, questa dislocazione del concetto di salute dai corpi all’economia, non si limitava a trasferire una condizione umana ai mercati; al contrario, annientava letteralmente la salute dei corpi per dare vita all’economia. È questa forma mortifera di dislocamento e inversione, intrinseca alla logica capitalistica, ad aver guadagnato il centro della scena nella crisi pandemica.
Se la salute antropomorfizzata dell’economia va a discapito della salute delle classi lavoratrici, di quelle più povere, delle minoranze e di coloro che hanno già patologie o disabilità, ciò significa che la «salute» del capitalismo non si limita a prendere la «vita» dei corpi al suo servizio, ma rappresenta essa stessa una forma di vita organica. Vuole una vita; prosciuga le vite; esprime la volontà di sacrificarne delle altre. In questo senso, si tratta di una figurazione che prende vita. E la bieca consolazione del modello costi-benefici è che tiene conto della salute e della vita dei corpi, ma lo fa solo per sostituirle con numeri, percentuali e curve. Tutte cose che non svolgono la funzione di «rappresentare» i corpi viventi, bensì di annientarli. Le curve e i numeri, infatti, dovrebbero mostrarci quante vite stanno morendo e se la curva scende un po’ dovremmo essere felici, perché significa che ne stanno morendo un po’ di meno, e ciò dovrebbe costituire una grande notizia. Il punto è che sono proprio queste lievi oscillazioni grafiche a fornire l’alibi di ferro per far «ripartire l’economia» e, con essa, dare nuovo slancio al virus e alle sue varianti. Ciò significa dunque che è l’oscillazione della curva della mortalità a mettere in pericolo le vite. Il punto di equilibrio della curva al servizio della razionalità capitalistica è quello che consente di stabilire livelli «ragionevoli» e «accettabili» di contagio e di mortalità, il «giusto» numero di decessi giornalieri, il «normale» andamento della curva stessa, il livello che stabilisce il numero di morti con cui possiamo tranquillamente convivere. In quanto rappresentazione, il grafico sterilizza dunque le morti, o diventa l’allegoria della sterilizzazione collettiva della morte in sé, mettendo nuovamente la metafora della salute al servizio di un progetto necropolitico – esemplificando in modo straordinariamente vivido la pulsione di morte che prospera nel cuore della macchina capitalistica.
Niente paura: non sto dicendo che i corpi non necessitano di rappresentazioni. E non sto nemmeno dicendo che non abbiamo bisogno di grafici o statistiche. Ci servono, eccome. La vita del corpo dipende infatti da rappresentazioni che illustrano quali sono i suoi bisogni. Il punto, tuttavia, è che dovremmo chiederci: di quali rappresentazioni abbiamo bisogno? Non penso che i grafici uccidano le persone; penso però che esemplifichino spesso la traiettoria di forme di violenza che dipendono da un generale, sterilizzato, disconoscimento ai fini della loro riproduzione. D’altronde, se alla preoccupazione per il mondo si sostituisce la preoccupazione per l’economia (intesa sia come economia di mercato, sia come mercato finanziario) e se si percepisce l’economia stessa come un corpo che rischia di ammalarsi o di morire, la nostra più grande responsabilità diventa quella di rimetterci al lavoro, far ripartire gli affari, affollare chiese e palestre, e poco importa se ciò favorirà i contagi, facendo ammalare le persone, o facendole morire. A restare implicita, in questo discorso, è l’idea terrificante che le vite di chi lavora sono superflue, così come le vite di coloro che non hanno una casa e dormono in rifugi che non hanno porte blindate e limiti invalicabili come le proprietà borghesi. A restare implicita, inoltre, è la dispensabilità di tutte quelle vite a cui viene fatto credere di riabbracciare la «libertà» proprio mentre si dirigono a passo spedito verso la malattia e la morte, proprie o altrui, fra cui quelle di chi non conoscono. Com’è possibile, allora, strappare il mondo dall’abbraccio mortale dell’economia? Il primo passo per una rifondazione promettente del mondo consiste proprio nel disfarsi dell’idea che questa necessiti del rilancio del capitalismo.
[…]
È possibile che la pandemia dia luogo a una qualche, pervasiva, forma di melanconia. D’altronde, come si fa a piangere tutte queste vite perdute? E, più in generale, come nominiamo questa perdita immane? Quale tipo di gesto pubblico, o quale monumento, potrebbe mai compensare la necessità di piangere collettivamente le perdite? Ovunque assistiamo alla mancanza di segni pubblici adeguati ai nostri lutti, e un senso di vuoto pervade il mondo sensibile. Se gli assembramenti e i cortei sono stati soggetti a restrizioni di vario tipo, e se le modalità di incontro garantite dalle piattaforme digitali generano spesso tensione, quali altre modalità potrebbero consentirci di connetterci per condividere il lutto? Chi ha partecipato alle varie forme di commemorazione attraverso le varie piattaforme digitali conosce bene la difficoltà di simili pratiche. E l’impossibilità di assistere da vicino una persona ricoverata in ospedale, prima che muoia, o l’impossibilità di riunirsi con altre persone che la conoscevano, sortisce effetti nefasti sul senso di perdita, impedendone l’aperto riconoscimento, anche collettivo. Moltissime persone che hanno subito una perdita, durante la pandemia, si sono ritrovate a piangerla da sole dentro casa, diventata il luogo esclusivo del lavoro del lutto, private di forme pubbliche di condivisione, commemorazione e registrazione della perdita. E nonostante Internet abbia cercato di imporsi definitivamente come la nuova sfera pubblica, difficilmente potrà sostituire un assembramento di persone, in luogo privato o pubblico, che si aiutano a elaborare e a vivere insieme la perdita – anche nei casi in cui, riunendosi, mantengono le distanze, si abbracciano in modi goffi o si baciano con un senso di ansia generalizzato. Forse, è possibile elaborare il lutto anche in modi totalmente individuali e privati. Tuttavia, simili forme di elaborazione potranno mai eguagliare la forza di un pianto nello spazio pubblico, la condivisione di storie o i canti – tutti modi di chiedere al mondo di testimoniare la nostra perdita nella sua singolarità, accaduta nel cuore di un tessuto sociale di vite intrecciate?
Nel caso di morti su larga scala e in rapida successione, come quelle indotte da una pandemia, le richieste di commemorazioni pubbliche del lutto sono sempre rivendicazioni politiche. Nelle fasi iniziali della pandemia, le immagini dei corpi accatastati in Ecuador, di quelli ammassati in una stanza di una casa di cura, nel New Jersey, o trasportati dai camion militari nel Nord Italia ci hanno fornito un resoconto illustrato di quanto siano state sottofinanziate e svalutate le infrastrutture sanitarie negli ultimi decenni, comprese quelle nelle carceri. Eppure, troppo spesso tali immagini passano frettolosamente e in modo sensazionalistico, cosa che rafforza un senso pervasivo di morte, oltre che una pratica condivisa di deviazione. Sembra quasi di sentire qualcosa del tipo: «Non soffermiamoci troppo su ciò che non va!». Il nostro obiettivo dovrebbe essere quello di convertire questo pervasivo senso di perdita in forme di lutto e di rivendicazione politica. Imparare a piangere la morte di massa implica la capacità di riconoscere la perdita anche di chi non si conosce, di chi non parla la nostra lingua e che vive a una distanza incolmabile, tutte cose che rimarcano la dimensione globale del nostro disorientamento. Non è affatto necessario conoscere ogni vita di cui si afferma energicamente l’esistenza. Non è necessario conoscere tutti i dettagli di questa o quella vita per sapere, in ogni caso, che è esistita. Al contempo, che il diritto di appartenenza al mondo sia anonimo non significa che sia meno vincolante nei nostri riguardi. Nel discorso mediatico, invece, a imporsi alla nostra attenzione sono solo le singole vite spezzate, quelle che avrebbero dovuto avere una possibilità in più di vivere, e che hanno sempre un nome. «Le persone più anziane», si dice, «sarebbero morte lo stesso, prima o poi» – perché invece le più giovani no? Quale che sia l’età, il valore di ogni singola vita è già parte delle vite altrui, e presuppone una forma di riconoscimento, qualora fosse perduta, che diventa un’incorporazione, un’eco vivente, una ferita aperta o una traccia che trasforma coloro che sopravvivono. Il fatto che altre persone stiano soffrendo in modi a me ancora ignoti, non significa che la loro sofferenza mi sia incomprensibile. E ciò accade perché a forgiare i vincoli etici tra noi non sono che echi, traduzioni, risonanze, ritmi e ripetizioni – come se la musicalità del lutto si facesse strada oltre ogni confine proprio in virtù dei suoi poteri acustici. Benché non coincidano, la perdita subita da chi non si conosce fa da eco alla nostra. E se fa da eco è proprio perché non coincidono. L’intervallo fra noi diventa dunque una connessione. Ecco perché, pur non conoscendosi, coloro che piangono una perdita hanno molto in comune.
I calcoli di mercato e le speculazioni economiche che hanno informato la ripresa dell’economia, accettando la morte di intere fasce della popolazione come prezzo da pagare per la «salute» del mercato, ritengono dunque il sacrificio di qualche milione di vite un prezzo ragionevole o, addirittura, una norma ragionevole. Proprio così, un tale costo è arrivato a qualificarsi come «ragionevole» in seno alla razionalità di mercato. Eppure, dal momento che la razionalità di mercato non esaurisce la razionalità in senso più ampio, ed è destinata ad arenarsi, dobbiamo affermare il valore incalcolabile di ogni vita, anche in assenza di una definizione statica o univoca di ciò che significa «vita». Il dilemma è come elaborare una nozione di eguaglianza sociale che includa, anziché negare, questo valore incalcolabile.
Traduzione italiana di Federico Zappino

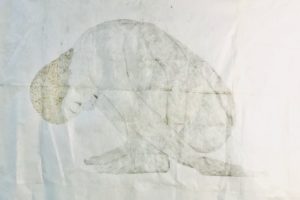



condividi