I molti modi del vivente
Un libro di Massimo Filippi
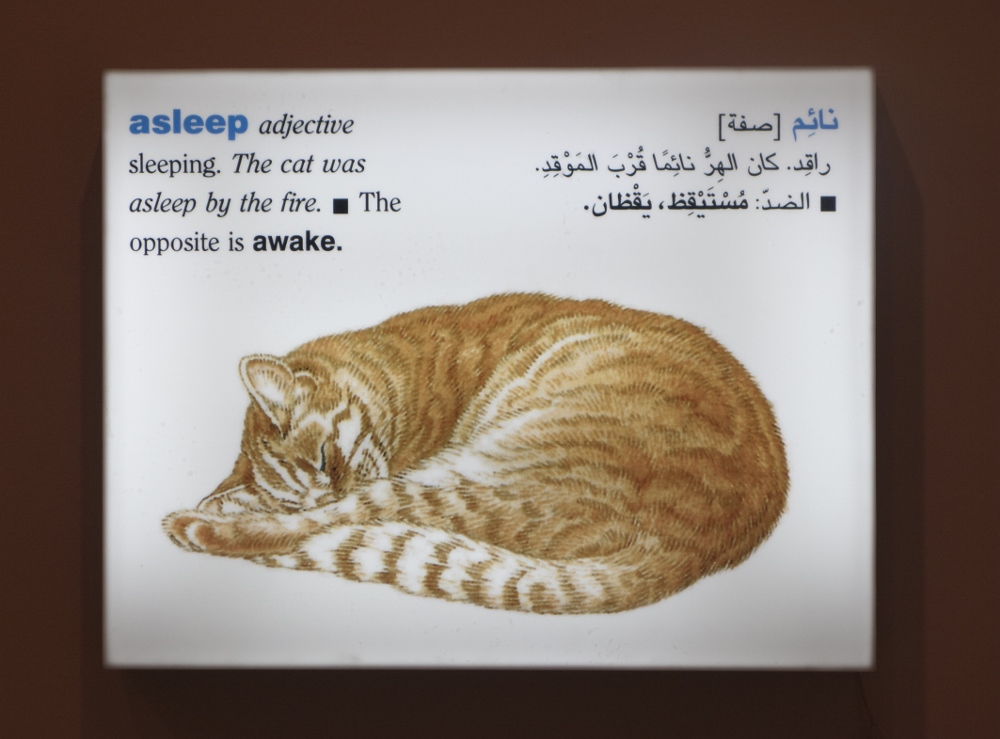
La politica animale è una politica del divenire, anche – specialmente dell’umano.
Brian Massumi, What Animals Teach us About Politics
Anche se le pareti dei mattatoi non sono ancora diventate trasparenti, la questione animale, cioè lo sfruttamento materiale e istituzionale degli animali, la portata e la sistematicità della loro messa a morte, è oggi più che mai evidente. Diversi, però, sono i modi in cui la questione animale diviene visibile. Da un lato, infatti, esiste un animalismo dei segni, che include gli animali nelle proprie rappresentazioni e mentre li appropria continua a mantenere intatto il proprio (umano): l’ennesima variazione sul tema dell’umanesimo, che facendo leva sulla libertà di scelta e coscienza individuali è ricondotto a un’istanza etica compatibile con le esigenze dell’impalcatura antropocentrica. Un animalismo normato che si fa, o meglio, trova spazio in contesti già esistenti, che siano i manifesti di partito (come quello del neonato Movimento Animalista di Michela Vittoria Brambilla) o gli scaffali dei supermercati: sterilizzato, confezionato e soprattutto venduto come stile di vita, insomma già sgrassato dal tritacarne del capitalismo contemporaneo. Dall’altro lato, ci sono le pratiche antispeciste che, pur non ignorando affatto la potenza dei segni, rendono visibile la performatività che questi hanno nel momento in cui, combinandosi coi dispositivi materiali (i processi, le istituzioni, le tecniche, le norme), servono a giustificare, sancire e anche produrre i modi e le forme di appropriazione degli altri non umani nella società contemporanea. L’ultimo libro di Massimo Filippi, Questioni di specie (elèuthera, 2017) riflette sulla politica animale delle pratiche antispeciste a partire da quello che Foucault definirebbe il ventaglio di rapporti della questione animale, in cui l’oggetto in questione, piuttosto che tendere verso le parole che lo fanno parlare, riconduce le parole alle situazioni che lo rendono possibile: la dimensione, l’intensità, la moltiplicazione e la pervasività delle pratiche di dominio, e la rimozione sistematica del loro materiale da costruzione – i corpi animali e animalizzati – dalla società.
La premessa da cui parte la riflessione di Filippi è che la questione animale è sempre anche una questione umana, e che non è possibile parlare degli animali non umani senza parlare, al contempo, anche degli umani come animali. Perché, se è vero che l’antropolatria – cioè la celebrazione dell’eccezionalismo umano – è resa possibile della rimozione degli altri non umani, è altrettanto vero che essa si fonda sulla costruzione dell’umano attraverso un lavoro di purificazione costante, letteralmente funzionale a levare di mezzo l’essere umano dal continuum nel quale è (da) sempre imbrigliato: non solo perché quella fra umani e animali è una storia di co-evoluzione, ma anche perché è una storia di co-appartenenza, di confini condivisi e differenziazioni inclusive, piuttosto che di differenze escludenti. Chiarita questa premessa, il libro di Filippi si sofferma su tre punti chiave della questione animale così intesa.
Il primo, una sorta di corollario, afferma la necessità di declinare politicamente l’antispecismo: infatti, se la questione umana è una questione politica e non un fatto di natura, anche la questione animale lo è. L’umanizzazione e l’animalizzazione sono effetti congiunti di pratiche discorsive e materiali attraverso cui si costruisce buona parte dell’ordine del mondo e le sue gerarchie. La creazione dell’uomo come Homo sapiens, sulla base di un privilegio linguistico-cognitivo strutturato dalla dicotomia natura/cultura, è una questione decisamente più politica che biologica, e non perché le differenze biologiche non esistano, ma perché esse «significano» soltanto all’interno di precisi sistemi simbolici e materiali. Che, nell’Occidente moderno, sono serviti alla definizione dell’identità e dei privilegi dell’uomo come «maschio, bianco, eterosessuale, cristiano, adulto, abile, sano e proprietario». Neppure i genitali maschili e femminili dicono nulla di per sé, ma solo all’interno della norma eterosessuale, i cui discorsi e le cui pratiche producono – non descrivono soltanto – questi corpi secondo l’opposizione binaria maschio/femmina. Un mescolarsi continuo di dispositivi di calcolo e dispositivi mitopoietici governa i processi di speciazione, fra loro interdipendenti e variamente articolati, dividendo fra corpi speciali, perché posti all’origine della specie (come pure del genere, della razza, e di molte altre categorie usate per definire le alterità) e dunque sacri, e corpi speciati, perché derivati dalla specie e per questo sacrificabili. Riconoscere il «comune […] meccanismo ideologico e operativo» in atto nel dominio sugli animali così come in altre forme di dominio (e sterminio) – quella sintesi tra burocrazia e massacro che Arendt descrive nei lager nazisti e Mbembe riconduce alle piantagioni di schiavi – vuol dire situare anche la relazione fra umani e animali all’interno dei rapporti di potere esistenti. Questi, che sono sempre storici e sociali e mai naturali, pur essendo costitutivi del vivente animale, non possono mai essere del tutto eliminati, come Filippi molto chiaramente sottolinea, ma possono sicuramente essere denaturalizzati e variamente modulati, tracciando le molteplici intersezioni del privilegio antropocentrico e inceppandone i meccanismi di funzionamento.
In quale direzione agire? Perché, ed è questo il secondo punto su cui si sofferma Filippi, l’antispecismo non esiste al singolare: anche se si tratta di un movimento ancora giovane, nato intorno alla metà degli anni Settanta, periodo in cui compaiono i primi testi teorici sull’argomento (Liberazione animale di Singer è del 1975), l’antispecismo ha attraversato almeno tre momenti che, seguendo uno sviluppo analogo a quello di altri movimenti di liberazione come ad esempio il femminismo, possono oggi anche coesistere. Da un antispecismo dell’identità, che è poi quello nato dall’alto e più o meno coincidente con la versione dell’animalismo etico di cui si è parlato, che non mette in questione il privilegio antropocentrico ma estende invece agli animali gli stessi diritti fondamentali dell’uomo, si è passati a un antispecismo della differenza, dal carattere più militante, in cui la questione animale diventa finalmente politica, ma che non mette ancora in crisi il concetto di specie, limitandosi a differenziarlo lungo molteplici assi; per arrivare, infine, all’antispecismo del comune (non perché questo sia l’antispecismo più diffuso nel presente, ma perché è quello che l’autore auspica per il prossimo futuro, e noi con lui), cioè quell’antispecismo che, invece di constatare le differenze esistenti, guarda al modo in cui le differenziazioni accadono (e possono accadere altrimenti), ai tagli nel continuum e a chi e cosa li ha prodotti, partendo dal presupposto che tutti gli animali, umani e non, «sono costitutivamente relazionali: non sono individui che entrano in relazione, ma relazioni che eventualmente […] possono venire individualizzate». Questa relazionalità è la vita stessa che ci attraversa impersonalmente, che condividiamo piuttosto che possedere, prima ancora di ogni logica del proprio – quando ancora siamo e lasciamo essere inappropriati, come direbbe Haraway.
Rispetto ai precedenti, questo antispecismo ha un carattere intersezionale, almeno per due ragioni: primo, perché si fonda sul riconoscimento del funzionamento congiunto e degli effetti analoghi includenti/escludenti di rapporti di potere che non esistono mai al singolare, ma che producono il fuori e il dentro del corpo sociale, identificando posizionamenti e regolando gli attraversamenti e gli aggiustamenti di confine; secondo, perché se anche gli animali non umani partecipano di questi meccanismi di soggettivazione nel tempo e nello spazio, anch’essi sono soggetti storico-sociali e non puramente biologici, e possono quindi performare – anche se non sempre sono nelle condizioni di poterlo fare – la loro soggettività rispondendo al potere che li assoggetta. Tutti gli animali possono resistere, se intendiamo la resistenza come la capacità che ogni animale, senza distinzione, ha di patire, dunque desiderare, dunque poter irrompere nel campo del dominio, persino rinunciando alla vita se questa ha già luogo come una messa a morte. Se condividiamo con gli animali i medesimi processi di speciazione, possiamo condividerne anche le possibilità di resistenza. Ma cosa significa, in concreto, condividere la resistenza con gli animali?
Arriviamo quindi al terzo dei punti affrontati da Filippi, e cioè che il sintomo animale non richiede una cura, punto che l’autore, in realtà, discute all’inizio del libro, e che io scelgo di trattare in chiusura perché a mio avviso è cruciale per la pratica di una politica animale resistente. Ma prima una piccola divagazione. C’è un racconto di Michele Mari in cui un uomo, passeggiando per le vie brulicanti di gente per le imminenti festività natalizie, si ferma davanti alla vetrina di un negozio di animali attratto dal dialogo fra due passanti distratti, e si accorge che in un acquario, impigliato fra un’alga di plastica e il vetro, si dibatte ormai debolmente un minuscolo pesciolino nero. «Sarà stata la sua muta impotenza, la sua invisibile disperazione così in contrasto con la crassità filistea del Natale, ma io», dice il personaggio del racconto, «in quel pesce vidi compendiarsi tutto il dolore del mondo». Al termine di una serie di incontri con diversi umani incuranti, l’uomo col pesciolino color liquirizia – che compra a caro prezzo pur di sottrarlo al suo destino di merce, per giunta ormai invendibile – torna finalmente a casa, versa il pesce nell’unica zuppiera che possiede, aggiunge all’acqua il mangime, e si mette a guardare l’animale. Il racconto termina con l’uomo che rimane immobile di fronte a Sofferenza (questo il «nomignolo» che egli dà al pesce, morto o soltanto mortalmente indebolito non è dato sapere), là dove, finite le parole del personaggio, terminano necessariamente anche quelle dello scrittore: il punto in cui il dolore del mondo non può più essere detto, ma soltanto impossessarsi di noi.
Di fronte a questo «immenso dolore animale», come lo definisce Filippi, Mari lascia muto il suo personaggio. Al posto delle parole, quelle rivolte o anche accolte (attraverso un linguaggio che resta comunque umano), subentra piuttosto il compianto. Diversamente dagli altri passanti, che vedono il pesce come un oggetto in vendita dietro una vetrina, l’uomo vede Sofferenza perché sente «il sintomo animale» e decide di prendersene cura. Forse è troppo tardi per rendere vivibile la sua morte in vita, ma non ancora perché essa sia resa visibile. Chi può divenire visibile, chi può morire e, di conseguenza, chi ha il diritto di essere compianto? Il protagonista del racconto è capace di vedere la resistenza di Sofferenza perché ne accoglie la vita al grado zero, in tutta la sua disperata affermazione, «carne del mondo liberata dall’economia dell’utile e degli utili» (Filippi). Il sintomo animale che questo pesce intrappolato manifesta non è infatti, scrive Filippi, un’anomalia da normalizzare o estirpare, semmai qualcosa di cui «prendersi cura per liberare e liberarsi».
La differenza è sostanziale: come scrive Hedva nella sua Teoria della donna malata, la cura come azione temporanea istituzionalizza e legittima la malattia per cancellare i sintomi, invisibilizzare i corpi cronici, disfunzionali, indesiderati o non spendibili. Prendersi cura, invece, è un processo politico continuo, un modo per stringere legami di «parentela radicale» fra corpi fragili e precari, corpi a-normali considerati inutilizzabili, la cui vulnerabilità diventa finalmente visibile ma soprattutto condi-visibile. Se c’è il sintomo, allora vuol dire che qualcosa ancora resiste, perché il sintomo animale è la manifestazione del conflitto fra le forze del potere e quelle della resistenza al potere. Divenire animali, non è soltanto divenire capaci di sentire «tutto il dolore del mondo» (questo il titolo del racconto di Mari) ma anche tutta la vita del mondo, cioè prendersi cura della vita in comune con i nostri compagni di specie. Perché l’antispecismo sia, come scrive Filippi, un «movimento politico di critica radicale dell’esistente», è necessario che la politica degli animali si faccia anzitutto politica animale, cioè una politica immanente e affettiva, non con-forme alle differenze del contesto in cui ha luogo ma, come insegnano gli animali, volta alla trans-formazione e alla contaminazione radicali del vivente.





condividi