In purissimo azzurro
Giulia Napoleone alla Galleria Nazionale

«Il viaggio non finisce, solo i viaggiatori finiscono». Questa frase di Saramago sembra riassumere appieno l’intero percorso di Giulia Napoleone (Pescara, 1936), il cui lavoro è al centro di una importante antologica curata da Peppino Appella alla Galleria Nazionale: e non solo perché l’artista è da sempre instancabile uccello migratore (Francia, Australia, Inghilterra, Tunisia, Germania e Russia sono alcuni dei luoghi attraversati dal suo sguardo cristallino e curioso), ma anche per il fatto che – e mi si lasci passare questa congiunzione causale – ad accompagnare ogni suo progetto c’è, mi pare, un sentimento del tempo e dello spazio che ha ansia d’infinito, di sospensione, di trasparenza. Sin dai suoi primo passi nel campo della musica e della fotografia, Napoleone ha disegnato infatti un discorso teso ad attraversare l’ineffabile, a toccare con mano la riflessione per mostrarne i processi logici, a spingersi dietro il paesaggio visto di sfuggita dal finestrino di un treno in corsa e a cogliere (a stabilire un contatto con) i segni nel loro farsi, svolgersi, aprirsi all’alterità. Giunta ben presto alla pittura per elaborare un ritmo interiore che deraglia dagli steccati della ragione e conquista una magmatica metanarrativa, attenta a definire un’atmosfera sempre più controllata (del 1963 è la prima personale alla Galleria Numero di Firenze dove espone eleganti e minimali composizioni astratte), Napoleone mostra un percorso intellettuale solitario, il cui volto ha la voce della poesia, intesa come una missiva che ha tanti destinatari ma torna inevitabilmente al mittente.
Nel 1965, accanto all’arteria della pittura (che accompagna l’artista ormai da oltre cinquant’anni), si lega un brillante viale legato all’incisione diretta per instaurare un corpo a corpo con la carta che diventa protagonista e deuteragonista di un lungo racconto nato all’indomani della Scuola libera del nudo (qui Mino Maccari le insegna i segreti del bulino, della puntasecca, della maniera nera, del punzone) e dopo aver conosciuto Giorgio Morandi che la esorta a dedicarsi appunto all’incisione. In questi anni entra nella scena culturale romana dove frequenta Ennio Flaiano (che le presenta Sinisgalli e Moravia), Peppino Appella, Giovannino Russo o Dario Durbè e dove concepisce un discorso sempre più aperto alla leggerezza, alla nitidezza, all’astrazione del pensiero che pensa l’ultimo pensiero. Intorno alla metà degli anni Settanta, dopo un viaggio in Inghilterra (in questo periodo sperimenta un materiale plastico trasparente, il sicoglass), Napoleone partecipa alle attività che Appella organizza a Roma negli spazi della Galleria dell’Arco: intensi scambi tra artisti, poeti e letterati che le rendono visibile una strada in cui la parola pensa l’immagine e il segno si fa sogno, composizione lirica, lingua degli inizi e delle fini fatta di puntini, di tratti, di intervalli delicati.
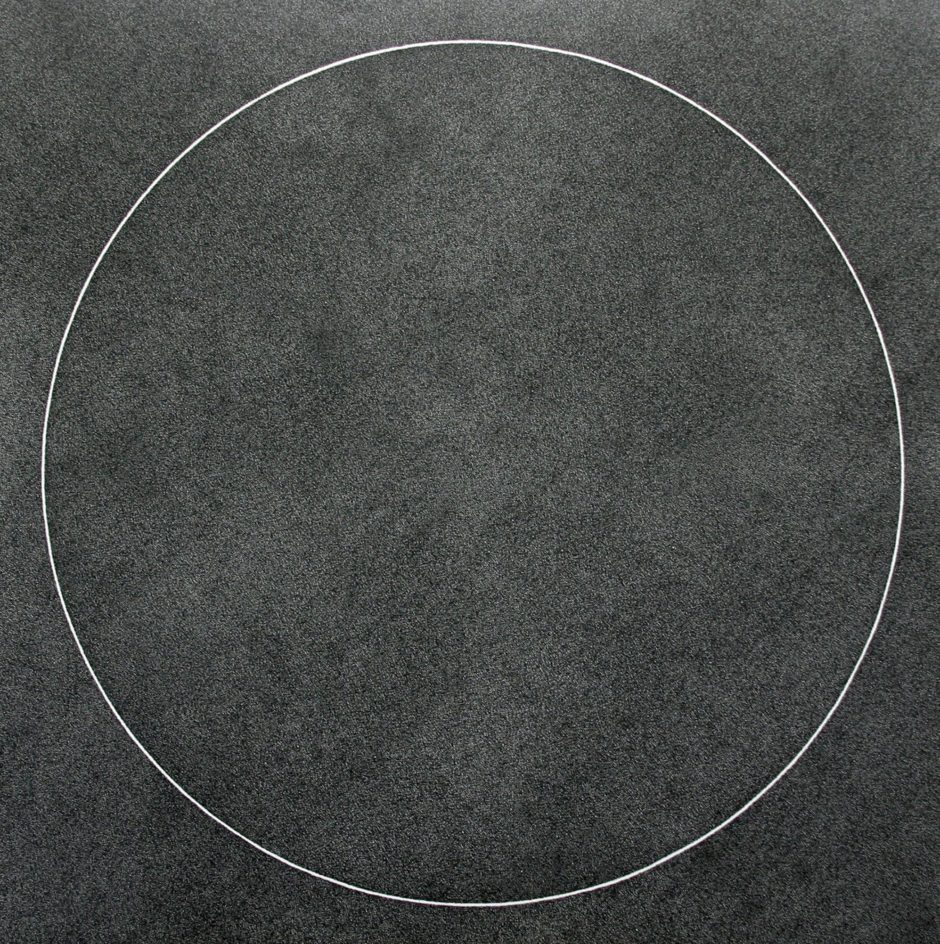
Datate 1956-2018, le opere presentate alla Galleria Nazionale con Realtà in equilibrio – il catalogo, prossimo all’uscita, reca un testo di Stefania Zuliani – ritessono il racconto di una vita, di un progetto etereo che si scrolla di dosso la realtà, si misura con la memoria (Misura della memoria è il titolo di una sua mostra del 2013), si predispone all’ascolto del silenzio. Ci sono, in mostra, centoquattro opere (tra dipinti, disegni, incisioni, sculture e libri d’artista) in cui si assapora la forza dell’evocazione, di un crudissimo azzurro («l’azzurro è denso di storia […], è il colore dell’intelligenza, del pensiero, della poesia francese» avverte l’artista in un’intervista che chiude la mostra e la riapre per chi abbia voglia di rileggerne le tappe) dove le cose si fanno eterne e dolci, dove il pensiero si estroflette e avvolge lo spettatore per trasportarlo al di là della fisicità, in un controspazio pungente, in una eterotopia accecante e brillante: vertigine dello stesso pensiero che si mostra in tutta la sua purezza. Di sala in sala si sente il colore dell’emozione che l’artista ha avuto in prima persona guardando la vita, di parete in parete ci si perde in un cosmo dominato dalla diastemia temporale, di spazio in spazio si gusta l’assenza della presenza, l’accento di una vocale che rincorre un segno di luce, l’accenno a un cosmico sapore di sapere.
Alba (1967), Trittico (1975), parti del ciclo denominato Organo (1980), La stria che dal mare (1986), Viaggio nel sogno (1987), Sogno nel sogno (1991) e alcuni pezzi dal ciclo Misura della memoria (2012) sono piccole parti di una straordinaria azione semiotica, di un discorso poetico affidato alle immagini, al segno che si compone e che affiora come un pensiero muto, aperto alla pagina e proteso oltre i bordi del tempo per condividere la quiete di una solitudine attenta a decifrare, a conoscere il mondo mediante le tonalità profonde del blu, «del sovrasensibile» (Kandinsky): «quando io adopero il blu non penso al mare, non penso al cielo. […]. Il blu è un colore versatile, un colore che mi permette tutte le sfumature che voglio. […]. Il blu è un’astrazione, un pensiero».





condividi