La critica istituzionale
Il nome e la cosa
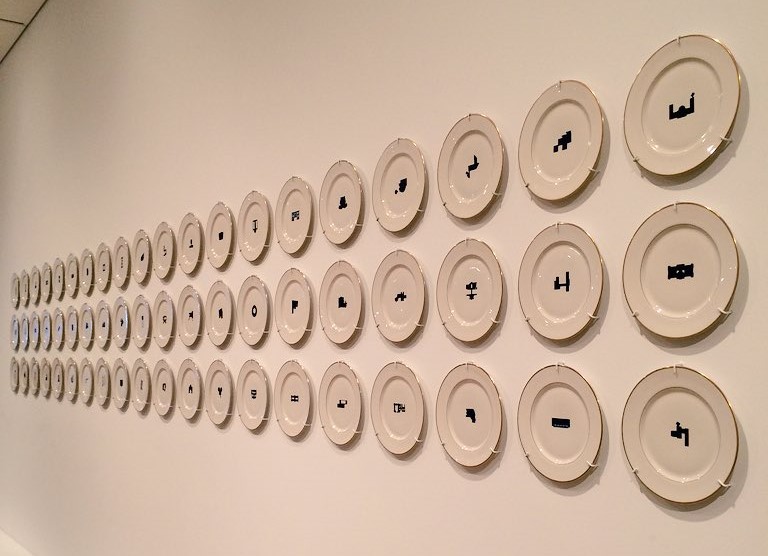
Esce in questi, per ombre corte, il saggio di Stefano Taccone dal titolo «La critica istituzionale. Il nome e la cosa». Con la prefazione di Stefania Zuliani, il volume analizza oltre quarant’anni di pratiche e studi, costruendo un documentato itinerario critico che giunge fino agli anni più recenti, in cui l’attenzione per la critica istituzionale si è riaccesa. Per l’occasione pubblichiamo il primo capitolo dal titolo «Dalla critica dell’istituzione arte alla critica istituzionale», ringraziando l’editore e l’autore per la collaborazione.
***
In un celebre passaggio dei Quaderni dal carcere, Gramsci sostiene che “la crisi consiste appunto nel fatto che il vecchio muore e il nuovo non può nascere”. Gli anni centrali del decennio Settanta sono ancora notoriamente percepiti come un periodo di generale crisi a partire innanzi tutto dall’aspetto economico, prima ancora che da quello culturale, eppure nulla come questa definizione gramsciana sembra confarsi maggiormente nel descrivere quella che è la situazione della cultura e, più specificamente, delle arti visive in quel periodo, almeno per noi che possediamo il vantaggio di osservare il tutto da una certa distanza cronologica. Tutte le neoavanguardie ormai hanno conosciuto la loro epifania e si preparano a consolidare le loro posizioni nella narrazione storico-artistica. Esse sono in quel momento il volto del presente dell’arte, ma già non più il presente dell’arte nel suo farsi. Contemporaneamente sono ancora in incubazione e perciò non ancora visibili tutte quelle tendenze che, con i critici di “October”, potremmo considerare espressioni del postmodernismo neoconservatore – la pittura neoespressionista nelle sue varie declinazioni nazionali – o del postmodernismo di resistenza – le tendenze appropriazioniste e di critica della rappresentazione più in generale.
È in questo clima di peculiare sospensione tra il non più e il non ancora che viene alla luce quello che, malgrado le numerose, e non prive di fondamento, confutazioni rivolte a certe sue rigidità, che lo accompagnano fin dalla sua apparizione1 (1974), resta uno dei tentativi più lucidi di lettura totale del fenomeno dell’avanguardia, Teoria dell’avanguardia del critico letterario tedesco Peter Bürger. Egli parte da “alcuni assunti metodologici fondamentali, che Marx formula nell’Introduzione ai Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, ovvero il legame tra possibilità di progresso della conoscenza e sviluppo dell’oggetto al quale si volge la conoscenza stessa, per trasporli sostanzialmente nel campo dell’arte. Se il pieno dispiegamento dell’arte – “condizione di possibilità di un’adeguata conoscenza dell’oggetto stesso” – si raggiungerebbe infatti storicamente”nella società borghese solo con l’estetismo”2, gli autentici soggetti della sua autocritica sarebbero le avanguardie storiche3. Esse infatti – questa la tesi centrale del discorso di Bürger – “non negano una precedente impronta dell’arte (uno stile), ma l’istituzione arte in quanto qualcosa di separato dalla vita concreta degli uomini”, né per questo pensano che l’arte “deve essere semplicemente distrutta, ma trasposta nella vita concreta dove si conserverebbe, anche se in forma trasformata”4.
Ma cosa intende Bürger per istituzione arte? E qual è il giudizio di cui la sua teoria, sempre muovendosi all’interno della categoria di istituzione arte, investe il fenomeno delle neoavanguardie? È infatti a partire da un più o meno ideale confronto-contrapposizione con il suo pensiero circa l’una e le altre che può narrarsi lo sviluppo tanto delle teorie attraverso le quali sorge e si precisa il concetto di critica istituzionale, quanto della sua pratica stessa, che vede come soggetti gli artisti.
Circa il primo quesito è lo stesso Bürger a toglierci dal rischio di ogni arbitrio interpretativo, allorché scrive chiaramente che con istituzione arte “si deve intendere sia l’apparato della produzione e della distribuzione artistica, sia le concezioni dell’arte che dominano in una determinata epoca e che determinano in modo essenziale la ricezione delle opere”. Le avanguardie condurrebbero un attacco che investe sia l’una che l’altra accezione, rivolgendosi “sia contro l’apparato di distribuzione, al quale l’opera artistica è subordinata, sia contro lo status dell’arte definito nella società borghese dal concetto di autonomia”5.
Ancora più limpido è il suo argomentare sulla questione delle neoavanguardie:
Naturalmente vi sono ancora tentativi di portare avanti la tradizione dei movimenti d’avanguardia […]; ma questi tentativi, come per esempio gli happening, che si potrebbero definire neoavanguardia, non possono più raggiungere il valore di protesta delle manifestazioni dadaiste, indipendentemente dal fatto che siano organizzati e realizzati meglio di quelle. La cosa si spiega in una certa misura per il fatto che i mezzi usati dagli artisti d’avanguardia per ottenere un certo effetto hanno nel frattempo perso una parte notevole del loro potenziale di shock. Ma forse il fatto determinante è che il programma avanguardistico di superamento e riconversione dell’arte nella vita pratica non ha avuto sostanziale attuazione. Perseguire gli intenti avanguardistici con gli stessi mezzi impiegati dalle avanguardie non può più in un mutato contesto produrre quel preciso effetto raggiunto dalle avanguardie storiche. Nella misura in cui i mezzi, in virtù dei quali gli artisti delle avanguardie speravano di ottenere il superamento dell’arte, hanno nel frattempo conseguito il rango di opera d’arte, non si può più pensare con il loro impegno di rendere vincolante la pretesa di un rinnovamento della vita pratica. In termini più precisi: la neoavanguardia istituzionalizzando l’avanguardia come arte, nega i più genuini intenti avanguardistici. […] L’arte neoavanguardista è arte autonoma nel senso pieno del termine, perché nega gli intenti avanguardistici di una riconversione dell’arte in prassi vivente6.
Non è questione, almeno per il momento, di interrogarci sul grado di condivisibilità di tali valutazioni. Basta osservare che se in Bürger le neoavanguardie sono “arte autonoma nel senso pieno del termine” e, soprattutto, la critica dell’istituzione arte – anche nella prima delle due accezioni, quella che più sembra avvicinarsi alla prassi propria della critica istituzionale – è completamente appannaggio delle avanguardie storiche, si è indotti a sospettare che episodi come la rimozione del grande stendardo di Buren dalla mostra collettiva del Guggenheim di New York nel 1971 o la cancellazione della retrospettiva di Haacke ad opera dello stesso museo e nel medesimo anno, ovvero i due episodi più emblematici del valore destabilizzante della critica istituzionale, o sono a lui sconosciuti o sono da lui reputati, quasi in un’ottica di derealizzazione baudrillardiana, espressioni di una falsa, apparente conflittualità. Ma per ora su tutto questo sospendiamo il giudizio.
Ciò che tanto più induce a ricercare invano in Teoria dell’avanguardia un sia pur minimo segno di coscienza della critica istituzionale è proprio l’assonanza di quest’ultima con l’espressione “critica dell’istituzione arte”, che ai nostri orecchi di posteri suggerisce facilmente l’ipotesi che costituisca una sorta di progenitore prossimo della denominazione di critica istituzionale – o la tentazione di interpretarla così –, per quanto non esista alcuna prova sufficientemente fondata sulla derivazione diretta della prima dalla seconda.
L’espressione critica istituzionale “usata per descrivere la pratica artistica politicizzata della fine degli anni Sessanta e dei primi anni Settanta”7 compare invece per la prima volta, secondo Alexander Alberro, nel 1975 – e dunque a un solo anno di distanza dal saggio di Bürger – in un testo pubblicato sulla rivista “The Fox” dall’artista concettuale inglese Mel Ramsden, membro del collettivo Art & Language di cui la stessa “The Fox” è espressione. “Intrattenersi perennemente su di una critica istituzionale (il corsivo è mio) senza rivolgersi a specifici problemi nelle istituzioni”, scrive ad un tratto Ramsden, “significa generalizzare e declamare slogan. Essa può anche produrre la sfortunata conseguenza di affermare ciò che si predispone per criticare. Essa può anche agire come una barriera per elaborare eventualmente una pratica comunitaria (linguaggio… socialità…) che non incarna solo una modalità mercificata di esistenza. Non intendo, cioè, semplicemente reiterare le logiche della società attuale e affermare le gerarchie di mercato”8. Nel contesto di un discorso che, partendo dalla presa d’atto che “amministratori, mercanti, critici, esperti etc., i quali un tempo sembravano i neutrali servitori dell’arte, ora, specie a New York, sono divenuti i suoi padroni”9, individua quindi la possibilità di una “trasformazione radicale” solo nello sviluppo di “una serie di iniziative che, lavorando in sinergia l’una con l’altra, altereranno la ormai così tanto interiorizzata mentalità carrierista” e, più nello specifico, di “una comunità – una base dalla quale le caratteristiche tipiche del mercato, come l’individualismo, possano essere distrutte e possa essere prodotta un’arte che eccede i limiti dell’inquadramento istituzionale”10 –, il concetto di critica istituzionale non designa evidentemente ancora una tendenza ben precisa e determinati artisti che ne facciano parte, ma tutt’al più una attitudine. Esso sembra osservato inoltre in una ottica più che altro negativa, come uno strumento che rischia costantemente, a causa della sua indisponibilità a spingersi più a fondo nella critica ed elaborare conseguentemente alternative, di fare il gioco proprio del soggetto che si intende attaccare.
Curioso constatare come tale giudizio non si riveli troppo distante da quello riservato ad Haacke, alla cui opera Ramsden si dichiara interessato,
benché essa tenda ad alludere alla politica come a un genere di argomento alienato. Egli ci presenta, cioè, sempre la “politica” di altre persone (Amministratori del Guggenheim etc.). Ma io ho una questione più seria: se siamo d’accordo sul fatto che dobbiamo attaccare inesorabilmente l’imperialismo artistico, poi, in quanto assalto, diviene ampiamente una faccenda di tattiche. O, piuttosto, le nostre tattiche dovrebbero incarnare alternative […]; questo significa che la “teoria critica” deve essere informata da una (prospettiva di) “critica radicale”. Ora fare “arte” a partire da una critica dell’attuale potere senza farla dal punto di vista di un’alternativa mi sembra carrierismo opportunistico e quanto meno affettato. In ogni caso è fondamentalmente impossibile11.
Accuse peraltro rivolte un attimo prima anche a Daniel Buren: “Penso che parte della sua pratica sia finalizzata a ottenere vantaggi (una caccia all’affare) per se stesso, suppongo che egli stia facendo sì che il potere del Kunstwelt guadagni attenzione”12.
Bisogna attendere i primi anni Ottanta (1982) per trovare finalmente associate con puntualità le pratiche che più comunemente si riferiscono alla critica istituzionale con i quattro artisti canonicamente ascrivibili a essa, allorché Benjamin Buchloh, in un saggio pubblicato su “Artforum” che, sulla scorta delle teorie di Walter Benjamin, rilegge la storia novecentesca delle pratiche del montaggio e dell’appropriazione alla luce delle categorie di merce ed allegoria, parla delle “analisi sul luogo e sulla funzione storica delle costruzioni estetiche compiute da Buren e Asher” e delle “operazioni che rivelano le condizioni materiali di queste istituzioni come ideologiche compiute da Haacke e Broodthaers”13. Benché la tendenza non abbia ancora un nome, le basi per la sua invenzione storiografica appaiono così pienamente gettate.
Su di esse solo tre anni dopo (1985) l’allora non più che ventenne artista Andrea Fraser – che non a caso si forma in quegli anni, tra l’altro, proprio seguendo i corsi di Buchloh – imposta il suo saggio per “Art in America” dedicato alla più anziana collega Louise Lawler, sostenendo che il suo “Impegno nella determinazione e l’acculturazione istituzionale dell’arte può essere fatto risalire alle avanguardie storiche – Duchamp, dada e surrealismo, da una parte, l’avanguardia sovietica dall’altra”, ma possiede una relazione più immediata
con le pratiche post-studio degli anni Settanta, in particolare con l’opera di Michael Asher, Marcel Broodthaers, Daniel Buren e Hans Haacke. Benché molto differenti, tutti questi artisti si impegnano (si impegnavano) nella critica istituzionale (il corsivo è mio), che va dalle costruzioni (o decostruzioni) situazionali di contesti architettonici in gallerie e musei di Asher e Buren alla direzione di un museo fittizio di Broodthaers e alle documentazioni delle affiliazioni aziendali dell’arte di Haacke14.
L’artista americana, poi riconosciuta e riconosciutasi come esponente della seconda generazione della critica istituzionale, sembra così precisare e consolidare l’intuizione già avanzata dal suo professore, adoperando anche, a differenza di quest’ultimo, l’espressione critica istituzionale in una modalità che, benché ancora apparentemente designante un’attitudine più che una tendenza artistica e significativamente scritta in minuscolo, acquista un valore semantico decisamente più preciso di quello posseduto dieci anni prima in Ramsden.
L’etichetta critica istituzionale, se dobbiamo prestar fede alla testimonianza che si può evincere da un altro saggio della Fraser che appare su “Artforum” esattamente venti anni dopo (2005) – costituendo un po’ il passaggio obbligato per tutti i dibattiti su tale fenomeno che si sono sviluppati nel primo decennio del nuovo millennio –, non viene adottata comunque a partire da un determinato scritto, né, del resto, è possibile individuare coordinate cronologiche troppo dettagliate circa il momento dopo il quale entra in voga:
Avendo studiato sia con Buchloh che con Craig Owens, che pubblicò il mio saggio sulla Lawler, penso sia possibile che uno di loro si sia lasciato sfuggire l’espressione “Institutional Critique”. È anche possibile che a metà degli anni Ottanta i loro studenti della School of Visual Arts e del Whitney Indipendent Study Program (dove insegnavano anche Haacke e Martha Rosler) – compresi Gregg Bordowitz, Joshua Decter, Mark Dion e io – abbiano cominciato a utilizzare il termine come abbreviazione di critique of the institutions (“critica delle istituzioni”) durante le nostre discussioni a fine lezione. Non c’era occorrenza precedente del termine, ed è curioso pensare che il canone che noi credevamo di recepire si fosse formato in realtà proprio a quell’epoca15.
Alla fine del decennio Buchloh sviluppa con più ampio respiro i cenni alla critica istituzionale contenuti nel saggio sul montaggio e l’appropriazione, ma neanche questa volta ne parla come tendenza a sé stante, bensì la ingloba nella storia dell’arte concettuale, pur considerandola una sorta di sovversione rispetto all’arte concettuale propriamente detta, anche perché l’occasione è data dalla mostra L’art conceptuel: une prospective del Musée d’Art moderne de la Ville de Paris (1989), per il cui catalogo16 scrive un testo poi ripubblicato in una nuova versione l’anno successivo (1990) su “October”. Benché premetta che l’arte concettuale annovera tra le sue fila una “vasta gamma di posizioni spesso confliggenti”17, egli descrive la sua vicenda come una parabola che dall’ “estetica dell’amministrazione”, ovvero dalla “rigorosa soggezione mimetica dell’esperienza estetica ai principi di ciò che Adorno chiamava il mondo totalmente amministrato”18 che gli artisti concettuali adottano, giungerebbe alla “critica delle istituzioni”, espressione con la quale intende
un riconoscimento che materiali e procedure, superfici e strutture, luoghi e collocazione non sono solo una questione pittorica o scultorea da affrontare nei termini di una fenomenologia dell’esperienza visiva e cognitiva o in termini di analisi strutturale del segno (come molti artisti minimalisti e postminimalisti hanno ancora creduto), ma che essi sono sempre già inscritti nelle convenzioni del linguaggio e quindi nel potere istituzionale e nell’investimento ideologico ed economico19.
Mentre il primo stadio è quello proprio di artisti come Robert Morris o Joseph Kosuth, il secondo, “che appare ancora meramente latente” in Lawrence Weiner e Robert Berry alla fine degli anni Sessanta, “diviene molto rapidamente manifesto nell’opera di artisti europei della stessa generazione, in particolare quella di Marcel Broodthaers, Daniel Buren e Hans Haacke dopo il 1966” – per il momento Asher, già presente invece accanto a questi ultimi tre nel saggio di Buchloh del 1982, è estromesso dal canone. “Infatti una critica istituzionale (il corsivo è mio) diviene l’epicentro degli attacchi di tutti e tre gli artisti alla falsa neutralità della visione che offre il sottostante fondamento logico per quelle istituzioni”20.
Buren parte – “come i suoi colleghi americani” – “da una investigazione critica del minimalismo”, ma “la sua precoce comprensione dell’opera di Flavin, Ryman e Stella lo rese rapidamente capace di sviluppare posizioni dall’interno di una analisi strettamente pittorica che portò presto a una inversione dei concetti pittorici/scultorei dell’intera visualità”. Egli determina così l’incontro tra “una revisione critica dell’eredità della pittura tardomodernista (e americana del dopoguerra)” e “un’analisi dell’eredità di Duchamp, cui guarda criticamente in quanto inaccettabile negazione della pittura” ed è proprio “questa particolare lettura di Duchamp e del readymade come atto di radicalità anarchica piccolo-borghese” a garantirgli il successo nella critica speculare di due per certi versi antitetiche tradizioni. Compiendo “una analisi sistematica degli elementi costitutivi del discorso della pittura, Buren andò a investigare tutti i parametri della produzione e ricezione artistica”. Un “cambiamento di superfici di appoggio e procedure di produzione” che conduceva tanto “a un’ampia gamma di forme di distribuzione” – “dalla tela distesa ai fogli di carta con strisce stampate spediti anonimamente; dalle pagine nei libri ai tabelloni” -, quanto a “uno spostamento dei luoghi tradizionali di intervento artistico e di lettura” concretizzantesi “in una molteplicità di luoghi e forme di esposizioni che giocavano continuamente sulla dialettica di interno ed esterno, oscillando così nelle contraddizioni della scultura e della pittura e ponendo in primo piano tutti quei nascosti e manifesti dispositivi di inquadramento che strutturano le tradizioni nel discorso sia del museo che dello studio”21.
Se Buren e Haacke “dalla fine degli anni Sessanta in poi rigettarono la violenza di quella relazione mimetica sull’apparato ideologico stesso, adoperandolo per analizzare ed esporre le istituzioni sociali da cui le leggi della strumentalità e la logica dell’amministrazione emanano in primo luogo”, spetta “a Broodthaers costruire oggetti in cui le realizzazioni radicali dell’arte concettuale sarebbero trasformate in parodia diretta”. Egli le scopre nel loro
intricato legame con una profonda e irreversibile mancanza: una mancanza non causata dalla pratica artistica, naturalmente, ma alla quale quella pratica rispondeva nel pieno ottimismo delle sue aspirazioni, evitando di riconoscere che la purificazione dell’immagine e del talento, della memoria e della visione, nella rappresentazione estetica visiva non era solo un altro eroico passo del progresso irreversibile dell’Illuminismo verso la liberazione del mondo dalle forme mitiche di percezione e dai modelli gerarchici dell’esperienza specialistica, ma anche un’altra, forse l’ultima (e forse quella più reale e devastante), delle erosioni a cui la sfera tradizionalmente separata della produzione artistica era stata soggetta nei suoi continui sforzi di emulare l’episteme dominante nel contesto paradigmatico proprio dell’arte stessa22.
È chiaro che tale operazione di sostanziale generazione della critica istituzionale da una costola dell’arte concettuale, ma condotta in maniera tale da implicare finalmente una profonda svalutazione degli esiti storici dell’arte concettuale stessa, non può che essere mal tollerata da personaggi emblematici di tale tendenza come Kosuth – al di là dei pur pesanti attacchi alla sua opera specifica di cui il saggio abbonda. Egli, nella sua lettera di replica per il catalogo della mostra parigina, poi ripubblicata nel 1991 su “October” con una piccola aggiunta già presente nella seconda edizione del catalogo, accusa Buchloh di “aver squalificato se stesso una volta e per tutte” producendo “un comunicato stampa per una cricca di amici” più che uno studio seriamente approfondito sul piano storico. “Al fine di isolarmi e bandirmi come un modernista”, chiarisce l’artista,
il signor Buchloh semplicemente arresta la disamina sulle mie attività nel momento in cui esse possono essere favorevolmente comparate con l’opera dei suoi amici sulla questione della “critica istituzionale”. Il periodo che va da The Second Investigation passando per il periodo di “The Fox” – gli anni coperti da questa mostra – è completamente assente. Nel contempo, il signor Buchloh prende intuizioni, terminologia e persino una agenda filosofica da questo mio testo iniziale e lo adatta nel processo di validazione dell’opera che vuole supportare. Egli vorrebbe farti credere, caro lettore, che la “critica istituzionale”, che egli ascrive solo all’opera dei suoi compagni, venga fuori dal nulla e potrebbe essere fatta così senza il beneficio di questo primo scritto e dell’opera che andava con esso23.
Né può condividere tale versione dei fatti Seth Siegelaub, mercante e promotore simbolo degli anni eroici dell’arte concettuale americana, la cui replica appare per la prima volta nella seconda edizione del catalogo della mostra e poi su “October” insieme a quella di Kosuth, che muove invece a Buchloh innanzi tutto un’accusa che, per un critico marxista e attento alle implicazioni storiche e sociali, quale egli si ritiene, non può che risultare assai infamante, bollando la sua ricostruzione storica come “formalistica e idealistica”, giacché “è difficile immaginare come si possa trattare questo periodo senza menzionare, anche in una incidentale nota a piè di pagina, per esempio il Maggio ’68 o la guerra degli Stati Uniti in Vietnam”. La considera inoltre “riduttiva per un’altra ragione ancora: per lui l’arte concettuale è fondamentalmente una storia di ciò che egli pensa accada a Manhattan tra la Ventitreesima Strada e Canal Street”, fattore ancor più inspiegabile se si considera che a quel tempo Buchloh vive proprio in Europa24.
La controreplica di Buchloh, contenuta nello stesso numero di “October”, non è meno dura. L’autentico obiettivo del disappunto di Kosuth gli appare il consolidamento del
suo territorio e status contro il sia pur minimo cenno di dubbio critico con una confutazione completamente sproporzionata, uno sciopero di deterrenza, per così dire, che risolverebbe le questioni una volta e per tutte e indurrebbe critici futuri a pensarci due volte circa anche il desiderare di porre una domanda o due. Inoltre – e paradossalmente – sembra che egli non possa resistere alla tentazione di mostrare ancora una volta il suo status di maestro con il dispiegare il potere istituzionale del museo per organizzare una rappresaglia pubblica simile al famoso affare del Guggenheim, quando diede inizio, insieme ad altri, alla censura dell’opera di Daniel Buren dalla Mostra Internazionale del Guggenheim nel 1971.
Una censura nella quale Kosuth ha effettivamente la sua parte di responsabilità, benché ampiamente condivisa. A proposito di Siegelaub osserva invece innanzi tutto che il suo saggio è stato in grado di svegliarlo “dal suo storico sonno”, alludendo alla sua “esclusiva identificazione con un particolare momento della produzione artistica” da cui deriverebbe il “fallimento nel riconoscere ogni altra attività in quel momento, per non parlare dello sviluppo dell’opera di una generazione seguente”. Il rilievo sull’omissione del contesto storico viene poi liquidato come espressione del “determinismo meccanicistico che Siegelaub considera essere dialettico”, mentre a quello sulla riduzione del raggio di analisi agli Stati Uniti oppone la domanda retorica: “La parte finale del saggio non ha effettivamente a che fare con le risposte critiche europee ai miti dell’arte concettuale nell’opera di Marcel Broodthaers, Daniel Buren e Hans Haacke, per esempio?”25.
Se l’area della critica istituzionale appare così ormai nitidamente individuata da un “amico” degli artisti in essa implicati come Buchloh, ad adoperare l’espressione come tendenza piuttosto che come attitudine sembra piuttosto il “nemico” Kosuth. In ogni caso, a partire dagli anni Novanta la coscienza della critica istituzionale come tendenza a sé stante può considerarsi un fatto acquisito.
Note
| ↩1 | Cfr. almeno Martin Lüdke (a cura di), Theorie der Avant-garde. Antworten auf Peter Bürgers Bestimmung von Kunst und bürgerlicher Gesellschaft, Suhrkamp Verlag, 1976; Benjamin Buchloh, Teorizing the Avant-Garde, in “Art in America”, 72, 10, November 1984. |
|---|---|
| ↩2 | Peter Bürger, Theorie der Avant-garde (1974) trad. it. Teoria dell’avanguardia, a cura di Riccardo Ruschi, Bollati Boringhieri, 1990, p. 22. |
| ↩3 | Ivi, p. 28. |
| ↩4 | Ivi, p. 59. |
| ↩5 | Ivi, p. 28. |
| ↩6 | Ivi, p. 68. |
| ↩7 | Alexander Alberro, Institutions, Critique, and Institutional Critique, in Alberro e Blake Stimson (a cura di), Institutional Critique: An anthology of artists’ writings, The MIT Press, 2009, p.8. Dove non diversamente indicato le traduzioni sono mie. |
| ↩8 | Mel Ramsden, On practice, in “The Fox”, 1, 1975, ora anche in Alberro e Stimson (a cura di), Institutional Critique, cit., p. 176. |
| ↩9 | Ivi, p. 170. |
| ↩10 | Alberro, Institutions, Critique, and Institutional Critique, in Alberro e Stimson (a cura di), Institutional Critique, cit., p. 8. |
| ↩11 | Ramsden, On practice, cit., p. 192. |
| ↩12 | Ibidem. |
| ↩13 | Benjamin Buchloh, Allegorical Procedures: Appropriation and Montage in Contemporary Art, in “Artforum”, 21, 1, September 1982, p. 48. |
| ↩14 | Andrea Fraser, In and out of place, in “Art in America”, 73, 6, June 1985, ora anche in Alberro e Stimson (a cura di), Institutional Critique, cit., p. 293. |
| ↩15 | Andrea Fraser, From the Critique of Institutions to an Institution of Critique, in “Artforum”, 44, 1, September 2005, trad. it. di una versione leggermente modificata dall’artista stessa in Stefano Chiodi, a cura di, Le funzioni del museo. Arte, museo, pubblico nella contemporaneità, Le Lettere, 2009, p. 79. |
| ↩16 | Suzanne Pagé, et al., L’Art conceptuel, une perspective, cat. de l’exp., Musée d’art moderne de la Ville de Paris, 22 Novembre 1989-18 Février 1990. |
| ↩17 | Benjamin Buchloh, Conceptual Art 1962-1969: From the Aesthetic of Administration to the Critique of Institutions, in “October”, 55, Winter 1990, p. 105. |
| ↩18 | Ivi, p. 143. |
| ↩19 | Ivi, p. 136. |
| ↩20 | Ivi, pp. 136-137. |
| ↩21 | Ivi, pp. 137-139. |
| ↩22 | Ivi, p. 143. |
| ↩23 | Joseph Kosuth e Seth Siegelaub, Joseph Kosuth and Seth Siegelaub Reply to Benjamin Buchloh on Conceptual Art, in “October”, 57, Summer 1991, p. 153. |
| ↩24 | Ivi, p. 155. |
| ↩25 | Benjamin Buchloh, Benjamin Buchloh Reply to Joseph Kosuth e Seth Siegelaub, in “October”, 57, Summer 1991, , pp. 158-161. |





condividi