Sull’esitare
È possibile diventare gatti?
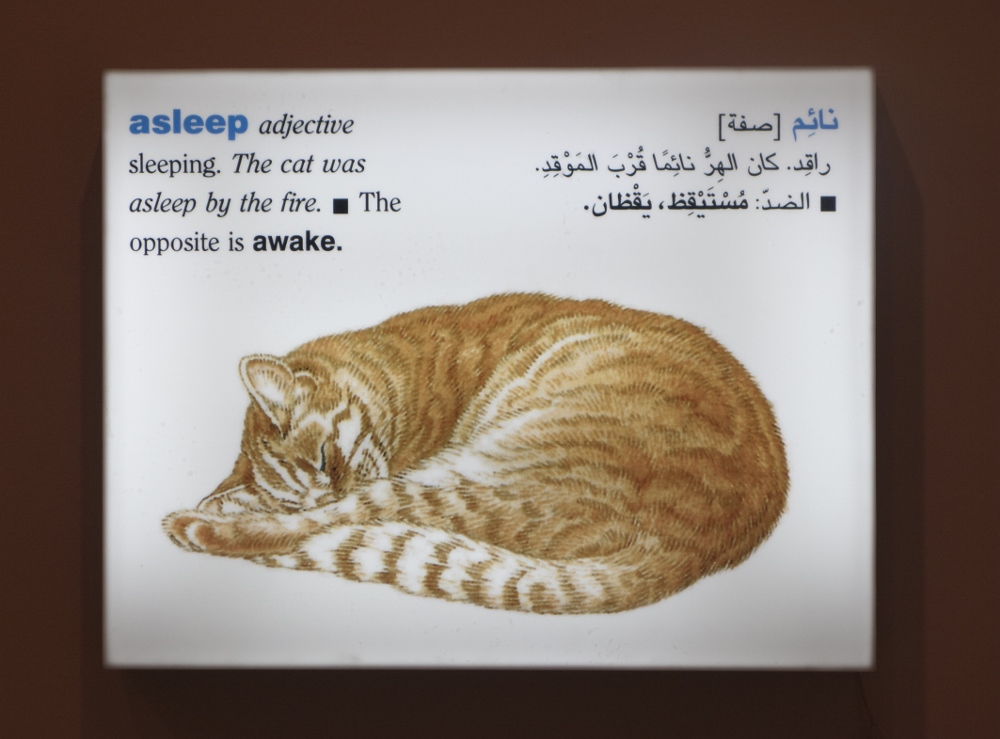
Cosa hanno in comune il gatto della mia vicina, Philippe Petit e Steph Curry? Questo: non esitano. Partiamo dal gatto. Oggi il gatto della vicina cammina placido e tranquillo sul margine superiore della ringhiera del balcone: una fettuccia di poco più di un paio di centimetri di ferro stondato che sovrasta quattro piani. Lui cammina, si ferma, osserva, guarda di sotto, riprende il cammino. Il volto è curioso ma placido. Solo la coda mostra una postura tesa, attenta, guardinga, all’erta, all’insaputa del gatto verrebbe da dire. La sapienza e la tensione sono tutte della coda.
Philippe Petit è un celebre umano che nella notte tra il 5 ed il 6 agosto del 1974 tese con alcuni complici un cavo di acciaio fra i tetti delle due Torri Gemelle allora splendidamente svettanti nello skyline newyorkese e all’alba, proprio come il gatto della vicina, prese a passeggiare sul filo con il solo aiuto di un bilanciere, avanti e dietro per molte volte dalla torre nord alla torre sud. L’arrivo delle forze dell’ordine non lo scompose, lui continuò a passeggiare a sazietà per poi concedersi al glorioso arresto.
Steph Curry, invece, è un giocatore di pallacanestro, certamente uno dei più forti al mondo, attualmente in attività ma nondimeno nella storia di questo sport, gioca nel campionato NBA nella squadra dei Golden State Warriors. In una recente clip che ha girato sul web è possibile vedere questo giocatore che infila 103 canestri consecutivi da una distanza di circa 7 metri (che nel basket attribuisce il valore di 3 punti al canestro). Una macchina ipnotica, incantata, ripetitiva. 103 volte perfetta.
Il gatto, si diceva, può fare quello che fa perché non esita e se il gatto non esita non è perché ha una dote particolare, semplicemente non sa esitare. Una buona definizione di gatto (di animale in generale) potrebbe essere «vivente non esitante». Evidentemente il rischio di cadere di sotto e morire, e di procurare dolore alla sua padrona, la vertigine delle altezze, la sconsiderata pericolosità dell’atto, il vissuto di onnipotenza che deriva dalla riuscita di una prodezza così ardita, i vantaggi economici, relazionali, sociali, affettivi e sessuali che questa giocata da fuoriclasse determinerebbero, non abitano il gatto. Non lo premono, non lo strattonano, non emozionano e non disturbano il gatto. Il gatto può fare questa prodezza non grazie a una virtù di cui dispone, ma grazie a una virtù di cui non dispone. Quindi diciamolo: caro gatto non hai alcun merito. La tua prodezza è l’esito dell’essere ottuso, ottuso nel senso acustico: non ti risuona nulla.
Petit e Curry per fare le loro prodezze devono diventare gatto, devono non esitare laddove una buona definizione di umano è «vivente che esita». Ma di che pasta è fatta allora l’esitazione umana? L’esitazione nasce dal fatto che l’umano per sua natura si disturba e per disturbarsi occorre essere in due, il disturbante ed il disturbato. L’automa/gatto non si lascia disturbare dalle chiacchiere. Prevedo, temo, mi osservo, faccio ipotesi, mi immedesimo, mento, simulo, dissimulo, interpreto, attribuisco, anelo, rinuncio, ricordo (anzi, no: rievoco), trasgredisco, fantastico, mi incoraggio, mi dissuado, mi ingolosisco, mi consolo, disprezzo, scelgo. Un mare di pratiche che spalmano l’uomo in un lasso di tempo che eccede e precede quell’immarcabile puntino di presente che è il puntino perfetto su cui il gatto poggia sicuro la sua zampetta sulla ringhiera, Petit il suo piede sulla fune e Curry rilascia la palla dal suo polpastrello. Quel puntino preciso in cui l’umano non esita, ma coincide con sé; perché coincide con sé.
La lista delle pratiche sopra evocate oltre ad essere allungabile praticamente all’infinito, presenta un’altra sorprendente dote. Al di sotto dei significati espliciti, manifesti e condivisi che quei verbi esprimono, essi si allacciano in un caotico intreccio in cui tutto può significare tutto, l’uno può significare l’altro e il suo opposto. Un luogo dove il principio di non contraddizione è inghiottito in un sabba equivoco e ambivalente. E più l’uomo è emozionato, più questo sottobosco fa baccano e da segni di sé. «Inconscio» è un accettabile nome di questo luogo, mentre la stoffa da cui sono ritagliate (e di cui sono fatte) tutte le pratiche descritte (e infinite altre) è detta «linguaggio». Quindi l’ultima riga dell’equazione di questo ragionamento dice: il gatto non ha un dispositivo (il linguaggio) per questo non è disturbato e per natura non esita. L’uomo ha invece in dote il dispositivo linguistico che lo divide in due (tanto da poter sostenere, prodezza questa inaccessibile al gatto, «Io sono io») e lo rende manchevole, intempestivo, indeciso, esitante. L’inconscio è il velenoso prodotto di scarto di questo dispositivo. La pratica del linguaggio, cifra di umanità, è perdita di naturalezza, è pura esitazione.
«Coscienza significa esitazione». È Henri Bergson il filosofo dell’esitazione e Federico Leoni a pagina 128 del suo recente volume dedicato al filosofo francese e pubblicato da Feltrinelli ne riepiloga il senso con un singolare ribaltamento dell’ordinaria, freudiana, natura dell’inconscio. Scrive Leoni:
È questa la radice prima di quell’impossibilità, per la coscienza, di cogliere il momento giusto, di eseguire perfettamente quanto richiesto. La vita della coscienza Bergsoniana si svolge tutta nel segno di questa nevrosi strutturale. In altri termini, Bergson percorre un’ipotesi capovolta rispetto a quella di Freud. L’uomo è nevrotico non perché l’attività della coscienza sia screziata dalle illusioni dell’inconscio, ma perché la vita inconscia dell’automa è turbata dalle petulanti incursioni della coscienza.
Se Petit e Curry passano alla storia, se le loro prodezze fanno collassare di stupore la mandibola ed esclamare la domanda infantile ma come fa’, è perché, sia detto con lo strillo del buttadentro del circo, sono uomini che sanno diventare gatti e per questo fanno cose fenomenali, circensi. Non sono disturbati dal linguaggio e dal suo velenoso resto, l’inconscio. È questo il passaggio più intrigante della storia. Che tipo di gatto diventano? Come fanno a diventare gatto? Lo diventano a comando o lo sono? O forse si limitano a creare le condizioni perché s’inneschi l’incantesimo del diventare gatto? È allenabile il diventare gatto? Come silenziano il linguaggio con il quale si disturbano, dal momento che due secoli di filosofia ci hanno spiegato che silenziare il linguaggio sarebbe come chiedere a un polmone vivo di non respirare, a un cuore vivo di non battere?
Dobbiamo immaginare che Petit e Curry hanno in dote un dispositivo mal localizzabile che genera aree immuni, impenetrabili al baccano, dove essi diventano e restano a lungo, gatti. Intendiamoci, tutti gli uomini in molti momenti della giornata sono convocati alla non esitazione e spesso ci riescono; anche un dentista, un pittore, un pasticciere, un chirurgo, insomma tutti coloro che pagherebbero (e farebbero pagare) cara o con conseguenze irreparabili la propria esitazione, devono saper non esitare proprio mentre il coro tuona: «Vietato esitare!». La faccenda ricorda una di quelle sfide infantili («Facciamo a chi ride prima?», «Non pensare ad un elefante!») perché nulla fa esitare di più di un’istanza, interna o esterna che ti convoca a non esitare.
Se proviamo una scomposizione al rallenti di queste prodezze troviamo biblioteche di neurofisiologia e cento anni di psicoanalisi, soprattutto nel suo pulviscolo fatto di lapsus ed atti mancati ma è solo un esercizio bisbetico che non coglie il punto, come prendere un pezzetto della tela della Gioconda per vedere la sua composizione e allora, per tenerla leggera, direi che si tratta di narrare la delicata relazione tra desiderio e riuscita nell’animale esitante, cioè parlante, cioè umano.
È allenabile il talento umano di diventare gatti? Viene in mente la replica del portiere di calcio che, allo studioso di fisica che gli dimostrava, calcoli alla mano, che parare un rigore è pura fortuna perché la reattività neurofisiologica è sempre più lenta della velocità del tiro, disse: «sarà, ma di certo, più mi alleno a parare rigori e più ho fortuna». Allora se ne deduce che le grandi prodezze, le grandi riuscite chiedono, sì, training, chiedono la lucidatura di automatismi con ripetizioni, prove ed errori infinite, ma se alla fine non ci si toglie di mezzo, per dirla con una espressione cara a Simone Weil e a molta tradizione mistica alle prese con la ben più ambiziosa ricerca di Dio, la prodezza non riesce e rimane aperta e pulsante solo la macchina dell’ossessione impantanata nel fuoco di artificio dell’esitazione e così la vita diventa un gigantesco allenamento fine a se stesso.
Al di là del talento di Curry e di Petit, la sfida che si presenta a ogni umano performante consiste nella capacità di calibrare e soprattutto armonizzare due momenti: allenarsi, studiare, impratichirsi e il togliersi di mezzo, silenziarsi al momento giusto. E comunque al tiro 104, Curry ha sbagliato. Un granellino di esitazione ha impacciato il suo polpastrello e lui è tornato fra noi, umani esitanti.





condividi