Under Conditions Not of Our Choosing
Thoughts One Can't Do Without

Il prossimo lunedì, 16 novembre, esce per Juxta Press il saggio breve di Andrew Ross, Under Conditions Not of Our Choosing, nella collana Thoughts One Can’t Do Without. L’assunto da cui parte Ross in questo scritto è che non abbiamo la possibilità di scegliere il tempo in cui viviamo, né le condizioni che determinano il nostro agire. Quali sono, allora, le nostre responsabilità nei confronti del mondo che ci è stato dato, non solo per interpretarlo e capirlo, ma anche per cambiarlo? Juxta Press è una nuova impresa editoriale ideata e diretta da Gabriele Guercio, insieme a Lucia Coco e Octavia Stocker. Il saggio, come molte pubblicazioni di Juxta Press, esce in lingua inglese, qui pubblichiamo un’anticipazione tradotta in italiano, ringraziando l’editore per la gentile concessione.
**
Nel corso degli anni, mentre scrivevo un libro, mi tornava in mente un’esperienza del passato, direttamente rilevante per l’argomento del libro stesso. Di frequente un tale ricordo riemerge abbastanza tardi nel processo di scrittura. La sua soppressione fino a quel momento suggerisce che l’esperienza ha modellato la scelta del tema e, inoltre, che il ritardo ha assicurato che una tale rivelazione non mettesse a repentaglio la narrazione. Il momento del ricordo giunge di solito come un’epifania, invitando così all’autoanalisi. Ma non ho mai ritenuto utile scrivere riguardo una tale personale stranezza – almeno sino ad ora.
Senza dubbio ciò a cui mi riferisco appartiene alla psicopatologia della scrittura, un campo di indagine che ha fornito un’infinità di materiale fertile per gli analisti critici del processo creativo. Negli ultimi anni della mia carriera, ho sviluppato un forte interesse per la psicoanalisi, perciò potrebbero esserci state più ragioni per riflettere su simili questioni. Ma una volta apprese le mie lezioni da Freud, ho deciso di “dimenticarle” così da poter vedere il mondo attraverso un’altra lente, meno indottrinata. Naturalmente i freudiani direbbero che è una cosa molto freudiana da fare, dal momento che lui, meglio di chiunque altro, aveva capito che la repressione è fondamentale per la nostra capacità di portare ordine e significato nel mondo. Abbiamo bisogno di dimenticare così tanto per poter fare qualcosa. Ma prima di andare avanti con questa linea di indagine, lasciatemi fare un esempio di ciò di cui ho appena parlato.
L’ultimo libro che ho pubblicato riguardava i lavoratori edili palestinesi in Cisgiordania. Come molti dei miei libri, anche questo era un prodotto di circostanze e non il risultato di un piano ponderato. I compagni di Decolonize This Place, il collettivo artistico-attivistico a cui appartengo, mi avevano invitato a collaborare alla realizzazione di un film in Cisgiordania. Alcune delle riprese richiedevano delle interviste a dei Palestinesi che attraversavano la Green Line per lavorare in Israele. Durante le riprese, sono rimasto colpito dallo spettacolo delle enormi cave di pietra nel paesaggio ondulato della Cisgiordania e ho dedotto, correttamente, che dietro di esse si celasse una ricca storia locale di lavorazione artigianale della pietra. Sarei poi anche venuto a sapere che le colline della Palestina che si vedono nei libri illustrati ospitavano alcune delle migliori pietre calcaree del mondo, e che l’industria della pietra era un vero e proprio pilastro dell’economia nazionale.
Nel libro, ho seguito il percorso della pietra e dei lavoratori, dalla cave attraverso le fabbriche e le officine, fino ai cantieri, la maggior parte dei quali si trovava all’interno degli insediamenti di Israele e della Cisgiordania. Ma ho anche provato a ricostruire la storia del contributo di lunga data dei lavoratori palestinesi all’ambito edificatorio. Essi hanno avuto un ruolo decisivo nella costruzione della maggior parte dei beni e delle terre “dal fiume al mare” che, oggi, comprendono Israele e i Territori Occupati. Anche molte nazioni del Medio Oriente hanno beneficiato della loro expertise con la pietra. I palestinesi in effetti hanno costruito quasi tutti gli stati della regione tranne, tragicamente, il proprio.
Ma di tutti gli argomenti che avrebbero potuto attirare il mio interesse in Palestina, che cosa mi ha spinto in primo luogo verso questi particolari lavoratori e il loro mestiere? La rivelazione, quando è arrivata, ha fatto luce su questa domanda. A differenza delle precedenti epifanie, ho deciso di riconoscere questa nel testo stesso, scrivendo di come il mio interesse per la pietra si fosse sviluppato durante la mia esperienza di lavori di costruzione e prefabbricazione in cemento ai tempi della scuola e dell’università. Sono stato in grado di ricordare quella “sensuale” manipolazione del cemento e della pietra frantumata, e ho notato che i lavoratori che avevo intervistato in Palestina e Israele utilizzavano sostanzialmente gli stessi materiali e procedevano secondo modalità simili. In qualche modo, questa intimità con il loro mestiere mi era consapevolmente sfuggita, anche se, presumibilmente, era stata di aiuto nel concepire il libro.
La parola che avevo scelto per definire la memoria soppressa era “latente”, e la sua relazione con il libro è definita “connessione personale”. Sebbene ci siano modi più originali per spiegarlo, ho deciso di considerare la memoria “rivelata” come banale, e sperato che potesse parlare da sé. Per quale motivo? Perché volevo credere che la solidarietà con questi lavoratori e il desiderio di amplificare le loro voci nel mondo fossero fattori di gran lunga più importanti alla base della scrittura del libro rispetto alla mia passata esperienza come operaio edile.
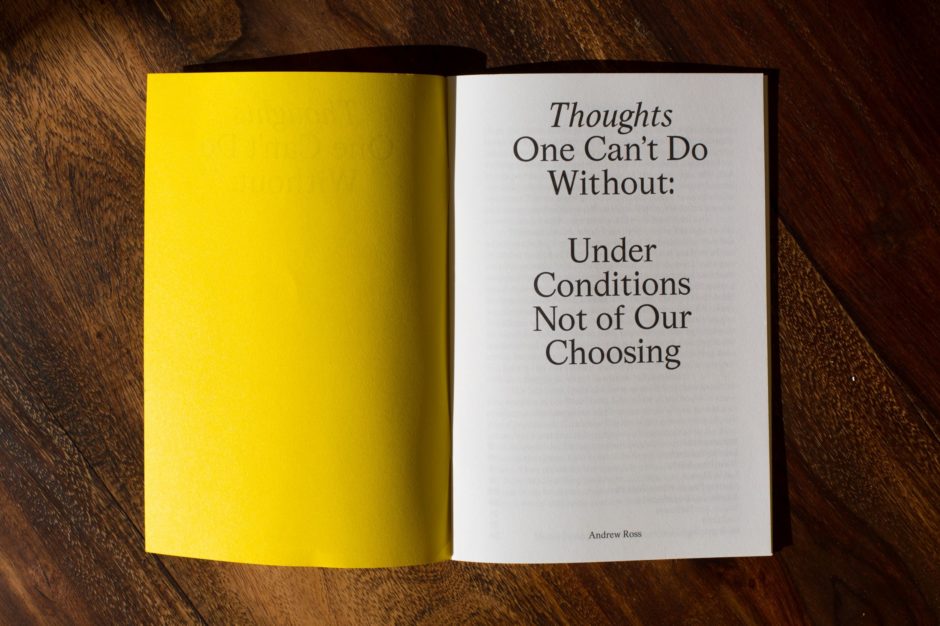
Guadagnare solidarietà
Riflettendoci, però, mi sono reso conto che questi due impulsi non sono poi così distanti. La solidarietà, almeno nella sua forma più umile, va guadagnata; non può essere semplicemente dichiarata, assunta o adottata, e sicuramente le sue interpretazioni più deboli – spesso etichettate come indicatori di virtù – si presentano sotto forma di un tweet, o dell’aggiunta del proprio nome a una lettera o una petizione che sta circolando. Scrittori, artisti e intellettuali impegnati devono affrontare regolarmente questa sfida, dal momento che ci troviamo nella posizione di amplificare le voci di persone che non godono dello stesso livello di accesso all’“ossigeno” della pubblicità. Potremmo scegliere di assumere la causa degli inascoltati e diventare sostenitori impegnati, persino fidati, di tale causa ma, a meno che non abbiamo “le mani in pasta”, in genere lo facciamo con la consapevolezza di potercene sempre andare. La colpa potrebbe lasciare una cicatrice residua per gli scrittori di coscienza che abbandonano una causa in questo modo, ma ci sono anche ricompense morali per coloro che lo fanno. Per quale motivo? Perché la vera forza della mente aperta e liberale dovrebbe risiedere nella sua capacità di principio di “ripensare” un impegno.
A tal proposito, vale la pena distinguere quel tipo di sostegno privo di rischi, o facoltativo, da un coinvolgimento più profondo e duraturo in una causa. Considerate il tanto citato avvertimento, attribuito a Lilla Watson, un’attivista aborigena del Queensland: “Se sei venuto qui per aiutarmi, stai sprecando il tuo tempo. Ma se sei venuto perché la tua liberazione è legata alla mia, allora lavoriamo assieme”. Questo tipo di ammonimento viene spesso rivolto a “salvatori bianchi” dalle buone intenzioni, e può avere effetti positivi – delle analisi sul privilegio bianco, ad esempio, che non siano semplicemente auto-indulgenti ma che portino a nuovi tipi di relazioni con coloro che lottano per i loro diritti e per il loro sostentamento. Ma lo spirito di trasformazione della sfida – che vale la pena adottare come regola generale – è applicabile a chiunque faccia un lavoro politico o arte.
Negli ultimi decenni ho cercato di rispondere a questa sfida scrivendo diversi libri che rompono il paradigma della difesa facoltativa che, a volte, si caratterizza come una ricerca “paracadute”. Penso a questi come a dei “libri movimento”, basati su di una “ricerca militante” con vari gruppi (come il Gulf Labor Artists Coalition e Strike Debt), che ho co-fondato e nei quali sono stato attivo. Una scrittura di questo tipo comporta rischi e responsabilità che non si applicano al compito di produrre articoli o comunicati in stile propagandistico intesi a promuovere gli obiettivi del movimento. Nel documentare e analizzare un movimento da una posizione soggettiva, la responsabilità verso gli altri attivisti è fondamentale, così come la discrezione sui dettagli dell’organizzazione. Ma questo genere incoraggia anche le critiche allo stesso processo decisionale interno e alla strategia, critiche che possono infastidire i colleghi o rovinare relazioni. Anche se l’obiettivo è quello di aiutare a portare il movimento sempre più in avanti, un punto di vista che non è approvato collettivamente può sempre esporre l’autore ad accuse di rottura dei ranghi o altri tipi di malafede. Ma finché vale la pena correre il rischio, la responsabilità di sottoporre il lavoro del movimento all’analisi è la più autentica proprio quando essa viene intrapresa da un suo membro attivo.
Scrivere in questo modo è stato per me un modo per cercare di essere all’altezza della lunga e duratura sfida di integrare la teoria con la pratica. Ogni momento di azione ha bisogno di un movimento di idee per dargli forma e slancio politico. Ma esse funzionano a velocità diverse. Per gli intellettuali, il germinare delle idee avviene più lentamente e in un continuum diverso da quello degli attivisti, che devono sempre avanzare richieste al presente in corso. Il trucco è provare a sincronizzare i due, e anche trovare una voce che sia reattiva e persuasiva sia nei confronti della teoria che della pratica.
Intellettuali e artisti che vogliono essere parte integrante di un movimento devono anche affrontare delle scelte su dove impiegare le nostre energie creative. Una cosa è alimentare un’insurrezione generando una grafica o un testo per gli organizzatori e gli agitatori; un’altra è aiutare a immaginare come la fase di protesta di una ribellione possa essere trasformata in una riorganizzazione rivoluzionaria della società. Le svolte di quest’ultimo tipo sono rare e spesso dipendono da quella componente inafferrabile che è il tempismo. La leggenda di Detroit Grace Lee Boggs, la cui politica dialettica parlava dell’interdipendenza dell’evoluzione e della rivoluzione, ci ha esortato a essere consapevoli del nostro momento storico mentre ne diamo inizio a uno nuovo. Come incitazione, ha voluto porre la domanda: “che ora è sull’orologio del mondo?”. Troppo spesso, ci ha avvertito, la sfida di correggere le ingiustizie viene affrontata riciclando vecchie idee sulla resistenza e il cambiamento, e i risultati sono fin troppo facilmente incorporati all’interno delle strutture di potere. Poiché la presa di potere ha spesso comportato delle versioni timorose degli stati esistenti, Boggs ha sostenuto che il compito più genuinamente rivoluzionario è quello di cercare di vivere ora come vorremmo vivere in una società futura, piuttosto che aspettare che questa si realizzi.
La lezione di Boggs ha risuonato maggiormente tra gli anarchici che creano spazi prefigurativi o comunità per modellare il mondo di liberazione che desiderano, nel quale la cura, la reciprocità e il consenso saranno le regole d’oro. I giovani, naturalmente, sono di solito più adatti a questa vita sperimentale. Essi temono che il loro futuro sia già precluso – a causa del debito studentesco, del degrado ambientale o della sorveglianza totale – e quindi sono più inclini ad accettare la sfida di vivere come vorrebbero. Di conseguenza, questi spazi tendono a non essere molto transgenerazionali. Come educatore e attivista che sta invecchiando, mi trovo a trascorrere molto tempo con persone molto più giovani di me, per cui ci sono dei momenti di malinconia yeatsiana: “Quello non è un paese per vecchi. I giovani / L’uno nelle braccia dell’altro … ”. Ma essere un radicale per la vita (piuttosto che uno che invecchia sul posto) significa che dobbiamo sempre ascoltare da vicino le voci e le idee (dei) giovani, e quindi la mia guida migliore, in questi momenti, è la poetessa Muriel Rukeyser che una volta ha descritto i giovani radicale come “esiliati dal futuro”.
La promessa di una liberazione nazionale si è inasprita così spesso che esito a farvi riferimento simultaneamente ma, in quanto fedele a vita alla causa dell’indipendenza scozzese, mi sento obbligato a citare una massima affine dello scrittore di Glasgow Alasdair Gray: “Lavora come se vivessi ai primi giorni di una nazione migliore”. Essa si trova inscritta sul muro di Canongate del Parlamento scozzese, sia come ingiunzione ai membri della classe politica che lavorano sodo all’interno dell’edificio, ma anche a tutti coloro che adesso vogliono vivere quel sogno. Come nativo scozzese, sono consapevole che questa raccomandazione di prendere il controllo del proprio destino storico è intrisa di una riconoscibile sensibilità nazionale verso le virtù del lavoro e del buon senso. Dopo tutto, nella tradizione calvinista, il duro lavoro è un segno, anche se non una garanzia, di salvezza futura. Essendo incapace di eliminare completamente le mentalità presbiteriane della mia infanzia, trovo difficile di conseguenza concepire un programma di emancipazione che non implichi il sobbarcarsi di lavoro e fatica.
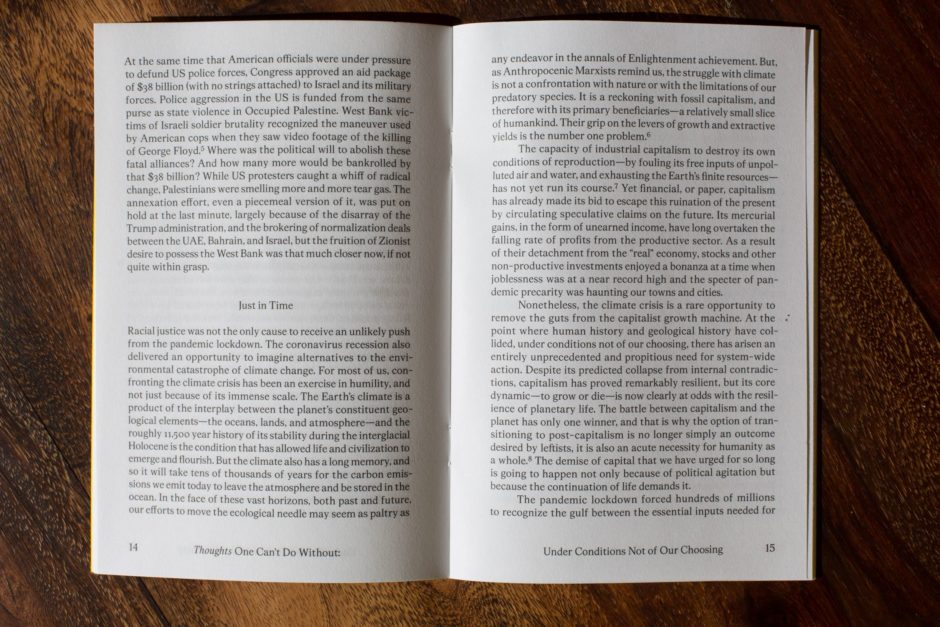





condividi