L’alleanza dei corpi
Note per una teoria performativa dell'azione collettiva

Pubblichiamo qui una anticipazione del libro di Judith Butler L’alleanza dei corpi, a cura di Federico Zappino, Nottetempo (2017), in libreria dal prossimo 9 febbraio. Il saggio della filosofa e femminista americana verrà presentato il prossimo lunedì 13 febbraio da Tuba Bazar (via del Pigneto, 39a, Roma), insieme al curatore Federico Zappino e a Federica Castelli.
Spesso, negli ultimi tempi, mi viene posta la seguente domanda: come si fa a passare dalla teoria della performatività del genere a una riflessione sulle vite precarie? Sebbene tale domanda miri implicitamente a ottenere una risposta di tipo biografico, essa pone in ogni caso in rilievo una questione di tipo teorico: qual è, se c’è, la connessione tra la «performatività del genere» e le «vite precarie»? Com’è possibile, nel mio caso, partire dall’interesse per la teoria queer e i diritti delle minoranze sessuali e di genere, per poi arrivare a scrivere, piú in generale, su come la guerra e altre condizioni socioeconomiche designino intere popolazioni come non degne di lutto? In Gender Trouble, scritto nel 19891, l’ipotesi era che determinati atti individuali volessero, o potessero, sortire effetti sovversivi sulle norme di genere. Ora mi trovo a riflettere sulle forme di alleanza tra varie minoranze o parti di popolazione considerate dispensabili; piú in particolare, sono interessata al modo in cui la precarietà – questo termine intermedio che è anche, in qualche modo, un termine di mediazione – potrebbe operare, o già opera, come luogo di alleanza tra gruppi di persone che, al di là di essa, hanno poco in comune tra loro, o tra i quali vi è talvolta perfino diffidenza e antagonismo. Nonostante la mia attenzione si sia dunque spostata seguendo piú o meno questa traiettoria, a non essere mutata è la mia convinzione che le politiche identitarie non siano in grado di esaurire la questione piú ampia di cosa significhi, politicamente, vivere insieme, attraverso le differenze, talvolta in una prossimità che non è frutto di una scelta deliberata, specialmente in quei casi in cui vivere insieme, per quanto difficile, resta un imperativo etico e politico. La libertà, d’altronde, è qualcosa che si esercita il piú delle volte insieme agli altri, e non necessariamente in modo unitario o conforme. Tale esercizio non presuppone né produce un’identità collettiva, quanto, piuttosto, un insieme di possibilità e di relazioni dinamiche che includono forme di supporto reciproco, conflitto, rotture, gioia, solidarietà. Per comprendere questa dinamica propongo di indagare due ambiti teorici, ai quali possiamo riferirci sinteticamente con i concetti di «performatività» e «precarietà», al fine di suggerire la possibilità di considerare il diritto di apparizione nei termini di una cornice coalizionale – piú precisamente, una cornice in grado di collegare le minoranze di genere e sessuali alle vite precarie in senso piú ampio.
[…]
Se l’accezione della performatività è innanzitutto linguistica, in che modo gli atti corporei diventano anch’essi performativi? Rispondere a questa domanda ci consente di comprendere non solo il modo in cui si forma il genere, ma anche il carattere performativo delle dimostrazioni di massa. Nel caso del genere, quelle iscrizioni e interpellazioni primarie di cui abbiamo parlato vanno di pari passo con le aspettative e le fantasie di coloro che ci circondano, le quali ci condizionano in modi che restano del tutto incontrollabili: ciò è parte dell’imposizione psicosociale e del lento inculcamento delle norme. Queste norme ci piombano addosso quando nemmeno ce l’aspettiamo, e poi si fanno strada in noi, animando e strutturando la nostra responsività. Queste norme, infatti, non si limitano a imprimersi su di noi, marchiandoci ed etichettandoci quali destinatari passivi di una cultura. Esse, piuttosto, ci «producono», ma non nel senso che ci danno vita, né nel senso che determinano rigidamente chi siamo. Piuttosto, queste norme informano le modalità vissute di incorporazione che acquisiamo nel corso del tempo; e queste forme di incorporazione possono rivelarsi modi per contestare o sovvertire le norme stesse.
Un esempio chiaro di come ciò possa accadere si manifesta quando rigettiamo i termini attraverso i quali ci è stato assegnato un genere: in effetti, possiamo incorporare o mettere in atto questo rigetto prima di esprimerlo verbalmente. Possiamo infatti percepire il rigetto in primo luogo come un rifiuto viscerale di conformarsi alle norme veicolate dall’assegnazione del genere. Nonostante noi tutti, in vari modi, siamo messi nella condizione di non poterci sottrarre alla riproduzione delle norme di genere, è anche vero che, a volte, le sentinelle incaricate di sorvegliare la nostra conformità a quest’obbligo si addormentano in piedi. Ed ecco allora che ci troviamo a deviare dal percorso designato, ci ritroviamo in una zona umbratile, e iniziamo a domandarci se in questa o quella situazione ci siamo comportate da vere donne, o almeno in modo abbastanza femminile, o in modo sufficientemente maschile, oppure iniziamo a domandarci se la mascolinità sia ben esemplificata dall’uomo che si suppone che noi siamo, o se invece non abbiamo in qualche modo fallito – ed ecco che finiamo per dimorare, felicemente o meno, negli interstizi tra le categorie prestabilite di genere. L’ipotesi del fallimento, d’altronde, è sempre presente nell’attuazione del genere; un modo per descrivere il genere potrebbe essere proprio quello di una performance per la quale la possibilità di fallire è una caratteristica essenziale. Vi è una sorta di idealità, se non proprio una dimensione fantasmatica, nelle norme culturali di genere, e anche se gli esseri umani cercano di reiterare e di assecondare quelle norme, al contempo acquisiscono consapevolezza dell’esistenza di un divario persistente tra quegli ideali – molti dei quali in conflitto tra loro – e i vari, e viventi, tentativi di incorporazione, nei quali la comprensione di noi stessi e la comprensione degli altri si accavallano. Il mio genere viene a me a partire dal modo in cui qualcun altro si è relazionato con la norma, e poi dimora dentro di me come una fantasia che, al tempo stesso, è stata formata da altri, ma è anche divenuta parte della mia formazione.
Ciò che voglio dire, in realtà, è piuttosto semplice. Il genere è qualcosa che riceviamo; non è semplicemente iscritto sui nostri corpi, come fosse gesso sull’ardesia, come fossimo passivamente obbligati a portare un marchio. Ciò che siamo obbligati a fare, semmai, è recitare la parte di genere che ci è stata assegnata, e ciò significa, a un livello inconscio, che la nostra formazione si deve a un insieme di fantasie estranee che ci sono state trasmesse attraverso interpellazioni di vario tipo.
[…]
In definitiva, nel sostenere che il genere fosse performativo ho voluto sostenere che esso consiste in un certo tipo di attuazione; che l’«apparizione» del genere viene spesso fraintesa quale segno di una verità interiore, o innata; che il genere è indotto da norme coercitive, le quali richiedono che si aderisca a un genere o all’altro (solitamente all’interno di una cornice rigidamente binaria); che la riproduzione del genere è dunque sempre una negoziazione con il potere; che, infine, non vi sarebbe genere al di fuori della riproduzione di quelle norme che, proprio nel corso della loro ripetizione, possono essere disfatte e rifatte in modi inattesi, aprendo cosí la possibilità di ricostruire la realtà del genere lungo nuove direttrici2. L’aspirazione politica di quest’analisi, e forse proprio il suo obiettivo normativo, è quella di contribuire a rendere le vite delle minoranze sessuali e di genere piú possibili e piú vivibili, perché i corpi non conformi alle norme di genere [gender nonconforming], al pari di quelli fin troppo conformi (e ad alto prezzo), siano in grado di respirare e di muoversi liberamente negli spazi sia pubblici sia privati, cosí come in quelle zone che intersecano e confondono il pubblico e il privato. La teoria della performatività del genere che ho formulato in questi termini, chiaramente, non ha mai prescritto quali performance di genere fossero «giuste», o maggiormente sovversive, e quali invece fossero «sbagliate», o reazionarie, anche nei casi in cui auspicavo che certi tipi di performance di genere facessero breccia nello spazio pubblico, liberi dalla violenza della polizia, dalle molestie, dalla criminalizzazione, dalla patologizzazione. Il punto era quello di allentare la morsa coercitiva delle norme di genere – il che non significa trascendere o abolire tutte le norme –, per rendere possibile una vita maggiormente vivibile. Quest’ultimo è un proposito «normativo». E «normativo» non significa «normalizzante»; significa, piuttosto, che tale proposito rappresenta una concezione del mondo come dovrebbe essere. Il mondo come dovrebbe essere, infatti, tutelerebbe la possibilità di sovvertire la norma, e offrirebbe supporto e conferma a quanti lo facessero.
È forse possibile, ora, tentare di comprendere in che modo la precarietà abbia sempre fatto parte di questo quadro, dal momento che la performatività del genere è una teoria, cosí come una pratica, che ha tentato di contrastare le condizioni di invivibilità in cui versano le minoranze di genere e sessuali (e, talvolta, anche le piú ampie maggioranze che «passano» per normative a un prezzo molto alto, in termini psichici e somatici). La nozione di «precarietà» designa quella condizione politicamente indotta per cui determinate persone soffrono piú di altre per la perdita delle reti economiche e sociali di sostegno, diventando differenzialmente esposte all’offesa, alla violenza e alla morte. Come ho già detto altrove, «precarietà» significa «distribuzione differenziale della precarietà»3. Le persone esposte in modo differenziale rischiano in percentuali decisamente piú elevate di ammalarsi, di impoverirsi, di patire la fame, di essere soggette a spostamenti indesiderati, di essere vulnerabili alla violenza, senza le adeguate forme di protezione o di risarcimento. La «precarietà», inoltre, caratterizza la condizione politicamente indotta di vulnerabilità ed esposizione massimizzata di persone soggette all’arbitraria violenza di stato, alla violenza domestica o di strada, cosí come ad altre forme di violenza non perpetrate dallo stato, ma rispetto alle quali gli strumenti legali degli stati non sono in grado di offrire sufficiente protezione o riparazione. Attraverso il concetto di «precarietà» mi riferisco quindi a fasce di popolazione che versano in condizioni di inedia o quasi, alle quali il cibo non è assicurato tutti i giorni, o arriva accuratamente razionato – come accade, per esempio, quando lo Stato di Israele decide di quanto cibo necessitino i palestinesi residenti nella Striscia di Gaza per sopravvivere –, o ai molti esempi globali in cui anche solo la possibilità di vivere sotto un tetto è temporanea, se non proprio perduta del tutto. Ma la precarietà riguarda anche le sex workers transgender, costrette a difendersi dalla violenza di strada o dalle molestie della polizia. E a volte, le stesse persone appartengono contemporaneamente a piú d’una di queste categorie, e sono legate tra loro dalla comune soggezione alla precarietà, che sia improvvisa o protratta nel tempo, anche se non vogliono riconoscere questo vincolo.
Cosí la precarietà, forse in modo ovvio, si collega direttamente alle norme di genere, dato che sappiamo perfettamente che coloro che non vivono il genere in modi pienamente leggibili sono maggiormente suscettibili di molestie, patologizzazione e violenza. Le norme di genere, d’altra parte, determinano quanto e come possiamo apparire nello spazio pubblico, quanto e come il pubblico e il privato debbano essere distinti, e quanto questa distinzione sia strumentalizzata al servizio della politica sessuale.
[…]
Ciò che a volte definiamo «diritto» di apparizione è tacitamente sostenuto da schemi regolativi che qualificano solo determinati soggetti come degni di esercitare questo diritto. Quindi non conta affatto quanto «universale» tale diritto possa essere ufficialmente dichiarato: il suo universalismo è in realtà particolarizzato da forme differenziali di potere che stabiliscono chi può apparire e chi no. Per coloro che sono considerati «inammissibili» nella sfera dell’apparizione diventa fondamentale allearsi e la lotta deve prevedere un’istanza plurale e performativa di ammissibilità là dove essa non esiste. Questo tipo di azione performativa plurale non deve limitarsi a ottenere un posto per coloro che non ce l’hanno, o che ce l’hanno precario, all’interno di una preesistente sfera di apparizione. Tale azione, al contrario, deve produrre una frattura all’interno di quella sfera, mostrando le contraddizioni che animano e al contempo cancellano le sue pretese di universalità. Non può esserci alcun ingresso nella sfera dell’apparizione senza una critica delle forme differenziali di potere che la costituiscono, né in assenza di un’alleanza critica tra gli esclusi, gli inammissibili – i precari –, un’alleanza che stabilisca nuove forme di apparizione in grado di superare quelle differenze. E il fatto che ogni forma di apparizione sia resa possibile da un «fuori» costitutivo non rende affatto inutile continuare a lottare. Al contrario, è l’unica ragione per cui continuare a farlo.
Alcune azioni quotidiane, a volte, diventano particolarmente significative per comprendere il significato politico della performatività, nella sua lotta che parte da condizioni di precarietà ed è volta a contrastarle. Come sappiamo, non tutti possono dare per scontato il diritto di passeggiare per strada, o di entrare in un bar, senza subire molestie. Passeggiare per strada da sole, senza subire vessazioni da parte della polizia, significa anche passeggiare senza essere necessariamente accompagnate da qualcuno, con tutte le forme di protezione informale che ciò comporta. Quando una persona transgender cammina per strada ad Ankara o entra in un McDonald’s di Baltimora, la questione è se quel diritto sia esercitabile dal singolo individuo. Se si tratta di qualcuno dotato di straordinarie capacità di autodifesa, forse lo è; se lo spazio culturale entro il quale si muove lo accetta, lo è sicuramente. Ma quando diventa possibile passeggiare senza protezione e sentirsi sicure, ciò accade perché molte altre persone supportano quel diritto, anche se è esercitato individualmente. Se posso esercitare questo diritto e se esso mi viene riconosciuto, in altre parole, è perché ci sono molti altri che lo stanno esercitando a loro volta, anche se non in questo stesso momento. Ogni «io» prevede un «noi», tutte le volte in cui si entra o si esce dalla porta di casa, o ci si trova in uno spazio privo di protezione, o esposti in mezzo alla strada. Potremmo dire che c’è un gruppo, se non proprio un’alleanza, che passeggia là fuori, visibile o meno. […] Questo «io» è allo stesso tempo un «noi», senza che ciò significhi un’impossibile totalità. Essere attori politici è una funzione, un modo di agire in un’ottica di uguaglianza con altri umani – e questa è un’importante idea di Hannah Arendt che resta centrale per le lotte democratiche contemporanee. L’uguaglianza è una condizione e una qualità dell’azione politica, nel momento stesso in cui ne costituisce l’obiettivo. L’esercizio della libertà non è qualcosa che si origina in te o in me: la libertà è qualcosa che nasce tra noi, dal legame cui diamo vita nel momento in cui esercitiamo insieme la nostra libertà, un legame senza il quale non ci sarebbe nessuna libertà.
[…]
Possiamo ora tornare alla domanda piú generale: cosa significa rivendicare diritti quando non se ne ha nessuno? Significa rivendicare il potere che ci viene negato, per mettere in evidenza la negazione e combatterla. Come accade, per esempio, nei movimenti di occupanti abusivi a Buenos Aires, in cui coloro che non hanno piú una casa si trasferiscono a vivere all’interno di edifici disabitati rivendicando poi il diritto di residenza4: a volte non si tratta di un potere che precede l’atto; la questione, a volte, sta tutta nell’agire, perché in quell’agire risiede il potere che si rivendica. Questa è la performatività per come io la concepisco, ed è un modo di agire determinato dalla precarietà [precarity], e volto ad abbatterla.
La precarietà è ciò che accomuna donne, queers, transgenders, poveri, disabili, apolidi, nonché le minoranze religiose o razziali: si tratta di una condizione sociale ed economica, non di un’identità (la precarietà, infatti, attraversa tutte queste categorie ed è in grado di produrre potenziali alleanze tra persone che non sanno di condividere una comune appartenenza).
[…]
Nei miei primi scritti, ero interessata al modo in cui diversi discorsi sul genere sembravano creare e mettere in circolazione determinati ideali di genere, generando essi stessi quegli ideali, e facendoli però passare per essenze naturali o per verità innate, espresse successivamente da quegli stessi ideali. Cosí, l’effetto di un discorso – in questo caso, un insieme di ideali di genere – veniva largamente frainteso come causa interna del desiderio e del comportamento, un nucleo di verità espresso da gesti e azioni. Questa causa interna o questo nucleo di verità non solo si sostituivano alla norma eterosessuale, ma di fatto mascheravano e facilitavano il suo operare. La mia definizione della «performatività del genere» diede adito a due interpretazioni contrastanti: per la prima, ciascuno si sceglie il proprio genere; per la seconda, siamo tutti completamente determinati dalle norme di genere. Questi due riscontri apertamente divergenti lasciano intendere che qualcosa non era stato abbastanza ben spiegato e compreso, riguardo alla dimensione duale di ogni tipo di performatività. Infatti, se il linguaggio agisce su di noi prima che noi agiamo, e se esso continua ad agire in ogni istante in cui agiamo, ciò significa che dobbiamo intendere la performatività del genere innanzitutto come «assegnazione di genere» – ossia, quelle modalità attraverso le quali veniamo chiamati con un nome, e «genderizzati» [gendered], prima di capire in che modo le norme di genere agiscano su di noi dandoci una forma, e prima di essere in grado di riprodurre quelle norme in modi che si possono anche scegliere. All’interno di questo processo performativo, pertanto, la scelta arriva in un secondo momento. Seguendo la riflessione di Eve Kosofsky Sedgwick5, il nostro sforzo dovrebbe consistere nel comprendere in che modo le deviazioni da quelle norme possano aver luogo, come a volte accade, suggerendo che qualcosa di queer è al lavoro nel cuore della performatività del genere, una queerness che non è poi cosí diversa da quelle «sterzate» dell’iterabilità di cui parla Derrida riguardo alla citazionalità dell’atto linguistico.
Assumiamo, pertanto, che la performatività descriva sia i processi attraverso i quali siamo agiti, sia le condizioni e le possibilità dell’agire; e che, in assenza di queste dimensioni, non saremmo in grado, propriamente, di agire. Il fatto che le norme di genere agiscono su di noi implica che siamo suscettibili alla loro azione, vulnerabili a un certo modo di essere interpellati, fin dall’inizio. E tutto ciò viene registrato a un livello precedente a ogni volontà. Un modo per comprendere l’attribuzione di genere può consistere nel soffermarsi proprio su questo piano di ricettività involontaria, di suscettibilità, di vulnerabilità, di esposizione al linguaggio precedente a ogni possibilità di elaborare o proferire un atto linguistico. Norme come queste richiedono e, al tempo stesso, istituiscono determinate forme di vulnerabilità corporea, senza le quali il loro operare non sarebbe nemmeno pensabile. Ecco perché possiamo, come già facciamo, descrivere la potente forza citazionale delle norme di genere nel momento in cui sono istituite e applicate dalle istituzioni mediche, giuridiche, psichiatriche, nonché contestare l’effetto che hanno nella formazione e comprensione del genere in termini patologici o criminali. Eppure, questa forma di suscettibilità, questa condizione di vulnerabilità, è presente anche quando accade qualcosa di «queer», quando la norma viene rifiutata o rivista, o quando prendono vita nuove formulazioni di genere. Proprio perché qualcosa di involontario e di inaspettato può accadere in questo dominio di «vulnerabilità», il genere può emergere in modi che rompono gli schemi meccanici della ripetizione o deviano da essi, risignificando, e talvolta infrangendo in modo piuttosto enfatico, le catene citazionali della normatività di genere, facendo spazio a nuove forme di vita del genere.
La performatività del genere non caratterizza solo ciò che facciamo, ma anche il modo in cui il potere del discorso e delle istituzioni ci condiziona, vincolandoci e facendoci muovere in relazione a ciò che definiamo le «nostre» azioni. Per comprendere il fatto che i nomi con i quali veniamo chiamati sono tanto importanti, per la performatività, di quelli con cui chiamiamo noi stessi, dobbiamo innanzitutto individuare quali convenzioni siano all’opera all’interno dell’ampio spettro di strategie di assegnazione del genere. Solo allora saremo in grado di vedere in che modo gli atti linguistici ci condizionano e ci animano in modi incarnati – dal momento che la suscettibilità e la vulnerabilità s’inscrivono già a livello corporeo. Infatti, l’incarnazione implicata sia dal genere sia dalla sua performance si trova a dipendere dalle strutture istituzionali e dai piú vasti contesti sociali.
Non possiamo dire nulla a proposito del corpo se non sappiamo che cosa lo supporti, e quali relazioni intrattenga con questo sostegno – o con la mancanza di sostegno. E il corpo è meno un’entità che un insieme di relazioni viventi; il corpo non può essere dissociato dalle condizioni infrastrutturali e ambientali del suo vivere, e del suo agire. La dipendenza, nostra come delle altre creature viventi, dalle forme di sostegno infrastrutturale ci espone a una specifica vulnerabilità – come sappiamo – che possiamo sperimentare in tutti quei casi in cui non siamo sostenuti da nessuno, quando quelle condizioni infrastrutturali iniziano a decomporsi o quando ci troviamo a essere radicalmente privi di sostegno, in condizioni di precarietà. Agire in nome di quel sostegno, quando ne siamo privi, è il paradosso dell’azione performativa plurale nel regime di precarietà.
Note
| ↩1 | Judith Butler, Questione di genere. Il femminismo e la sovversione dell’identità (1990), trad. it. di Sergia Adamo, Laterza, 2013. |
|---|---|
| ↩2 | Judith Butler, Fare e disfare il genere (2004), a cura di Federico Zappino, Mimesis, 2014. |
| ↩3 | Cfr. Judith Butler, Vite precarie. I poteri del lutto e della violenza (2003), a cura di Olivia Guaraldo, Postmedia Books, 2013. |
| ↩4 | Cfr. Jorge E. Hardoy, David Satterthwaite, Squatter Citizen: Life in the Urban Third World, Earthscan, 1989. |
| ↩5 | Eve Kosofsky Sedgwick, Stanze private. Epistemologia e politica della sessualità (1990), a cura di Federico Zappino, Carocci, 2011. |

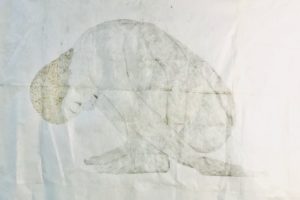



condividi