I sentieri della performance
Su alcune recenti pubblicazioni italiane

Se pensiamo alla Body Art ed alla performance più in generale in ambito italiano – non così probabilmente in altri paesi – il nome più emblematico sembra essere non tanto quello di un artista, ma quello di un critico, ovvero la compianta Lea Vergine, il cui Il corpo come linguaggio. Body art e storie simili (1974) resta non solo e non tanto una pietra miliare sull’argomento, ma proprio il punto di partenza naturale per chiunque in Italia – e non solo in Italia – voglia intraprendere lo studio di certi temi. E ciò al netto del fatto che la sua scrittura critica attraversa anche molti altri territori e in tal senso resta eloquente un passaggio di una intervista rilasciata a Barbara Casavecchia nel 2008: «A ondate sono stata la critica dei Napoletani, dell’Arte Programmata, dell’Arte e Politica, della Body Art, delle Donne, del Trash, dell’Ombra».
A quasi tre anni dalla sua scomparsa è possibile parlare di suoi eredi o solo di una sua eredità? Forse è più congruo parlare, con maggiore modestia, di continuatori? Oppure, in termini ancor meno ambiziosi, niente di tutto questo, ma solo soggetti più giovani che, tra l’altro, si sono formati sui suoi scritti o, tutt’al più, a contatto con la sua persona e – perché no? – visitando le sue mostre, ché Lea Vergine è stata anche una non trascurabile curatrice. Non intendo in questo luogo rispondere con puntualità a tali tutt’altro che semplici dilemmi, per quanto tenda a preferire l’ultima ipotesi, favorita peraltro dal fatto che l’unico ambito che le rimane totalmente estraneo, a differenza della maggioranza dei critici d’arte della sua generazione, è quello dell’insegnamento, e dunque non ha mai avuto la possibilità di formare allievi all’interno delle dinamiche più comuni. L’intento di questo articolo è piuttosto quello di mettere a fuoco alcuni degli studi di maggiore interesse aventi come oggetto la Body Art e – come ci ha insegnato a chiamarle lei stessa – le «storie simili», usciti in Italia di recente. Un itinerario propedeutico, benché non sufficiente, alle questioni poste sopra.

Senz’altro di gran pregio nel panorama della letteratura su tali argomenti è un volume antologico che ha ormai già cinque anni ma non risulta aver minimamente perso la sua attualità: Performance art. Traiettorie ed esperienze internazionali (Castelvecchi, Roma, 2018), a cura dall’artista Chiara Mu e dallo storico e critico d’arte Paolo Martore. Esso non possiede dichiaratamente alcuna ambizione di porsi ad un livello tipologico di classici italiani sulla performance – quelli di Francesca Alfano Miglietti o di Teresa Macrì e tanto meno quello della Vergine ‒ che pure sono intesi come riferimenti importanti. La sua genesi va ricercata, piuttosto, nelle vicende biografiche di Mu, come appare chiaro da quanto quest’ultima racconta nell’introduzione: «Ho avuto modo di confrontarmi con la carenza di materiali durante le mie recenti esperienze di insegnamento in accademie e scuole private italiane, riscontrando la medesima condizione di penuria culturale che mi ha portato quindici anni fa a perseguire i miei studi e la mia ricerca artistica in Inghilterra». Il libro scaturisce pertanto innanzi tutto da un impulso etico, oserei dire un atto d’amore, un libro in italiano e per gli italiani, onde rendere più facilmente fruibile «a studenti, futuri artisti, lettori curiosi e cultori della materia» una selezione preziosa, benché naturalmente «ben lontana dall’essere esaustiva».
Essa abbraccia un arco temporale compreso entro l’ultimo mezzo secolo circa, in un’ottica che pur non disconoscendo i prodromi presenti nelle avanguardie storiche, pensa comunque il tempo della performance come qualcosa che esplode in consonanza con gli anni più caldi della contestazione globale per poi trasformarsi in rapporto alle vicissitudini storiche, ma senza perdere la sua prorompente rilevanza. Consequenziale l’esclusione di testi relativi ad artisti già abbastanza noti al pubblico italiano – niente Orlan, Vito Acconci, per non parlare di Marina Abramović, del cui lavoro pure si trova conto, ma è sempre affrontato in maniera laterale – o già tradotti. Infine, «le parole dirette dei teorici e degli artisti sul proprio operato, privilegiando saggi, interviste e manifesti» sono preferite ai testi meramente «descrittivi di opere e artisti da parte di terzi».
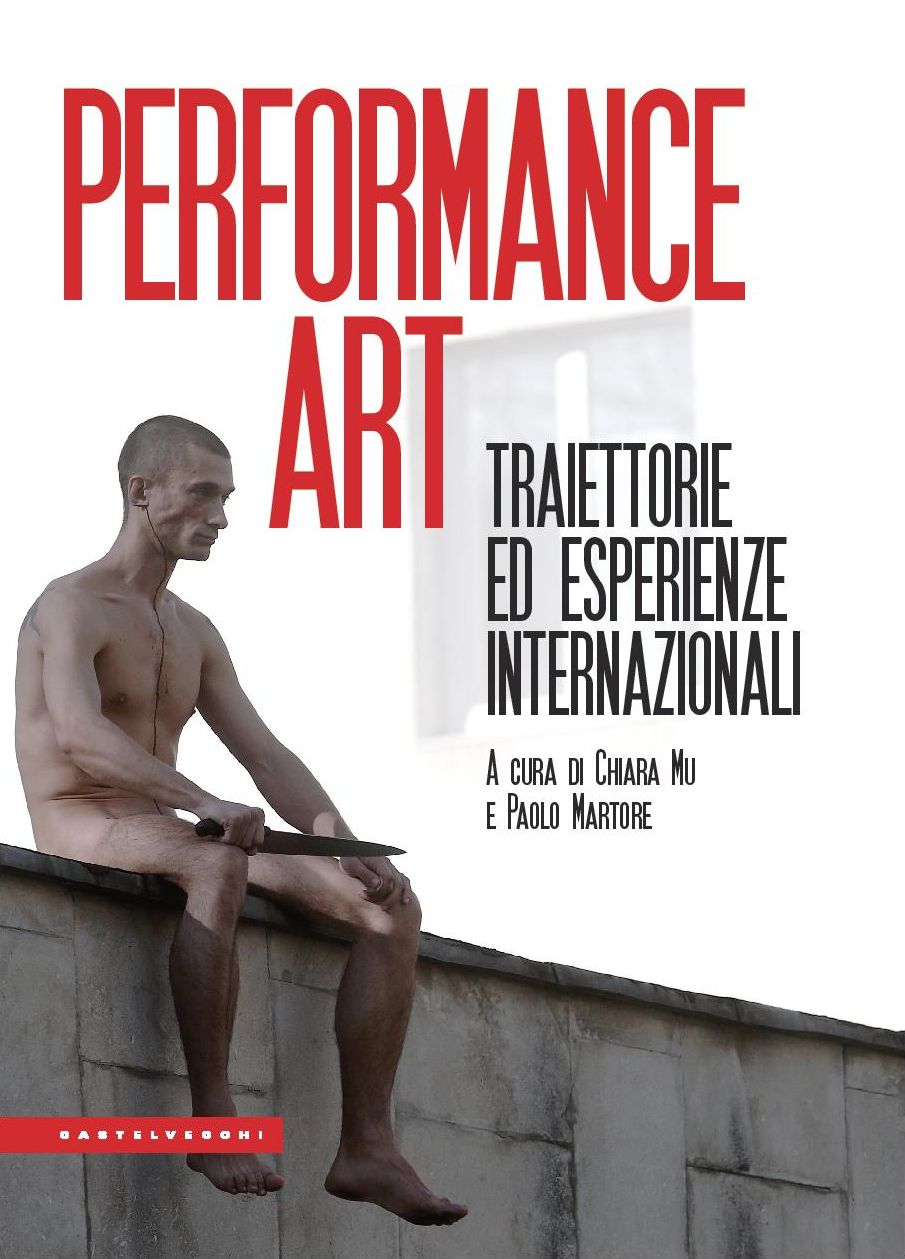
Chi è presente invece? Per esempio, il certo molto meno noto Piotr Pavlenskij, intrepido critico dell’opprimente apparato della Russia putiniana, delle sue strategie repressive, cui oppone azioni di grande icasticità ed inevitabilmente scandalose. Egli è inserito nella prima sezione, interamente dedicata a pratiche con una impronta fortemente centripeta, quelle di «artisti che hanno centrato la propria ricerca estetica ed etica sull’utilizzo del corpo come luogo di sperimentazione e tenuta, sia dal punto di vista fisico, sia dal punto di vista politico». Su tale piano si incontra anche Ulay, il cui profilo per i più sarà sempre inevitabilmente segnato dall’associazione con l’ex compagna Marina Abramović, ma anche da un confronto che per alcuni potrà giocare a suo favore: «Guardami: non ho nulla di speciale. Tutto quello che possiedo è leggero, minimale, semplice. Non potrei mai vivere come Marina, siamo antitetici. Lei vuole essere una star, io no». Spostandoci dall’altra parte dell’Oceano, troviamo invece Bruce Naumann, per il quale è tutto un giocare con i limiti e gli inciampi delle facoltà psico-corporee, anche attraverso l’abbondante ausilio del video, capace di complicare certi effetti, se non di produrne di inediti, e Andrea Frazer, nella quale i modi bodyartistici divengono ulteriori strumenti delle sue indagini nel campo della critica istituzionale. Chiude la sezione il saggio del 2012 della storica dell’arte Amelia Jones, la quale si impegna a demitizzare il live, che non esita a definire una vera propria ossessione del nostro presente.
Nella seconda sezione il focus si espande attraverso il tempo, «condiviso dilatato o negato nell’amministrare la dimensione effimera dell’opera: accettandone la sparizione o riproducendo la performance con altri corpi e in altri luoghi o riattivando la narrazione dell’evento originario grazie alla sua documentazione». In tale direzione si muove Santiago Sierra, il quale organizza gruppi collettivi di soggetti che in maniera anche per certi versi deliberatamente ripetitiva compiono azioni inutili e/o abbiette e compie così una azione di denuncia, assai trasparente, contro l’essenza oppressiva del lavoro. Meno ferocemente improntato alla denuncia, ma non meno consapevole dei processi sociali appare Mark McGowan, abile – tra l’altro – nello scatenare reazioni sensazionalistiche e a catena dei media, giocando spesso sullo scarto tra annuncio e fatto, come per la performance in cui l’artista dichiara di mangiare un piccolo corgi, la razza canina prediletta dalla Regina Elisabetta II – e non a caso in grado di vantare una pagina di Wikipedia così esaustiva da somigliare a un sito personale. È anche in tal senso che la performance trova uno sviluppo nel tempo, al di là della sua esecuzione letterale. Una visione simile sembra propria del critico e curatore Christopher Bedford, il quale ripercorre storicamente la celebre performance di Chris Burden, Shoot, onde proporre «un nuovo concetto di ontologia della Performance Art, secondo cui una data performance […] nel corso del tempo si scinde, si trasforma e si moltiplica in più medium a seconda dei contesti critici». Parimenti lo studioso di arti performative Philip Auslander pare scettico sulle possibilità di un evento realmente scevro di mediazione: «Ritengo […] che l’attuale condizione della performance dal vivo sia esattamente questo: l’intervento sempre più frequente della riproduzione ha privato l’evento live del suo status unico e auratico», e chiama naturalmente a sostegno del suo argomentare Walter Benjamin, ma anche Jean Baudrillard. Con Mona Hatoum torniamo ad una grinta iconoclasta degna di Sierra, ma ci troviamo catapultati in un’epoca differente (1987) rispetto alle più recenti parole dell’artista spagnolo, benché alcuni passaggi evochino già una condizione molto familiare: «Sei anni fa mi proponevo alle gallerie inviando loro la documentazione dei lavori già eseguiti. Bastava presentarsi e fare qualcosa; si veniva invitati in base al proprio lavoro. Oggi chiedono descrizioni del progetto dettagliatissime e con largo anticipo, a volte sei mesi prima. Perciò, se vuoi realizzare un’opera site-specific e dici che intendi lavorarci fino all’ultimo minuto, non va affatto bene». La questione del tempo come organizzazione o come spontaneità è centrale anche in Franko B – l’unico italiano che compaia nell’intero volume – che sviluppa il suo ragionamento intorno alla celeberrima impresa della Abramović, The Artist is Present (2010), mettendo in evidenza le sue implicazioni di «spettacolo/teatro» che la porrebbero a grande distanza dalla «performance nella sua forma più alta e pregnante (che) è fondamentalmente una questione di urgenza e necessità».

La terza sezione contempla «le pratiche artistiche di chi ha fatto della dimensione relazionale l’elemento costitutivo della propria ricerca, analizzando il concetto di partecipazione come strumento e al contempo come apertura dell’opera a possibilità di svolgimento più o meno impreviste». La scelta di aprirla con un saggio di Claire Bishop, tra gli studiosi più autorevoli circa la questione dell’arte come interazione dello spettatore, è significativa – così come non deve passare inosservata l’assenza dell’altra autorevole voce dell’arte come relazione, Nicolas Bourriaud. Detournando il celebre saggio benjaminiano L’autore come produttore in Lo spettatore come produttore, la storica dell’arte britannica attraversa le tesi del filosofo tedesco, i paradigmi relazionali posti in atto da personaggi come Bertold Brecht o Antonin Artaud, fino a giungere alle più recenti tesi del filosofo francese Jacques Rancière, quelle a lei più care nella misura in cui quest’ultimo critica la coincidenza tra spettacolo e passività, ché «il senso politico della partecipazione» risiede per lui nell’«appropriarci dell’opera» e «usarla in modi che i loro autori non avrebbero neanche potuto sospettare». Così agisce lo «spettatore emancipato». Quindi l’itinerario lambisce nomi e scritti degli «anni eroici», come Allan Kaprow, che nell’ambito della sua teorizzazione e pratica dell’happening comincia a pensare che «il pubblico andrebbe completamente eliminato», in quanto rifluirebbe nell’opera-evento stessa, o Graciela Carnevale, autrice di un atto terribile quale El encierro (1968), ma tale terribilità non è che un raddoppiamento del clima di terrore che si vive nella sua Argentina a partire dal golpe militare del 1966. Anche le azioni di Koki Tanaka vogliono «rispecchiare la società in cui viviamo», ma con esse la questione della partecipazione compie un grosso balzo nel tempo – i primi del nuovo secolo ‒ e nello spazio, la multietnica San Francisco: «Per prima cosa ho invitato alcuni parrucchieri a tagliare i capelli della stessa modella. Poi ho fatto suonare lo stesso pianoforte a cinque studenti. Quindi ho chiesto a cinque poeti di comporre un poema unico. Infine, ho chiamato diversi ceramisti a creare un unico vaso». Il fine è spostare l’attenzione dal risultato al «processo creativo e rivalutare così il senso dell’atto in sé». Infine, la statunitense Miranda July fonda la partecipazione sulle nuovissime frontiere della tecnologia – tanto più nuove nel 2014! ‒, realizzando una app di messaggistica per smartphone che utilizza il GPS «per triangolare interazioni in cui un utente inviava un messaggio, che andava recapitato verbalmente e di persona da un altro utente che si fosse trovato vicino alla posizione del destinatario».
La quarta ed ultima sezione contiene le esperienze più vicine alla cosiddetta arte attivista. Abbiamo già osservato diversi casi di profonda radicalità politica, ma in questa occasione ciò che fa la differenza sembra essere la circostanza per cui la performance risponde «ai contesti politici e sociali esperiti, determinando una modalità di lavoro che assume le contraddizioni delle tematiche affrontate per rovesciarne la comprensione». Il critico e curatore Adrian Hearthfield esamina – tra l’altro – le nozioni di tempo e di spazio nella performance in rapporto alle logiche capitaliste: se marxianamente «il tempo è diventato una merce profondamente regolata: il suo valore primario è la velocità, perciò perdere tempo significa perdere denaro», agli spazi urbani occidentali non può che far fronte una performance «sempre più nomade», che migra «senza sosta verso altri luoghi, altri campi dell’arte e della vita, per collocarsi ovunque la necessità di espressione, relazione e sussistenza lo imponga». Godibilissimo è il dialogo del 1984 tra la storica dell’arte e curatrice Lucy Lippard e l’artista Susanne Lacy, entrambe estremamente implicate nell’intreccio tra arte e attivismo e quindi consapevoli delle problematiche per cui l’una e l’altro non sempre si sposano alla perfezione, ma in quanto donne anche assai avvertite del peso delle pratiche femministe nello sviluppo della performance artistica attivista e non, tanto da scoprire come l’attività di un Vito Acconci possa considerarsi un cogliere «al balzo l’opportunità offerta dalle pratiche di auto-coscienza femministe». Di grande spessore è anche l’appassionata, travolgente apologia della performance pronunciata da Guillermo Gómez-Peña: «Tra di noi ci sono parecchi esuli delle arti visive, eppure raramente produciamo oggetti da esibire in musei e gallerie. Infatti, la nostra opera è principalmente il corpo, carico di implicazioni semiotiche, politiche, etnografiche, cartografiche e mitiche. A differenza degli artisti visivi e degli scultori, creiamo oggetti da utilizzare senza limiti né cautele: non ci importa se nel corso della performance si consumano o si distruggono», ecc. Imprescindibile sul piano della performatività attivista, tipici nelle loro strategie di slittamento dei discorsi e delle pratiche aziendali, a partire dal nome, sono gli Yes Men. Le coloriture antagoniste dei loro fini fanno sì che essi risultino tra i casi, ad occhio e croce minoritari nella selezione, in cui le esigenze pratiche sono preposte a quelle teoriche anche sul piano delle definizioni: «L’arte come categoria non è importante per quello che facciamo. In effetti, quando presentiamo il nostro lavoro a grandi platee non ci definiamo mai artisti. Non è politicamente vantaggioso». Attivismo legato ad una realtà politico-sociale completamente diversa e quindi assai differentemente motivato e formalizzato è poi quello di Kubra Khademi, che nel 2015 percorre da sola a piedi il quartiere di Kabul, dove vive, indossando sopra i vestiti una corazza di acciaio che le copre il seno ed il fondoschiena attirando l’attenzione degli astanti, tutti uomini. Chiude Tania Bruguera con la sua proposta di un’Arte Utile, prospettiva che fin dall’espressione – incluso l’uso delle maiuscole ‒ appare connotata da non lievi perplessità, in quanto immediatamente suggerisce che l’arte in sé abbia qualcosa da farsi perdonare: «Arte Utile è rendersi conto che l’arte non può essere solo una proposta. Arte Utile è passare dalla fase di proposta a quella di applicazione nel mondo reale».
«Nell’era delle molteplici narrazioni, svolte e spesso determinate dai mezzi di comunicazione utilizzati, quello che resta o forse andrebbe riscoperto è dunque il piacere della lettura», scrive Chiara Mu nei righi conclusivi della introduzione, rivendicando inoltre la felicità della scelta di rinunciare ad ogni supporto visivo – a parte l’immagine di copertina, sulla quale è riprodotta una performance di Pavlenskij. Si sa, del resto, che la riproduzione tecnica della performance, più ancora che quella della pittura o della scultura, è un inevitabile tradimento. Tanto più in un’era di saturazione dell’iconosfera, in grado di inibire con la sua prepotenza le capacità di immaginazione autonoma, la centralità della lettura diviene una sorta di invito a cogliere viceversa l’occasione di uno spazio vuoto affinché l’immaginazione del singolo, irritata dalla lettura, possa manifestarsi. Un invito, parafrasando Rancière, a dimostrarsi lettore emancipato!
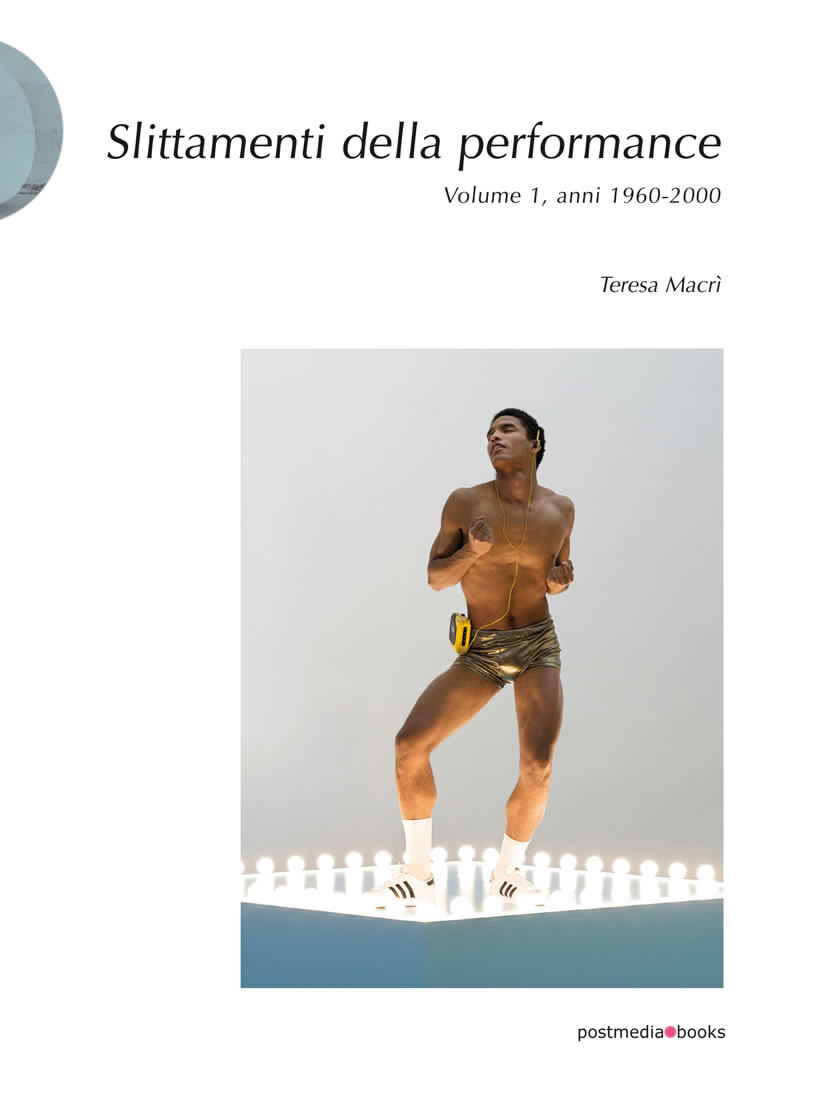
Si è già accennato a Teresa Macrì, al peso dei suoi studi e quindi del suo profilo di studiosa. Ad ormai circa trent’anni dall’inizio delle sue ricerche intorno alla performance e, in particolare, a quella che è ormai a tutti gli effetti una seconda generazione, distinta – e distante ‒ da quella storica degli anni Sessanta-Settanta, che all’inizio degli anni Novanta si confronta inevitabilmente con le prospettive del Post-Human, con un tempo in cui tanto la cibernetica che l’ingegneria genetica sembrano schiudere terrificanti quanto sterminati scenari, ella pone mano a un’impresa certo ambiziosa, ma in fondo meno di quanto possa apparire. Più che scrivere una storia organica della performance dalla sua genesi fino alla fine del secolo scorso, Slittamenti della performance. Volume 1. Anni 1960-2000 (postmedia books, Milano, 2020), l’autrice, come chiarisce nell’introduzione, «ondivaga tra questi corpi, ne cerca una concatenazione e sconfina nella sua cronologia per ricomporne una storia e catturarne l’opacità attraverso le parole», considerando l’attività di descrizione delle performance «un vezzo che, intellettualisticamente, mi permetto e mi concedo», pienamente cosciente, sulla scorta di Ludwig Wittgenstein, «che i limiti del mio linguaggio sono i confini del mio mondo, tutto ciò che io conosco è ciò per cui ho delle parole». Più avanti è ancora più esplicita sulle peculiarità del suo metodo e della sua visione: «L’intento di questo saggio è di uscire dalle categorie e dalle idolatrie, di avanzare un ordine/disordine, di recuperare i margini e gli scarti, di slittare liberamente nelle pieghe e di operare criticamente nel rizoma che alloca la dimensione performatica negli anni che vanno dal 1960 al 1999. […] I capitoli, dunque, si succedono per attinenza metodologica, formale o semplicemente empatica». Nell’introduzione al secondo volume del progetto editoriale, Slittamenti della performance. Volume 2. Anni 2000-2022 (postmedia books, Milano, 2022) non mostra minori cautele, riportando nuovamente la massima del filosofo austriaco e chiarendo di aver cercato di analizzare la materia «tenendo conto sia delle logiche di interazione con l’art system e sia del consenso a cui, purtroppo, molti performer si inchinano per quei 15 minutes of fame. Oltre alle note empatie con cui il mio sé, smodatamente, si incarna».
Il primo capitolo è esplicitamente dedicato alla genealogia della performance, rinvenuta ‒ pur premettendo che «la sua origine discende dagli umori avanguardistici precedenti che comprendono le gesta più iconoclaste delle serate futuriste e del Cabaret Voltaire di Hugo Ball» ‒ innanzi tutto in personaggi come Trisha Brown John Cage, Merce Cunningham, Yves Klein, Allan Kaprow, Yvonne Rainer, nei vari esponenti di Fluxus, ma anche nel meno noto collettivo giapponese Hi Red Center; dunque nell’ambito della musica e della danza, oltre che in quello delle arti visive, intorno agli anni Cinquanta-Sessanta. Nessun cenno invece a Marcel Duchamp, a lettristi isouiani e situazionisti e a Piero Manzoni.
Il concetto chiave intorno a cui ruotano gli artisti del secondo capitolo è la categoria freudiana di perturbante, un ombrello al di sotto del quale è, del resto, possibile collocare artisti anche molto diversi per poetiche. Vi trovano spazio naturalmente le «forme oltraggiose di auto ed etero-aggressività» degli azionisti viennesi e certe performance di Carolee Schneemann tra l’abietto e il visionario; quelle di Vito Acconci, ove il corpo diviene luogo in cui «pulsioni spaventose e istintuali cortocircuitano», e quelle di Marina Abramovic e Ulay – quest’ultimo definito «il pioniere indiscusso della performance» che, ad un certo punto del suo percorso stringe con la Abramović «un art-love-affair di dodici anni»; Chris Burden, nel quale «La performance è soprattutto carne che si manifesta, decostruendosi o riscrivendosi, interrogandosi o rispondendosi, automortificandosi o autoesaltandosi», e Gina Pane, anch’essa senz’altro legata ad una cifra cruenta, ma «Nel suo gesto estremo le blessures sono solo ferite, mai mutilazioni. Il suo sangue effluisce con leggerezza, non arriva alla pesantezza di Hermann Nitsch».
Il terzo capitolo è scritto quasi in antitesi al precedente, ché qui «Lontana dalle lacerazioni della carne e distaccata dall’irruenza della fatica e dall’impetuosità dello sforzo, la performance si concentra sullo smarcamento dei codici identitari e/o artistici. […] Fuori da qualsivoglia assemblaggio, molti di questi artisti sono unicità, dreamers fluttuanti che si riscrivono e si riconiugano attraverso la sinestesia dei linguaggi alchemici, di cui il corpo, lo spazio e l’altro compilano il paradigma». Così Joan Jones, «il cui lavoro si ramifica in performance, video, installazioni a cui concorrono anche il disegno, il suono e, of course, il teatro, la danza e il testo letterario», o Dan Graham, che con la sua concezione del video come specchio «attiva vari cicli di feedback che si svolgono tra l’artista e il pubblico e tra i membri del pubblico», sollevando i problemi della durata e dell’attenzione. Distante per media adoperati, oltre che per una poetica assai diversamente motivata, è Gino De Dominicis – finalmente un italiano! ‒, ma comunque pienamente rientrante nella nozione di liminale, attorno alla quale ruota l’intero capitolo, nel suo proporsi «fantasmaticamente di poter materializzare l’assenza, di rendere visibile l’invisibile». A distanza non eccessiva da De Dominicis sembra collocarsi Jannis Kounellis, considerato colui che possiede in assoluto «La versatilità performatica più causticamente poetica» e più volte chiamato con l’epiteto «il giovane favoloso», riecheggiando chiaramente il film sulla vita di Giacomo Leopardi di Mario Martone: «La poesia civile che trascende, ancora oggi, dalle sue opere è traccia indelebile di un vivere e ricucire, laicamente, la storia contemporanea».
I confini del terzo capitolo contemplano anche Gilbert & George, per la loro «scelta di unificarsi e di identificarsi in una unicità e, usando solo il proprio nome», alludendo alla volontà «di manifestarsi come essere singolare plurale», e Luigi Ontani, per i «Giochi di parole, doppi sensi, calembours e ambivalenze linguistiche» che sostanziano «una performatività semplice, ma sottile»; Rebecca Horn, la cui «semiologia è una sorta di wunderkammer della complessità, che racchiude un universo immaginario», e Bas Jan Ader, la cui «processualità meticolosamente studiata con cui l’artista articola le cadute collima nell’assimilazione di esperienze come il neoplasticismo, il romanticismo, l’azionismo, il teatro dell’assurdo nonché con la slapstick americana degli anni Venti e il non-sense»; esponenti del neo-concretismo brasiliano come Hélio Oticica e Lygia Clark, accomunati dalla vocazione ad assumere lo «spazio oggettuale nella sensibilità corporea» e ricostruire «la soggettività all’interno delle strutture coercitive sociali» sullo sfondo della dittatura in cui il loro paese è «catapultato col golpe del 1964», e Ketty La Rocca, la cui ricerca è assimilabile proprio a certe azioni della Clark, nelle quali spesso risiede alla base «la comunicazione gestuale che è affidata al movimento delle mani», sottratta «all’efficienza, che regola e struttura la società capitalista».
Il terzo capitolo include infine anche esponenti dell’identità intesa in senso liquido, «slittante nel post-genere» come Genesis P. Orridge, «performer, musicista, poeta, artista, occultista e pioniera della musica industriale». «Sui temi legati al gender, sui codici di appartenenza sessuale e sui loro superamenti» gioca anche Leigh Bowery, «carismatico maker multidisciplinare in cui musica, arte, moda, dance si interconnettono costantemente». Interessante qui la scelta della Macrì di includere anche soggetti non riconducibili al sistema dell’arte contemporanea tout court, ma non per questo da lei ritenuti inadatti a comparire all’interno di una ricognizione storica sulla performance. Quasi a marcare la continuità, poche pagine più avanti si trova Urs Lüti, ovvero un artista precocemente entrato nel «canone», ma immediatamente raffrontabile a questi ultimi due in virtù del suo porre «al centro della sua ricerca la questione di un’identità errabonda e in transizione». All’evocazione di «un’autenticità sottilissima, che tende a sfidare la provocazione attraverso l’attrazione dell’immagine e distanziarsi dall’evocazione performatica brutale e autolesionista degli stessi anni» tipica di Lüti corrisponderebbe un «procedimento affine» in James Lee Byars, «i cui temi della fragilità, invisibilità e morte, confluiscono nella ricerca del sublime e della perfezione».
Il discorso sul gender è centrale nel quarto capitolo, allorché inteso «come luogo di contrapposizione sessuale e di rivendicazione». Esso, avverte la Macrì, «è territorio minato che, negli anni della «seconda ondata» del movimento femminista, diviene un paradigma obbligato all’interno dell’esplorazione corporea». Sfilano così esponenti storiche dell’arte legata alle istanze femministe degli anni Sessanta e Settanta come Judy Chicago, certo più celebre per opere non assimilabili a performance come la grande installazione The Dinner Party (1974-1979), ma neppure estranea a tale medium. Di poco precedente a quest’ultima è Immolation (1972), una di quelle sue performance in cui è presente «un senso di sacrificio che rispecchia la frustrazione dell’artista quando si sentiva costretta a sopprimere qualsiasi femminilità». Non di meno ella «non si omologa, per obiettivi e pratiche, all’ala più estremista del femminismo corporeo, all’interno del quale l’esasperazione del gesto, l’uso di oggetti allusivi e l’uso del nudo integrale diventano gli enunciati di uno scontro che investe sia l’interiorità della performer che la socialità in cui essa si colloca». In questa direzione si muovono «angry women» già analizzate come la Abramović o la Schneemann, ma anche solo accennate o non ancora nominate, come Valie Export, Yayoi Kusama o Ana Mendieta. Se la Schneemann è, «senza dubbio, l’artista americana che ha espresso con più radicalità la differenza di genere», impostando «tutte le sue azioni sulle tematiche riguardanti la sessualità e l’erotismo in una prospettiva femminista», la Mendieta, avendo alle spalle una a dir poco «movimentata adolescenza», intaglia per anni «la sua silhouette attraverso performance e sculture materiche per incarnarsi all’interno di quella proiezione che è la madre terra, ascendendo e relegandosi ad essa, attraverso forme scavate nella sabbia e nella polvere, in quel rimando esiziale che è Cuba». Sul sentiero dei traumi infantili si incontra inevitabilmente anche la Kusama, che «fugge da un Giappone minato dal patriarcato e da una situazione familiare complicata […] per approdare a New York. Qui, avviene la prima svolta psichica e, come da manuale, tenta di elaborare il trauma attraverso l’azione comportamentale che, mescolandosi alle invettive femministe dell’epoca, la portano a inscenare performance in luoghi pubblici non prima di aver realizzato una vasta serie di installazioni», tipicamente connotate dal quel «pois segnico» che replica il «seme che l’azienda di famiglia coltivava e vendeva insieme a piante e verdure». Il patriarcato è oggetto di una critica spietata in Valie Export, la quale «si avvicina agli azionisti viennesi rappresentando una sorta di intuizione femminista connotata, oltre che dalla differenza sessuale, dalla variazione dei linguaggi adoperati», così come nella meno nota Natalia LL, che si impegna a ridiscutere il bene di consumo in un’ottica femminista, ponendo sotto accusa, non senza l’espediente dell’ironia, «il potere fallocentrico», mentre Marianne Wex analizza più di ogni altra la dimensione del genere eludendo «ogni tentazione spettacolare».

Col quinto capitolo si passa dall’identità di genere a quella razziale, benché, premette la Macrì, la scelta di includere certi artisti in un unico contenitore non vada certo intesa come «intenzionalità di ghettizzarli all’interno di qualsivoglia schedatura razziale»; ella mira piuttosto a «riportarne interamente il gesto espressivo nella loro corrosiva potenza poetica/politica». Qui trova posto dunque David Hammons, che adopera «La radicalità di pensiero e la devianza comportamentale come tattiche di attacco al potere dell’art system e alla sua egemonia di mercato», ma al suo fianco compaiono anche altri artisti afroamericani, insieme ai quali negli anni Settanta a Los Angeles fonda lo Studio Z. Tra essi Senda Nengudi, che, «evitata dagli espressionisti astratti americani e ignorata dalle femministe bianche», configurandosi insomma «come una creatura anomala anche nei circoli più rivoluzionari», «rimane nota per l’adozione di un materiale desueto, il collant di nylon, variamente stirato, annodato, riempito di sabbia e trasformato in filamenti e prolungamenti tentacolari che maschera la profondità del suo riporto». O Ulysses Jenkins, il cui lavoro multimediale «rientra in quell’annosa controversia sulla nozione di rappresentazione della realtà attraverso i media e di come essa, attraverso la fusione di immagine, suono e iconografia culturale, viene costruita e manipolata»; tutto ciò per un afroamericano di allora significa innanzi tutto muovere una «critica agli stereotipi culturali sul popolo nero creati dalla cultura popolare americana e tramandati dalla pervasività del video e della televisione». Ad un altro gruppo, l’Anti-Formalist Reclamation Organizzation, ma anche ad un’epoca e ad una generazione successiva, appartiene Sherman Flaming, «coinvolto in una pratica performatica che risente fortemente della corrente più classica della performance art, orientata all’autolesionismo fisico», nonché capace di rimandare «ai giochi d’infanzia, ai rituali e alle danze di derivazione africana e del Black Atlantic». Parimenti estranea allo Studio Z è Lorraine O’ Grady, con la quale torniamo però alla «questione della soggettività femminile nera»: i suoi «cicli performatici parodici e al tempo stesso pungenti» sconfinano «nel suo doppio o, più sottilmente, nella nozione di changing same ripescato» dal celebre poeta afroamericano Amiri Baraka. La O’ Gredy dichiara in più occasioni che «il suo lavoro non sarebbe mai stato compreso senza le mostre di artisti come Adrian Piper e David Hammons nel 1988-89». La Piper ‒ altra artista celebre del capitolo, benché non propriamente una afroamericana, bensì «un soggetto di razza mista come tutti gli americani poiché è per 1/32 malgascia, per 1/16 nigeriana e per 1/8 dell’India dell’est, oltre ad avere antenati britannici e tedeschi» ‒ più che una performer è una attraversatrice di media, e con essi mira, stando alle sue stesse parole, «ad attaccare il razzismo sulle singole transazioni interpersonali, quelle più elementari da cui i neri hanno imparato dai bianchi di essere sgraditi nella società tradizionale».
Gli ultimi tre capitoli possiedono una affinità di fondo, la questione del postumano che si affaccia prepotentemente nell’ambito delle arti visive – e non solo ‒ a partire dagli inizi degli anni Novanta, trovando un suo momento di sintesi – come è noto – fin dal 1992 con la mostra Post Human, curata da Jeffrey Deitch prima al Museo di Arte Contemporanea di Losanna e poi al Castello di Rivoli. Solo nel primo dei tre è però evocata esplicitamente nel titolo la nozione di postumano, mentre il secondo possiede in pratica un taglio monografico su Mattew Barney e il terzo preferisce il meno inflazionato e più specifico aggettivo «postorganico» associato al sostantivo «corpo», evocando quello che è forse il più celebre dei libri della Marcì, Il corpo postorganico (1996), appunto.
Naturalmente il terzultimo capitolo risale sovente a prima degli anni Novanta, aprendo con la questione dell’HIV, in virtù della quale è immediatamente agganciabile Félix González-Torres, il suo «darsi simbolico», le sue forme fragili «per mettere in scena la mia paura di perdere Ross, che scompariva a poco a poco davanti ai miei occhi», ma anche ritornando inevitabilmente ad attraversare umori già in parte esplorati nel capitolo sul perturbante. Si pensi a Paul McCarthy, intento a dissotterrare «varie abiezioni» per renderle «repellentemente visibili»; a scoprire «ogni recesso disgustoso della psiche, ogni sepolto istinto primordiale». Leggermente più giovane, ma a lui immediatamente accostabile è Mike Kelly, che analizza la «memoria individuale e collettiva» tirando in ballo «una molteplicità di temi: dalla storia dell’arte alla cultura popolare, dai miti della società americana ai suoi aspetti folkloristici e vernacolari, dai linguaggi della controcultura giovanile alle questioni dell’identità, dalla musica ai linguaggi del cinema e della televisione». Non lontanissima da tali poetiche sembra collocarsi inoltre Janine Antoni, con le sue perfomance che «Dalla masticazione alla suzione, al consumo compulsivo di cibo […] mettono in moto le tracce di perversioni orali individuabili socialmente».
Probabilmente i semi del perturbante vengono rinvenuti da alcuni di questi artisti nell’opera di un collega di fatto non troppo più anziano, ma di precoce fioritura e rilevanza come Bruce Naumann, nel quale affiorano peraltro riferimenti di grande pregnanza «ad autori come Ludwig Wittgenstein, Samuel Beckett, Merce Cunningham, John Cage, Steve Reich e Alain Robbe-Grillet». Altra artista ormai pienamente storicizzata che compare in questo capitolo è la prematuramente scomparsa Francesca Woodman, inclusa pur non essendo artefice di performance dal vivo, giacché, malgrado l’uso della fotografia, «Il suo corpo è il solo medium che la vitalizza, la vivifica e la eccita nel proiettarlo all’esterno, tra la tentazione di un narcisismo forse auto appagante e la «minaccia» di una sua sottrazione». Con una piccola proiezione cronologica in avanti giungiamo invece a Pilar Albarracín, la più giovane tra gli artisti inclusi nel primo volume e, non a caso, già pronta per tentare una decostruzione «dell’eredità bodysta attraverso quel potenziale critico che la libera concettualmente dallo standard autolesionista». Infine, Jana Sterbak, non tanto con i «vestiti di carne», quanto con i successivi indumenti telecomandati, getta idealmente un ponte verso le pratiche, comunque ben più radicalmente post-organiche, degli artisti dell’ultimo capitolo.
All’interno di questi temi un protagonista di particolare rilievo è senz’altro il già menzionato Matthew Barney, parlando del quale risulta impossibile non incentrare il discorso sul suo «video-kolossal» in «cinque partizioni video», Cremaster, che lo tiene impegnato per gran parte degli anni Novanta. La Marcì, prendendosi la premura di descrivere ciascuna partizione con una certa dovizia di particolari, commenta: «Oltre il maschile e il femminile, al di là degli schemi omologanti della sessualità politicamente corretta, oltre la piatta divisione binaria e oltre il corpo catalogato, assemblato e incasellato del gender, quello inventato da Barney ha deviato negli abissi della differenziazione sessuale, giocando sullo scarto ruolizzante, incarnando molteplici identità attraverso la materia plastica. Nell’aura postumana in cui si sono calati molti artisti, Barney ha evidenziato il lato più glamour e desiderante che potesse inglobare la trasformazione del corpo».
Infine, l’ultimo capitolo che include meno artisti, ma quelli più profondamente implicati nei discorsi sul cyborg, «identità ibridata tra macchina e organismo e che consente di superare le dicotomie tra umano e meccanico». La filosofa americana Donna Haraway, autrice del Manifesto cyborg (1985), «teorizza la possibilità di sovvertire non solo il concetto di genere, ma anche quelli di razza, di classe e di nazione, aprendo possibilità di riscatto per tutte le minoranze. La sua teoria culturale interconnette scienze sociali, filosofiche, ideologiche e politiche all’interno di un cyberspazio quale luogo privilegiato del femminile». È «In quest’ottica di riscrizione della soggettività» che vanno intesi artisti come Orlan, coetanea di altri protagonisti della performance emersi negli anni Settanta, durante i quali pure compie operazioni che restano storiche, ma indelebilmente ancor più legata agli anni Novanta, in quanto artefice di quello che è probabilmente il più compiuto incontro tra la Body Art e la chirurgia plastica, o come Stelarc, parimenti esordiente negli anni Settanta, ma intento a lavorare alle ibridazioni tecnologiche dagli inizi degli anni Ottanta, pur sviluppandole lentamente, si pensi al «vestito elettronico che gli consente di lavorare sull’amplificazione come processo estensivo corporeo (1981-1994) o alla mano artificiale […] attivata dai segnali EMG dei muscoli addominali e della gamba (1981-1994)». Più giovane rispetto agli ultimi due, ma fin dalla fine del decennio Ottanta decisamente impegnato nel medesimo senso, è poi Marcel-Lì Antúnez Roca, che «ha generato all’interno dell’attitudine comportamentale un’investigazione tecno-corporea fondamentale».
Così si arresta il primo dei due volumi. Fin troppo facile rimproverare qua e là omissioni di particolari performance o proprio di artisti in toto. Del resto, malgrado la ricercatezza della scrittura, accattivante ma non certo schematica, è probabile che gli intenti della Macrì siano anche – legittimamente ‒ divulgativi. Non spiegherei altrimenti la scelta di commentare ampiamente anche opere non propriamente riconducibili all’alveo del performativo di artisti relativamente noti. D’altra parte, le sue non infrequenti digressioni concernenti altri linguaggi artistici o la sua scelta di includere anche soggettività esterne al sistema dell’arte ufficiale riscattano ampiamente le lacune che nessuna ricognizione, anche la più ambiziosa, potrà mai evitare.
Il secondo volume radicalizza – nel bene o nel male – la tendenza a soffermarsi con ampio respiro su singole opere ed autori, cosicché, pur essendo ancora più corposo del primo, l’indagine si focalizza su molti meno artisti, configurandosi in definitiva più come una somma di brevi monografie. Una opzione certamente da ricondursi, come si è già udito, alla volontà di assecondare certe pulsioni empatiche, ma probabilmente anche dovuta alla distanza storica ancora scarsa che ci separa dalla materia.

Irrinunciabili le presenze di Vanessa Beecroft, Tino Sehgal e Anne Imhof, accomunati, se non altro, da un successo subitaneo. In verità il repentino movimento ascendente della prima è ancora dentro il secolo scorso, mentre quello dell’ultima ripeterebbe «esattamente la fenomenologia che accompagnò vent’anni fa Vanessa Beecroft». Le analogie non si fermerebbero però qui, giacché l’una e l’altra, «benché con difformi filologie», si muoverebbero «nello stesso spazio retorico e letterario che avviluppa in sé le dimensioni del vuoto, dell’apparente e del simulacro». Cronologicamente a metà tra le due si colloca l’emergere di Sehgal, probabilmente il primo artista a ripensare in maniera così profonda il paradigma della performance nel XXI secolo: egli «disossa totalmente la semiotica performatica dalla sua ortodossia finora intoccabile, la decostruisce e la rimodella in un dispositivo ammaliante di reificazione dell’esperienza collettiva».
Tra gli italiani spiccano inoltre Nico Vascellari, «un soggetto miracolosamente in progress, così liberamente volatile e irricattabile che afferrarlo solo parzialmente nel suo labirinto vitale, diventa un’escursione imponderabile, nonché intrigante. […] Sicché, come su una pista da skating, l’artista ondivaga attraversando a suo modo vari territori: musica, arte (corpo, scultura, installazione, collage, fotografia, disegno, video), autoproduzione, spazio indipendente, store, abbigliamento, capsule collection, video channel, auto-finanziamento, comunità»; Cesare Viel, che, «attraverso performance, scrittura e voce, disegno, audio e video, fotografia, scultura e installazione», veicola «Lo sfaldamento del sé. Le uscite del corpo-mondo e le entrate del corpo-parola. L’inconscio individuale e l’inconscio politico. L’archeologia del sapere e il sapere come oggettivazione del presente. Fratture e suture, disgiunzioni e ricongiunzioni, voli e planate»; Marcello Maloberti, che si avvale di «un corpo paradossalmente «normale», estratto dalla quotidianità, spesso intimità e declinato in sintagmi di ordinaria assurdità, di sorpresa metafisica, di movimento improvvido, di intermittenza incongruente e di corrispondenza alchemica»; Enzo Umbaca, che «Sorprende soprattutto [per] l’intensità delle azioni che mescolano, con una leggerezza calviniana, la densità del proponimento alla ironica o sarcastica o dissacrante lettura di esso, in una duplicità di significazioni che confluiscono in avventate (spesso) modalità di plasmazione»; Jacopo Miliani che trasforma la danza contemporanea in «un serbatoio infinito di immagini, di cose, di musica, di parole e di odori che forgia la sua complessa architettura e in cui tutti questi elementi innescati, concorrono a scatenare una intensa emozionalità».
Uno spazio minore, ma non per questo minore cura, è riservato invece a Sissi, il cui «percorso è scandito in un arcipelago di robe-sculpture, dall’appeal sorprendente che compendia la sua ventennale ricerca corporea di cui l’abito, per la sua significazione identitaria, è il centro enunciativo»; ad Alessio Bolzoni, la cui geometria espansa, «attraverso atti corporei mirabolanti a cui sottopone i suoi modelli», in quanto fotografo di moda, oltre che artista, «è espressione di una performatività liminale, che devia dalla canonicità» ‒ insieme alla Beecroft, Sissi e Bolzoni compongono peraltro il trio di coloro che la Macrì chiama i Fashonist ‒; a Marinella Senatore, fondatrice di «The School of Narrative Dance» (SOND), «la scuola nomade e gratuita, basata sulla narrazione di storie e su un sistema didattico incentrato sull’emancipazione, l’inclusione, l’autoformazione dello studente»; a Francesco Arena, che, classificato tra gli artisti-performer della «durata», sulla scorta del pensiero bergsoniano, la intende come «distanza temporale tra un’azione immutabile, invariabile, definitiva e il presente»; ad Andreco, che coniuga «inconscio situazionista» e formazione da «ingegnere ambientale […] da sempre impegnato in tematiche che riguardano connessioni tra arte e scienza, tra sostenibilità ambientale e urbanistica, tra corpo umano e città, tra ecologia e giustizia sociale».

Quest’ultimo è inserito nel novero degli artisti che intendono «La performance come parata» ‒ «una metodologia che affonda nel coacervo sperimentale degli anni Sessanta» ‒, cui afferiscono anche alcune operazioni di Jeremy Deller, che «Riattualizzando il concetto di festa collettiva in party, happening ad environment art […] tributa la comunità e i gruppi sociali della città» e di Francis Alÿs, che, «con un’azione metaforica e bizzarra, converte la ritualità della processione religiosa in culto feticistico dell’opera d’arte» ‒ l’inglese e il belga sono peraltro due artisti ai quali la in passato la Macrì dedica studi molto ampi ‒, nonché la «pratica multidisiplinare» di Theaster Gates, «che include scultura, pittura, installazione, musica e performance, oltre alle importanti azioni di riqualificazione urbana con il coinvolgimento delle comunità locali».
Altri esponenti della «durata», oltre ad Arena, sono infine John Bock, nel quale essa «acquista una sua dimensione filologica», inscenando di fatto «parodie di conferenze accademiche», intendendole «come una sorta di Gesamtkunstwerk che dissolve i confini tradizionali della pratica performatica ed espone forme critiche alle istituzioni», e – probabilmente più di chiunque altro ‒ Ragnar Kjartansson, le cui performance «si dilatano per ore, giorni, mesi persino, si consumano intorno al concetto di durata che, certo rimanda all’endurance art, ma che si scolla da essa poiché la resistenza fisica non è l’obiettivo, ma lo strumento per assurgere ad altro».

Se Teresa Macrì oscilla tra la polarità della lettura generale situata nell’arco cronologico e quella della focalizzazione di singoli casi studio ‒ e nel secondo volume, come abbiamo visto, sembra sbilanciarsi maggiormente verso la seconda opzione ‒, Francesca Gallo rinviene chiaramente l’argomento di Parole, voci, corpi. Tra arte concettuale e performance. Conferenze, discussioni, lezioni come pratiche artistiche in Italia (Mimesis, 2022) in una «particolare pratica artistica» ‒ e quindi in un particolare tipo di performance ‒ «oggi nota come performative lecture». Parimenti circoscrive geograficamente la sua ricerca alle «sue declinazioni italiane» e soprattutto – questa probabilmente la maggiore peculiarità del suo studio – risale alla «fin qui sostanzialmente ignorata archeologia», a fronte di una situazione internazionale ben diversa, come dimostra poche pagine dopo dando conto di tutta una serie di studi, ed anche di occasioni espositive in prestigiose cornici, che perdurano da decenni. La Gallo è infatti convinta di poter individuare «importanti antecedenti negli anni Settanta, in particolare in Vincenzo Agnetti, Giuseppe Chiari e Luca Patella che a ridosso delle esperienze internazionali di Vito Acconci e Joseph Beuys esplorano il parlato, la conferenza e il dibattito come forme d’arte autonome e in sé concluse».
Questione ineludibile peraltro è quella dei confini della lettura performativa: «In generale, la conferenza performativa si diparte dall’accresciuta dimensione discorsiva all’interno delle arti visive e in qualche modo deriva dal peso degli insegnamenti teorici delle scuole d’arte, almeno dagli anni Settanta in poi, per saldarsi oggi, invece, con la diffusione dei cosiddetti artisti ricercatori»; «In Italia, nonostante la formazione nelle accademie d’arte rimanga d’impostazione più tradizionale, la conferenza performativa nel clima dell’arte concettuale da un lato si innesta su sperimentazioni linguistiche di matrice verbo-sonora e poetica tout court, dall’altro attrae figure provenienti da ambiti disciplinari eccentrici rispetto alle belle arti»; tuttavia alcuni critici, notando che in essa «il linguaggio verbale non corrisponde all’autorità del significato», additano come «limitativo se non contraddittorio ridurre tale pratica all’ambito delle arti visive e delinearne una genealogia in ambito concettuale». La stessa Gallo è ben consapevole di quanto «le conferenze performative o conferenze-performance» ‒ divenute «quasi un genere, a metà strada tra l’intervento divulgativo e l’azione performativa vera e propria» ‒ «non siano esclusivo appannaggio delle arti visive». Tanto è vero che sente il bisogno di richiamare lo Speakers Corner in Hyde Park a Londra o addirittura la conversazione «fra docente e discente» che «rimonta almeno all’antica Grecia» per testimoniare l’antichità – e l’extra-artisticità – di certi modi. Non di meno, e pur non sottraendosi alla discussione su una mai esauribile problematicità, la vocazione alla contaminazione, sia pure episodica, attraverso operazioni ed esponenti estranei al sistema dell’arte tipica della Macrì non sembra appartenerle: «il presente studio si concentra su queste ultime» ‒ cioè sulle arti visive ‒ «tralasciando posture performative di eminenti intellettuali di fronte al pubblico».
Le genealogie possibili comprendono dunque episodi ed esponenti legati al Dada, al Surrealismo, al Bauhaus, al Black Mountain College, a Fluxus, ecc., coinvolgendo anche artisti che non ci si aspetterebbe immediatamente di trovare in un tale contesto, come Mimmo Rotella o Ad Reinhardt. «La discussione pubblica come opera d’arte» è però «resa celebre soprattutto dall’impegno ventennale di Joseph Beuys», la cui attività «con l’ausilio delle lavagne», tesa a declinare «la propria idea di «arte come scultura sociale»», è indubbiamente assai nota in Italia. Molto meno lo è, di contro, il Dan Graham «che in quegli stessi anni propone una formula di conferenza performativa più dialogica, basata su micro gruppi, in cui le tecnologie audiovisive aiutano a destrutturare l’univocità della comunicazione». Inoltre, «Un discorso a parte merita, nella prospettiva qui adottata, Vito Acconci», poiché «il suo lavoro ha una forte componente verbale nella fase precedente e successiva alla sua esplicita adesione alla Body Art»; «sulla scorta della fama internazionale che filtra anche in Italia», egli rappresenta «un imprescindibile punto di riferimento anche nel nostro paese».
Si giunge così ai grandi «pionieri» italiani degli anni Settanta: Luca Patella, che da «singolare sperimentatore di tecnologie dell’immagine fin dalla metà degli anni Sessanta, negli interventi di carattere performativo si distingue per la preferenza accordata alla lavagna luminosa», in quanto «strumento immediatamente evocativo della proiezione in senso sia ottico, sia psicologico, connessa allo studio della percezione psico-fisica che tanto lo affascina e rinforzata dalla partecipazione di psicologi, oltre che di linguisti, sociologi e critici d’arte»; Giuseppe Chiari, «singolare figura di compositore» nella cui nuova concezione della musica e dell’esecuzione «L’oralità compare precocemente», conducendolo ad una pratica discorsiva che, nel suo «forte carattere ironico, verso la cultura ufficiale e paludata dispensata nelle aule universitarie e nei conservatori», appare assolutamente in consonanza «con l’erosione della distinzione fra cultura alta e produzione dal basso» alla base di Fluxus; Vincenzo Agnetti, la cui ricerca sul linguaggio verbale è spesso un’occasione per riflettere sulla funzione dell’artista ed anche su quella della critica d’arte, come avviene nella conferenza di Ferrara del 1977, ove pare individuare una nuova modalità di intendere quest’ultima, «non più identificabile con la proiezione sull’opera del libero pensare o sentire del critico, ma piuttosto da intendersi come verifica dei principi che l’autore deve aver chiarito a monte dell’operazione artistica».
Contemporaneamente, la lettura performativa trova spazio in importanti occasioni espositive italiane, come la Biennale di Venezia del 1976, nell’ambito della quale «si svolge Attivo, una delle prime rassegne istituzionali interamente dedicate alla performance», ove, oltre a Chiari, operano in tal senso Eleanor Antin e Dennis Oppenheim, o l’ epocale Settimana internazionale della performance che si tiene nel 1977 a Bologna, «in cui sono in molti a puntare sul linguaggio verbale», oltre ad Acconci e Patella, Peter D’Agostino, Susan Lacy, Miro Polacci, Michele Sambin, Arrigo Lora Totino e Luigi Viola. Sempre nel 1977, inoltre Annina Nosei Weber cura alla New York University Discussion, «la prima rassegna interamente dedicata a tale genere», che vede «l’eccezionale partecipazione di Giuseppe Chiari», «unico italiano coinvolto».
Fin dagli anni Sessanta «la dimensione performativa della poesia» si incunea «profondamente nel mondo delle arti visive»: si pensi agli esponenti del fiorentino Gruppo 70; a Stripsody (1966), «volume nato dalla collaborazione tra la già celebre Cathy Berberian, Umberto Eco ed Eugenio Carmi, che raccoglie le serigrafie di quest’ultimo e le registrazioni su disco dei vocalizzi delle onomatopee rese popolari dal fumetto»; all’ «area degli approcci più concettuali » di Ferruccio De Filippi o di Gianfranco Notargiacomo; al «libro Hyde Park di Gianni Emilio Simonetti (1978)», che omaggia nel titolo la «tradizione londinese del libero discorso pubblico, in cui l’autore declina le teorie marxiane del lavoro e del capitale nel campo dei sistemi di comunicazione, sottolineando il contributo di valorizzazione fornito dalla voce […], in quanto espressione pulsionale libera anche dalle funzionalità produttive (del capitale)»; ad Anna Oberto, nella quale «il racconto e la rievocazione di figure femminili provenienti dall’ambito letterario delineano una sorta di rinascita individuale, di nuova definizione del soggetto femminile». E sono solo alcuni degli esponenti italiani.
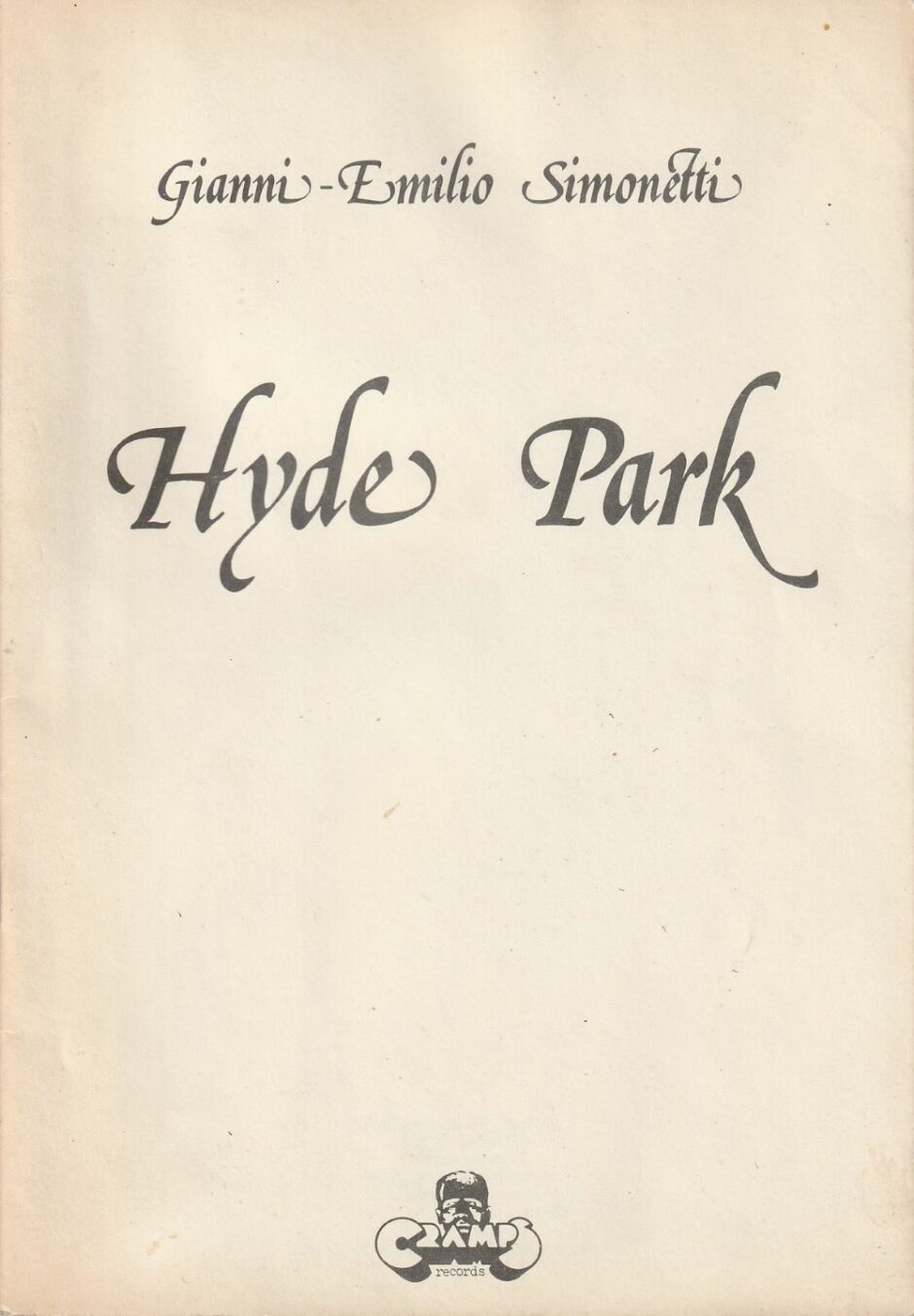
La radio, più o meno a partire dalla metà degli anni Settanta, «svolge un ruolo importante sia nella diffusione di tali ricerche, sia nella sperimentazione di un diverso modo di occupare uno spazio pubblico appena liberalizzato, l’etere». Se Giovanni Fontana, «protagonista e studioso di tale campo espressivo, nota che la «cosiddetta nuova oralità […] stabilisce un rapporto privilegiato con i nuovi media», è un giovanissimo Cesare Pietroiusti a sperimentare le radio libere come nuovo strumento per gli artisti visivi, mentre qualche anno dopo «perfino l’emittente pubblica rilancia e diffonde le sperimentazioni verbo-sonore: la «trasmissione Fonosfera, andata in onda su Radio Uno tra il 1979 e il 1981 nella fascia pomeridiana», accoglie, a poca distanza l’uno dall’altro, interventi di Luca Patella e di Lamberto Pignotti.
Sorta di anelli di congiunzione tra la stagione degli anni Settanta e la nuova epoca che si apre con gli anni Novanta sono poi due artisti di diversa generazione, ma entrambi singolarissimi, oltre che entrambi romani. Uno è Fabio Mauri, che, pur appartenendo indubbiamente alla generazione delle neoavanguardie, «si cimenta nelle conferenze con performance» non prima del 1987 e solo fino al 1991. La Gallo ipotizza un legame tra tale inizio così tardo e la scomparsa di Beuys, ovvero dell’artista «che aveva in qualche modo incarnato il medium, per così dire», l’anno precedente (1986), nonché con la circostanza per cui Mauri si trovi «in un momento in cui l’attenzione critica verso il suo lavoro sembra affievolirsi». L’altro è il già ricordato Cesare Pietroiusti, nella cui prassi artistica il linguaggio verbale possiede un ruolo costante, fin dal decennio in cui affianca Sergio Lombardo ed Anna Homberg nell’attività del Centro Studi Jartrakor, fondato nel 1977, ove ha «la sua iniziazione al mondo dell’arte».
Si arriva così, a partire dall’ultimo decennio dello scorso secolo, al tempo delle performative lecture vere e proprie, e qui gli esempi abbondano: da Alberto Zanazzo, che «individua nel convegno e nella conferenza modalità particolarmente congeniali al sostrato filosofico che innerva il suo modo di lavorare», a Gianni Piacentini, «uno dei primi a restituire alla conferenza in sé autonoma un coefficiente performativo e uno statuto di opera»; da Stalker Osservatorio Nomade, un caso in cui «la restituzione verbale, in forma di conferenza, fa parte del processo», a Mauro Folci, nel cui lavoro, costantemente connotato da una «spiccata vena politica» ‒ in «decenni in cui si inneggia allo spontaneismo e alla naturalità degli istinti contrapposti alla tendenza normativa e coercitiva della società borghese» ‒, «il linguaggio verbale, in forma scritta e in seguito anche orale, assume centralità già alla fine degli anni Novanta»; da Marzia Migliora, che «trasforma la classica audio-guida da museo, chiedendo a diciassette persone estranee al mondo dell’arte di raccontare ciò che viene loro evocato da 24 opere della collezione del Museo del Novecento di Milano» (2009-2011), a Tea Andreoletti, che dal 2015 si trasferisce «a Budapest allo scopo di imparare a tirare di fioretto in una lingua a lei totalmente sconosciuta» e quindi, non avendo «prodotto alcuna documentazione visiva», «si limita a raccontare, per lo più in presenza, tale esperienza», ma «senza altro tipo di supporto, né visivo né gestuale, se non la sua mimica naturale»; dalla compianta Chiara Fumai, che «parla spesso della propria ricerca in termini di slavoro, con riferimento alla «contestazione radicale che [Valerie] Solanas rivolgeva all’etica capitalista del lavoro» […], ma con l’intenzione, spiega Giovanna Zapperi, di rovesciare i «meccanismi della produzione e del consumo dell’arte», ad Alessandra Ferrini, «uno degli esempi migliori per capire come la conferenza performativa si stia diffondendo nelle pratiche artistiche contemporanee anche grazie ai cosiddetti artisti ricercatori, visto che il dottorato di ricerca presso l’University of the Arts, a Londra, la spinge a sostanziare ulteriormente la naturale componente teorica e discorsiva del lavoro».

Un paragrafo a parte, quello conclusivo, è infine dedicato alle «lezioni di storia dell’arte», ché «Fin dagli anni Settanta gli artisti talvolta impersonano il ruolo di docente di storia dell’arte, mutuandone lessico, argomenti e posture, con intenti ironici, decostruttivi o esplicitamente polemici verso la struttura valoriale incarnata dalla narrazione ufficiale e/o dal sapere accademico» – Agnetti e Patella sono i nomi da fare innanzi tutto. Così nel 2015 Pasquale Polidori si cimenta in una conferenza performativa su Fountain, «collegandolo alla biografia più intima di Marcel Duchamp e in particolare al suo presunto orientamento omosessuale»; nel medesimo anno Cesare Viel – artista che abbiamo già visto essere tra i più cari alla Macrì – «propone una delle sue classiche azioni basate sul linguaggio verbale e sulla propria presenza scenica, a partire dal riferimento al fondatore del Bauhaus», Walter Gropius, del quale ripete, con innumerevoli varianti, una frase, per poi contrapporla ad un’altra di Wittgenstein, «come una sorta di allusione all’uscita dalla claustrofobica permutazione tipica dello stile razionalista».





condividi