Una metafora per l’umanità
Opere d'arte e nuovi inizi

Recentemente Quodlibet ha pubblicato un importante volume di Gabriele Guercio dal titolo «Opere d’arte e nuovi inizi»: Nel quadro di una prospettiva paradossalmente storicizzante, il libro tenta di dare conto dell’ex nihilo artistico e della sua operatività, invitando a giudicare l’arte passata e presente al di là delle volatili oscillazioni del gusto e della demagogica supposizione di una continua e inarrestabile moltiplicazione dei prodotti creativi. Qui pubblichiamo un estratto del capitolo 11 che pone diverse questioni interessanti per il dibattito contemporaneo e la teoria dell’arte.
***
Nel 2012, in un testo dedicato a El Anatsui, artista ghanese trasferitosi in Nigeria nel 1975, Okwui Enwezor, l’allora direttore della Haus der Kunst di Monaco, elogia la sua arte osservando che egli risponde «a ogni materiale con il quale lavora come se l’avesse incontrato per la prima volta nel flusso della storia». Il più significativo artista africano della sua generazione, nonché uno dei pochi scultori ad avere inventato «un linguaggio visivo unico e completamente nuovo con le sue sculture intessute di metalli» (il riferimento è ai cosiddetti “arazzi metallici”), Anatsui si avvale della frammentazione quale tecnica compositiva che funziona «da mordente promemoria di quanto anche le opere più astratte possano avere la capacità di umanizzare gli oggetti più umili». In questi casi, il lavoro della mano dell’artista – il laborioso e silente compito di appiattire i tappi delle bottiglie di alcolici; la torsione dei fili di rame in sottili viticci di metallo che suturino un pannello appiattito con un altro; la tessitura di questi pannelli in un unico, risplendente pezzo epico – serve da metafora per l’umanità.
Occorrenze alquanto rare nella recente letteratura artistica, simili affermazioni paiono riproporre un assunto qui ripetutamente studiato in sé e nelle sue cangianti manifestazioni. Enwezor, cioè, sembra propenso a credere in un legame inalienabile tra un’opera d’arte che inizia nel e dal nulla e la realtà umana. A suo dire, Anatsui si confronta con le cose da lui utilizzate e le “umanizza” nel proprio lavoro come se vi interagisse in maniera inedita. Nell’arrestare il flusso del processo storico dimostrando che una seconda vita è possibile, che si può (ri)cominciare ora e ancora, egli avrebbe quindi la capacità di sfidare la datità del dato e di liberare lo spazio affinché affiori il nihil che si accompagna alla comparsa del nuovo – nel suo caso, un linguaggio integro composto di elementi poveri e materiali di scarto.
Quando Enwezor scrive le frasi succitate, le composizioni multiformi di Anatsui sono già da qualche anno oggetto di progressiva ammirazione nel contesto istituzionale dell’arte contemporanea, dove si assiste a un proliferare di voci euforiche che ne decantano il prodigio, la sorpresa e lo strepitoso successo, pur ammettendone il carattere dai risvolti molteplici, se non addirittura ineffabili. La definitiva affermazione internazionale dell’artista data al 2007, in occasione della sua partecipazione alla 52a Biennale di Venezia: due opere vengono esposte all’Arsenale e una terza sulla facciata di Palazzo Fortuny.
Robert Storr, il direttore della rassegna veneziana, avverte nel catalogo che quegli “scintillanti” murali potrebbero venire erroneamente fraintesi per esempi di arte decorativa africana, laddove invece veicolano la carica simbolica, sociale e rituale di quella stessa cultura. Non solo: presumibilmente al fine di mostrare la loro collocazione in un quadro storico-artistico di tipo transcontinentale, Storr paragona la loro struttura policromatica a un’analoga tendenza riscontrabile nelle opere di autorevoli artisti occidentali quali Gerhard Richter, Ellsworth Kelly e Georges Seurat.
Sebbene da un’angolazione diversa, attinente alla storia e alla memoria, lo stesso Anatsui ha alimentato una ricezione tesa ad ascrivere alle sue opere una potenziale risonanza planetaria. Evocando il suo incontro casuale con un sacchetto di tappi di bottiglia gettati sul ciglio della strada, egli ricorda l’immediata emergenza di una varietà di pensieri:
Ho pensato a quegli oggetti come a connessioni tra il mio continente, l’Africa, e il resto d’Europa. Oggetti come questi furono introdotti nella mia terra dagli europei quando giunsero come mercanti: l’alcol era tra le merci utili allo scambio, ma divenne uno dei beni usati nel commercio transatlantico di schiavi: il rum prodotto nelle Indie occidentali fu trasferito a Liverpool e poi riportato in Africa, così ho pensato che i tappi delle bottiglie avessero un forte riferimento alla storia africana.
I suoi intarsi metallici trovano quindi un referente problematico negli abusi di potere che hanno reso il continente africano preda di schiavitù e mercantilismo. Nel primo decennio degli anni 2000, opere che affrontino simili temi sono particolarmente ben accette, perché paiono fornire una solida conferma dell’avvento dell’era postcoloniale, di un’epoca segnata da positivi processi di democratizzazione senza frontiere. Agli occhi di critici, curatori, collezionisti e direttori di museo, Anatsui e la sua arte diventano entrambi l’epitome di una strabiliante innovazione che avrebbe squarciato il velo lasciando emergere una realtà artistica finalmente esperibile al di là dei conflitti razziali, politici e culturali di cui la modernità fino al Novecento era stata tristemente istigatrice. Se negli anni Settanta, con l’arte concettuale, il progetto di uno spazio a-centrato di artisti, opere e idee, pur motivato da spinte interne a una pratica dematerializzata e ubiqua, non aveva avuto modo di realizzarsi (…), adesso è una mutata condizione geopolitica, il presunto incrinarsi dell’egemonia occidentale, che sembra offrire l’opportunità di ridisegnare la dialettica tra centro e periferia nel manifestarsi dell’arte sul pianeta. Non a caso, negli anni in cui la fama di Anatsui è in ascesa, non solo si ripropone l’esigenza, già avvertita dagli storici ottocenteschi e novecenteschi, di investigare l’arte quale fenomeno millenario e planetario, ma cresce anche il bisogno di interrogarsi su se e come esista un’arte contemporanea globale; se e come la stessa disciplina storico-artistica possegga o debba sviluppare delle metodologie che tengano conto della realtà mondiale.
Eppure, non appena si prova a ragionare in termini di globalità e di arte contemporanea globale indipendentemente dal verdetto del museo e dell’economia, si rileva come scarseggino i criteri alternativi di legittimazione. Le pratiche artistiche che d’ora innanzi assurgono alla ribalta e scatenano interesse e pubblicità nel contesto ufficiale attuale non solo mirano a posizionarsi in una supposta totalità planetaria, ma resistono tanto alle valutazioni basate su proprietà intrinseche (formali, procedurali e simboliche) identificabili all’interno di un campo storico-artistico delimitato (europeo, asiatico, nord-americano etc.) quanto alla verifica delle realtà esterne (sociali, politiche etc.) con cui si confrontano o dentro le quali si sviluppano. Si potrebbe aggirare l’ostacolo provando a giudicare l’arte in base ai suoi contenuti, ma sarebbe un approccio rischioso, perché, una volta svalutata la forma, lo stesso significato di un’opera può perdere di distinzione e apparire genericamente paragonabile a quello rintracciabile in altre tipologie di espressione, siano esse visive o no. Inoltre, in un simile scenario, l’imperante convinzione che il mercato possa decidere dei meriti di opere e artisti rischia di occultare la specificità del contributo di Anatsui; d’altronde, non c’è motivo di ritenere che, poiché sottende l’organizzazione delle società e abbia offerto un modello politico mondiale, l’ideologia neoliberale sia esente da falle. (…)
Infatti, al di là dei consensi riscossi, perché dover associare l’idea di un’opera d’arte che inizia all’oeuvre di Anatsui? Si è di fronte a una svolta a livello tanto formale quanto etico-politico, o si tratta invece di un fenomeno entusiasticamente enfatizzato nella cerchia del mondo ufficiale dell’arte, che, all’inizio degli anni Zero, più si alimenta di clamore e spettacolarizzazione più vorrebbe potersi vantare di una vocazione ecumenica, di un suo presunto carattere di universalità?
Per un verso, il modus operandi di Anatsui richiama alla mente l’enigma dell’origine: egli stesso agisce come il mitico vasaio che opera ex nihilo e dà forma al vuoto nel modellare l’argilla. Le sue composizioni metalliche sorgono nella e dall’assenza di significato del detrito, di quei tappi di bottiglia che, nullificati in quanto scarto, attraversano un ulteriore processo di azzeramento e diventano “non” non essere allorché l’artista li considera come elementi generatori di un inizio: cioè, carichi di valori sia storico-esistenziali che estetici. Grazie a questa incondizionata dinamica di riposizionamento e metamorfosi, il passato viene ripensato. Non solo: è precisamente a partire dai rifiuti del mondo che sorge un altro mondo e, in esso, una diversa accezione dell’essere e del non essere. Con Anatsui, il “trovare” picassiano e la reversibilità del dato e del creato concorrono in una pratica capace, se non di sovvertire, certamente di fare leva sui rapporti di forza tra centro e periferia, tra colonizzatori e colonizzati. I mosaici di tappi schiacciati, piegati, rivoltati e intessuti tra loro non si limitano a lasciar intravedere il diritto o il rovescio delle scritte consunte delle marche di liquori (Bull, Perfect Dry Gin, Dark Sailor Rum, Ozde etc.), ma si candidano a implacabili custodi della memoria, a raccontare di lusinghe e delusioni, commerci e raggiri, entusiasmi e depressioni, tossico-dipendenza e ineguaglianza sociale. Ciononostante, però, traghettano pure un messaggio di speranza: ossia che l’arte, forte delle sue proprietà vivificanti, potrebbe contribuire alla costruzione di un habitat planetario in cui gli uni e i molti si relazionano in termini di vicinanza e reciprocità tra diversi, piuttosto che di alienazione, impostura e prevaricazione.

Per un altro verso, tuttavia, il riconoscimento internazionale delle opere di Anatsui non implica la chiusura definitiva della forbice che recide le verità e i valori locali dall’assetto di modelli comportamentali vigenti nel mondo capitalistico, dove l’acquisizione e la sorveglianza delle informazioni offrono una maniera inedita di perseguire sfruttamento, regia e controllo di ogni aspetto dell’esistenza umana. Sebbene indicativo di una mutata percezione del pianeta, lo sviluppo di una coscienza storica post-occidentale non sana le lacerazioni profonde che affliggono popoli e culture eterogenee. Nella sua fase di intensificazione durante gli anni Novanta, la ricezione dell’arte africana contemporanea ha beneficiato, almeno a livello teorico, della nozione di multiculturalismo allora in auge tra i progressisti democratici. A essa ha talvolta fatto da collante il diffondersi di un discorso della vittima, vale a dire la tendenza ad accusare un torto subito, una violenza, una mancanza, così da poter acquisire una voce pubblica e recuperare un supplemento di sé proprio in un’epoca in cui l’unicità delle coscienze è ripetutamente svalutata. Tuttavia, benché promulgatrice di equità e giustizia, è utile notare come, poco dopo la sua comparsa, la rivendicazione identitaria sembra essersi fatta cooptare dall’ideologia neoliberista nella sua capacità di attrarre nell’orbita del “primo mondo” sempre più individui, tra cui non solo migranti extraoccidentali, in un’escalation di scambi culturali e commerciali in cui prevale la logica del profitto e perdurano le diseguaglianze sociali da essa incensate e comprovate. (…)
L’ascesa di Anatsui coincide quindi con un momento storico in cui né il multiculturalismo né l’ancillare concetto di “postmodernismo” riescono a mantenere le loro promesse di mutamento epocale. Piuttosto che risolversi grazie a un efficace riequilibrio dei rapporti sociali, la subalternità persiste e denota non più unicamente la classe operaia o i sans-papiers, bensì anche i bianchi piccolo-borghesi, destinati alla proletarizzazione. La figura del subalterno rispunta, tra l’altro, nella massa informe dei consumatori, i cui comportamenti apparentemente liberi e fantasiosamente plasmati grazie all’acquisto di sedicenti beni alla portata di tutti in realtà corroborano l’asservimento collettivo alle dinamiche omologanti del marketing. Riguardo alla “condizione postmoderna” teorizzata da Jean-François Lyotard nel 1979, laddove si è intensificato il senso di frammentazione, contingenza e fine delle grandi narrative eurocentriche, a esso non si è accompagnata la scoperta di orientamenti alternativi alle alienanti forme di vita e di pensiero ereditate dalla modernità. Inoltre, benché si sia molto confidato nei meccanismi della globalizzazione quali antidoti contro il colonialismo e ogni tipo di dispotico centralismo governativo, anche qui le aspettative sono state frustrate o vanno comunque ridimensionate. Al libero mercato planetario di corpi e cervelli è corrisposto lo smodato aumento di quelle che gli antropologi chiamano “zone di contatto”, aree dove gli individui, fino a poco tempo fa geograficamente e storicamente separati, si scontrano e interagiscono tra loro spesso all’interno di irregolari rapporti di potere. Infine, non solo si moltiplicano conflitti e guerre locali, ma, secondo le analisi dell’economista Jacques Sapir, da qualche anno sarebbe in corso un processo di de-mondializzazione che ha visto alcuni stati o imperi (Russia, Cina e USA) avvantaggiarsi in maniera abnorme della liberazione dei commerci su scala planetaria.
Il contesto dell’arte contemporanea rispecchia analoghe tendenze all’accentramento dei poteri. Avvantaggiato dall’asimmetria di arti e arte discussa nel capitolo 4, può a-criticamente assumere la nozione di arte quale principio, tacito e inoppugnabile, a base di una quantità potenzialmente indefinita di espressioni artistiche che compongono carrellate di finitudini tra loro estranee se non incompatibili.
(…)
Il bandolo di contraddizioni presenti nella compagine artistica appena descritta vanifica la pretesa di voler stabilire con certezza se gli onori conferiti all’opera di Anatsui costituiscano un meritato tributo al suo carattere “universale”, al suo servire da metafora per l’umanità, oppure si limitino a soddisfare scopi a essa estranei. Allo stesso tempo, si è però incentivati a chiedersi se e in che senso si possa parlare dell’idea di nuovo inizio, di una metamorfosi dell’ex nihilo in seno alla cultura dell’arte contemporanea. A tal fine, è opportuno ritornare alla figura di Enwezor e concentrare l’attenzione sul discorso critico che ha animato la sua carriera di curatore. Infatti, egli ha contribuito non poco all’ascesa di Anatsui e, negli anni precedenti alla sua scomparsa, ha lavorato alla realizzazione di un’importante retrospettiva dedicata all’artista, inauguratasi a Monaco nel 2019.
Nell’arco di un ventennio, a cominciare dalle mostre organizzate nel 1990 fino agli svariati impegni assunti alla guida della paradigmatica Documenta 11 (2002) o della Biennale di Venezia del 2015, il pensiero di Enwezor è andato vieppiù precisandosi. Costante è stata la sua preoccupazione per la difesa dell’arte africana, una missione il cui perseguimento ben presto gli si rivela pieno di insidie per via dell’inadeguatezza dei canoni artistici dell’Occidente.
(…)
Constatando come gli apprezzamenti novecenteschi della produzione artistica dell’Africa si siano focalizzati sulla natura tribale degli oggetti piuttosto che sui loro artefici, di cui spesso si ignora il nome, Enwezor riscontra come nell’ambito postcoloniale siano invece emerse problematiche di autenticità e di affermazione identitaria. (…)
È qui che significativamente entra in gioco il concetto di autore, il quale, a dispetto del discredito di cui è stato oggetto con il diffondersi della mentalità post-strutturalista e post-modernista – una mentalità in parte condivisa dallo stesso Enwezor nei suoi scritti –, viene a illuminare la dialettica tra memoria e contemporaneità e tra culture egemoni e marginali. Si può constatarne la rilevanza proprio nel corso di una conversazione con Anatsui, quando Enwezor osserva che la sua opera pone interrogativi sulla composizione del dominio internazionale dell’arte. Egli insiste affinché ci si attenga «alle peculiarità della soggettività dell’artista e dei luoghi della pratica, che non possono venire semplicisticamente cancellati dall’idealismo di una scena artistica globale e priva di confini». L’attenzione sulla specificità di un autore permetterebbe di pensare la complessità di una pratica globalizzata senza cedere a una critica totalizzante, insieme accrescendo la fiducia che si possa essere artisti importanti e risiedere ovunque. (…)
È degno di nota che, alla domanda sul nesso tra gli aspetti concettuali e quelli manuali della sua pratica, Anatsui risponda di credere nella presenza di una charge, di una “carica” psichica o spirituale che rimarrebbe impressa negli oggetti quando li si tocca. I tappi di bottiglia sono quindi impregnati di forze antropocentriche al tempo della loro antecedente storia di commercio, consumo e scarto, ma pure in quella successiva, che li vede modificati e integrati negli arazzi metallici. Con un’immagine corale in cui realtà passate confluiscono nel presente dello studio per attraversare una metamorfosi tramite l’autodeterminazione umana, l’artista spiega che i mezzi da lui impiegati «tendono a essere cose usate dagli esseri umani, toccate dalla mano umana […] se guardi alle grandi opere sono passate per così tante mani […] nello studio, tra i trenta o quaranta assistenti lavorano a delle pièce diverse. Buona parte della complessità che l’opera talvolta effonde è il risultato di così tante mani che l’hanno toccata».
Oltre a far riaffiorare tensioni rimosse e a trasfigurare il dato attraverso l’esercizio di un’operosità autoriale allargata – cioè dell’artista e dei suoi assistenti –, gli arazzi metallici riprendono liberamente la tradizione locale della tessitura, mescolandola con due tecniche rivoluzionarie dell’avanguardia europea: il collage e il ready-made. La loro fattura propone anche una completa identificazione tra forma e medium espressivo, essendo i tappi di bottiglia sia il materiale di realizzazione dell’opera sia la sua componente eidetica essenziale. Ma questi meriti “artistici”, apprezzabili alla luce di un passato tanto africano quanto europeo, sono di per sé insufficienti per poter sostenere l’avvento di una discontinuità radicale della situazione dell’arte contemporanea. Anzi, si è notato come, pur scuotendo gusti e criteri di giudizio etnocentrici, la “sorpresa” di Anatsui non abbia scomposto nessuna di quelle consolidate procedure che, nel cementare il connubio di arte e mercato, accentuano lo scollamento tra gli ideali e i significati portati dagli artisti e la convenzionalità del sistema in cui accettano di operare. Si direbbe che l’Occidente, incarnato dal capitalismo, continui a dettare le regole del gioco. Ma se è così, allora in che senso è lecito parlare di cominciamento?
La risposta qui avanzata è che l’idea di un’opera d’arte che inizia vada compresa in un’accezione diversa da quelle finora incontrate a cominciare da Vasari. In quest’ultimo caso, la possibilità di rinnovare l’occorrenza di un esordio nella e dalla instabilità del vuoto si arresta al sostrato dei desiderata, che restano impliciti, se non inconsci. E questa irresoluta metamorfosi dell’ex nihilo è percepibile esattamente nel discorso critico che a mano a mano sorregge Enwezor nella sua attività di curatore.
In uno dei suoi ultimi impegni pubblici, la direzione del Padiglione Centrale della 56a Biennale di Venezia del 2015 – dove, tra l’altro, Anatsui si aggiudica il Leone d’Oro alla carriera – egli elegge a tema della mostra il caos e il disordine dell’attuale “stato delle cose”. Chiama a raccolta le forze immaginative e critiche di artisti e pensatori per riflettere sul presente storico del pianeta. La rassegna, intitolata All the World’s Futures, contiene appunto un implicito appello a mettere in questione e a rinnovare la nostra visione della realtà, così da contribuire alla costruzione del futuro, un compito che si direbbe ormai sfuggito al controllo di larghe fasce dell’umanità per diventare appannaggio di esigue élite. Difatti, quasi a titolo di inderogabile propedeutico, Enwezor programma per tutta la durata della Biennale la rilettura dal vivo di Das Kapital di Marx, un progetto diretto dall’artista Isaac Julien. L’analisi del mutevole carattere del “capitale” dovrebbe permettere di identificarlo nella sua facoltà di incombere in qualsivoglia ambito dell’esistenza, dalle predazioni dell’economia politica alla rapacità dell’industria finanziaria, dallo sfruttamento della natura alla crescente disparità e all’indebolimento del contratto sociale.
Ma il grido d’allarme lanciato da All the World’s Futures non allevia l’amara constatazione di essere comunque coinvolti nel bailamme, anche quando lo si denuncia e lo si vorrebbe trasformare.
(…)
D’altro canto, però, l’impostazione teorica dell’esibizione non è esente da falle. L’auspicata storicizzazione qui e ora può facilmente indurre alla capitolazione verso una visione ultra-deterministica della pratica artistica. Questa, cioè, dipenderebbe dallo “stato delle cose”, costituendo un suo effetto anche allorché lo contesta, tanto che la si direbbe quasi valida a patto che enunci la politica che la guida nel proprio relazionarsi alla realtà esterna. Spesso condotta al fine di denunciare una discriminazione o un’ingiustizia subita, la contestazione dei poteri dominanti difetta, talvolta con fierezza, di un progetto di trasformazione di ampio raggio sociale, come era stato invece il caso della lotta perseguita dalla classe operaia nel Diciannovesimo e Ventesimo secolo.

In quest’ottica, alla tanto biasimata presunzione di autonomia artistica promulgata nella modernità europea rischia di subentrare un’indiretta sudditanza nei riguardi del contenuto, che molto spesso riguarda tutto quanto appare attuale, collettivo e di potenziale interesse globale. Una volta prese le distanze dall’era dell’arte per come concepita nel Vecchio Continente, e una volta criticato il carattere feticistico di quadri e sculture, si può così passare all’incentivazione, anche involontaria, di un gusto sociologizzante, una fissazione per l’attualità e un’idolatria dei media che in un certo senso strutturerebbero quel che un artista ha da dire e ne garantirebbero il merito. Ma c’è di più. Si direbbe che un’amnesia paralizzante induca a negare il fatto che, in svariate civiltà, uno dei meriti delle opere d’arte visiva sia stato quello di non mostrarsi rivoluzionarie di default in virtù del loro radicamento a una supposta nozione di contemporaneità.
Una pratica artistica “ribelle”, al tempo stesso critica e compiacente del sistema dell’arte contemporanea, potrebbe addirittura scadere in una sorta di “comfort art” di facile fruizione, pronta a offrire un alibi di rispettabilità e correttezza politica a quanti si ritrovano comodamente d’accordo con il messaggio da essa portato. Che sia o meno disinvoltamente improntato sul marketing, il lavoro degli artisti si presta a offrire una varietà di espedienti utili a lavare via i sensi di colpa – colonialistici e non – di quanti temono che garantire il benessere dell’umanità in sé abbia un costo insostenibile. Ma come evitare le mistificazioni dei facili appelli all’alleanza tra culture? In che modo può un’opera d’arte contribuire a correggere le disunità del mondo?
(…) All the World’s Futures evidenzia come Enwezor, nel dedicare i suoi sforzi alla realizzazione di un’alternativa che potesse risultare sia artistica che esistenziale, a suo modo lasci uno spazio aperto all’idea di un’opera d’arte che inizia: con lui, un cominciamento si rivela un’intenzione inattuata ma nondimeno irrinunciabile. Si configura anzitutto come un evento la cui occorrenza – nel futuro, così come in una circostanza presente o passata a noi tuttora ignota – dovrebbe porre fine all’egemonia di un canone artistico occidentale, così come alla Babele conseguente al suo sfaldarsi, e andare di pari passo con la facoltà di rimediare ai danni causati dalla prevaricazione degli esseri umani sui propri simili e sulla natura.
A rifletterci, l’importanza del richiamo di Enwezor alla coscienza storica si deve non limitatamente al suo appello all’attualità quanto al tentativo di allontanare la pratica e la teoria artistiche da un dominio regolato da nozioni e convenzioni autoreferenziali incrementate in Occidente e di avvicinarla alla storia umana tout court. È questo significativo salto di scala che bisogna approfondire.
Nel 2012, quando definisce il lavoro della mano dell’artista “metafora” per l’umanità, egli non sta pensando alla manualità come expertise, apprezzabile in base ai codici e alle convenzioni del moderno paradigma delle arti o intesa in termini di controllo e sfruttamento di materiali e risorse esterne a noi. Più o meno deliberatamente, Enwezor istituisce un’analogia tra quel che un artista fa e il farsi e il disfarsi delle esistenze umane nella storia. Esattamente come nella creazione di un’opera d’arte viene a essere quel che prima non c’era, così nella vita di ciascuno quel che davvero conta è la possibilità di essere un inizio, di costituirsi quale espressione unica delle possibilità umane. Alla luce di quanto scritto da Enwezor, gli arazzi metallici di Anatsui sarebbero dunque opere “qualificate di valore”? Dimostrerebbero la multiscalarità dell’umano?
Ci si può infine avviare a chiarire perché le affermazioni del 2012 abbiano dato il via a questo capitolo. Nel rilanciare, seppure indirettamente, l’idea di un’arte che inizia, quelle parole sono interpretabili come il sintomo di un bisogno di umanesimo che riaffiora per rimanere incerto, se non oscurato, nella contraddittoria situazione mondiale di cui il sistema dell’arte contemporanea a sua volta risente. L’ipotesi è che, anche malgrado persista in essa un’eco di modelli di pensiero talvolta lontani dalla tradizione dell’umanesimo, la posizione di Enwezor condivida di quella tradizione la fede nell’importanza della consapevolezza storica, che non è mai acquisizione passiva, ma incentivo all’impegno civile, all’autodeterminata evoluzione della specie e alla trasformazione della realtà.
(…)
Si è quindi implicitamente invitati a consultare sé stessi in merito sia alla propria condotta di vita sia al fatto che viviamo in e con le nostre menti in modo diverso gli uni dagli altri, differiamo nel carattere e nel vissuto, da persona a persona e da momento a momento, eppure ciononostante siamo inclini a entrare in contatto: a rompere l’isolamento. Ma l’arte riesce a esprimere questa complessità e mutabilità? Anche quando non sembra offrire risposte dirette al riguardo, può supplire al bisogno di una realtà parallela o in parallasse non confermabile eppure in grado di supportare la presenza di un’agentività “umana”?
(…)
Appurata però questa inclinazione programmatica, la questione irrisolta è perché mai ciò vada colto unicamente in nuce, nel suo arrestarsi a uno stadio propositivo e mentale. Che difficoltà incontra l’attuarsi di un nuovo inizio per come esso si lascia intuire dalla posizione di Enwezor? Davvero il bisogno di affrancarsi da una visione lineare ed etnocentrica dello sviluppo storico-artistico comporta l’esaurirsi dell’era dell’arte così come intesa a partire dalla rinascita giottesca e la fine dell’idea stessa di un’opera d’arte che inizia?
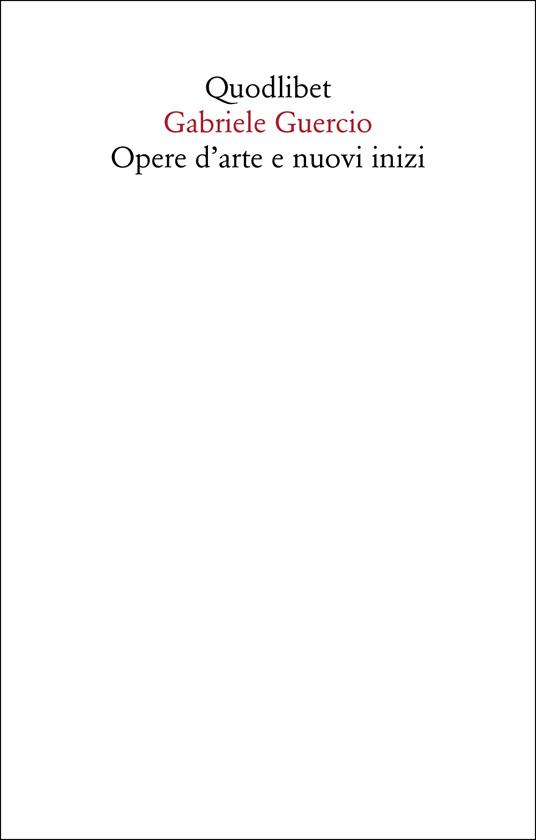
Ci si avvicina a delle risposte considerando l’espressione “metafora per l’umanità” da lui impiegata nei riguardi di Anatsui. In una suggestiva disamina della storia del termine, Ernesto Grassi ha sottolineato come la parola “metafora” rappresenti già una metafora, in quanto deriva dal verbo greco metapherein (“trasporre”): il linguaggio si avvale della capacità fantastica di divinare e/o conferire significati dando avvio a qualcosa di diverso dall’esistente. Non solo: come osservava Cicerone (De oratore, III, 155), una metafora riguarda qualcosa per cui manca un termine adeguato. Allude all’ignoto mediante ciò che è noto. Quindi è dell’umanità stessa che difettano le definizioni, e il lavoro della mano di un artista, lasciandosi percepire quale metafora, farebbe sì che due realtà all’apparenza distinte vengano riconosciute come una medesima in virtù di un elemento che segnala una proprietà fondamentale di entrambe. E, nel nostro caso, quell’elemento è un’affermazione dell’essere: il cominciamento ex nihilo talvolta riscontrabile sia nelle metamorfosi dell’umano sia nell’esperienza creativa di un artista. Ma che tipo di percezione, intelligenza emotiva e discorso critico è adeguato alla possibilità di cogliere questa ubiquità del medesimo, questa sinergia che ricompone assieme arte e vita pur rispettando la loro diversità dimensionale?
A rifletterci, il problema variamente concerne i casi incontrati fin qui. Ognuno presenta l’ex nihilo artistico come un evento non necessariamente interno a quanto avviene nelle cangianti sembianze materiali dell’arte soltanto: che la si percepisca immediatamente o retroattivamente, una svolta artistica può simboleggiare o plasmare attitudini, memorie, sentimenti e pensieri di cui precedentemente non c’era consapevolezza alcuna, né sul piano artistico né su quello antropologico – due piani che un nuovo inizio confonde ispirando a perseguire una sintesi, come l’esempio di Enwezor ulteriormente conferma.
Se si ammette, però, che le opere d’arte siano indirette dimostrazioni della facoltà umana di (ri)cominciare, allora un gesto estremo ma coerente sarebbe quello di provare a rovesciare la prospettiva attraverso cui comunemente le si osserva. Vale a dire, considerato che l’arte crea e veicola nuovi intendimenti dell’umano o rafforza una certa visione della plasticità della specie, è forse giunto il momento di porre in dubbio la convinzione che esistano linguaggi artistici determinabili ed esaminabili di per sé e/o in rapporto a qualsivoglia evoluzione o raggruppamento sistemico; altrimenti, servirebbe a ben poco avallare l’asserzione che il lavoro della mano di Anatsui è una metafora per l’umanità.
Nel comportare un’esistenza oltre la finitudine, il nuovo inizio che si intravede con Enwezor immagina l’umanità stessa come un infinito attuale, che si riconoscerebbe nella propria perennità vis-à-vis con l’esempio, le opere e le verità di individui e comunità che la disegnano. Così, mentre la pratica artistica diventa percepibile come generatrice di entità in cui la dimensione valutativa si intreccia con quella dell’agentività e delle intenzioni, l’enigma dell’origine si rinnova affinché a iniziare, a diventare “non” non essere nelle opere d’arte, siano principalmente valori antropocentrici quali quelli di giustizia, uguaglianza, libertà e rispetto della dignità umana. In questo processo, tenendo conto della complessità planetaria e senza negare la specificità dell’esperienza soggettiva e la diversità delle culture, si mostrerebbe l’intreccio di informazioni ed esistenza, mente e territorio, indigenia e cosmopolitismo, che costituisce la vicenda degli esseri umani. L’arte che inizia ha rappresentato, almeno idealmente, una testimone cruciale di questa ubiquità dell’umano. Ma ha tuttora modo di perseverare, ingrandire e rendere completamente trasparente tale capacità?
Oggi che la storia appare locale e insieme globale, direttamente coinvolta nello studio del farsi delle età geologiche, custodita e rinnovata tanto da persone reali quanto da dispositivi eterei e digitali, l’arte potrebbe cogliere l’opportunità senza precedenti di farsi carico dei significati dell’umano nella sua integralità. Contribuire all’autocomprensione in termini sia di individui che di specie, prospettando sì un’unità, ma de-globalizzata e senza centro.
È tuttavia evidente che, se quanto rilevato in questo capitolo va accolto come un desideratum, è perché almeno al momento difettano categorie o facoltà utili a cogliere tale realtà, a condividere un’esperienza o a raggiungere un tipo di conoscenza che efficacemente dimostri la non divisibilità tra le forme dell’arte e quelle della vita. La metafora rimane metafora, ma ci si può adoperare affinché non venga fraintesa la portata del messaggio che trasmette, affinché venga tramandato il bisogno di creare opere d’arte unite a nuove visioni dell’umano.





condividi